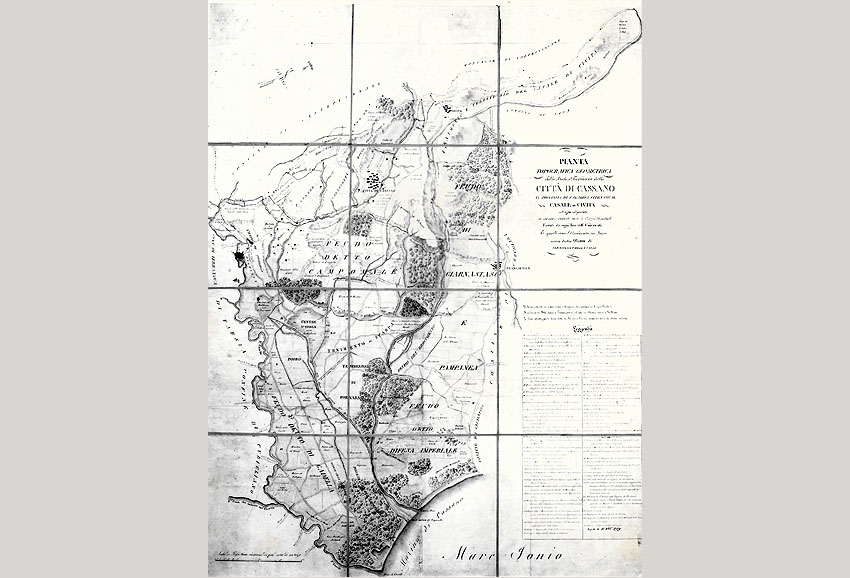LA LEGGEREZZA DELLA CULTURA
Se insomma, per chi vive più su dell’Appennino e del Po, l’Italia peninsulare appare spesso come un territorio omogeneo, senza grandi articolazioni interne, tuttavia la consapevolezza di una qualche differenza, anche linguistica, tra le due più note e popolose realtà del Mezzogiorno non può dirsi rara o poco comune.
Scomodiamo Calvino per parlare di una realtà particolare e forse unica, che della leggerezza fa il suo marchio di fabbrica.
Siamo andati in Calabria a stanare un gioiello di imprenditoria culturale,
un dono del Sud all’Italia, che parte da un piccolo centro nel 2004 per diventare oggi una realtà affermata a livello nazionale e oltre.
Coccole Books, casa editrice specializzata nella letteratura per l’infanzia, decolla da Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, con il mare davanti e la natura selvaggia del Pollino dietro. Nasce dalla passione di una coppia (nella vita prima, nel lavoro poi) che sceglie di lasciare le proprie professioni originarie (lui ispettore assicurativo, lei avvocato) per fare insieme qualcosa di nuovo e creativo. In un settore meraviglioso, complesso, avventuroso: quello dei libri per bambini e ragazzi, dagli albi illustrati per i più piccoli alle prime storie per le elementari fino ad entrare nel mondo dei romanzi per adolescenti.
Parliamo di leggerezza: all’inizio il loro progetto prende il nome irriverente di Edizioni Coccole e Caccole. Il nome poi si è trasformato, la casa editrice è cresciuta e si è allargato anche il target dei lettori. Ma lo spirito resta scanzonato.
Si parla di libri per bambini e ragazzi,
dove la seriosità (attenzione, non la serietà!) non deve mettere radici, perché delle cose importanti si può e si deve parlare in modo accessibile.
Dalle finestre degli uffici della casa editrice si vede il mare, anche se, impegnati come sono, loro non riescono spesso a goderselo. Il lavoro di Ilario e Daniela conosce pochi orari e poche pause, immune ai ritmi pigri di Belvedere Marittimo al di fuori della stagione balneare, quando invece si popola di turisti attratti sì dalle spiagge della Riviera dei Cedri, ma anche dall’indimenticabile tradizione gastronomica, e dai moltissimi itinerari di mare e di montagna, di natura e di storia.
Da questo sfondo ricchissimo prende le mosse il loro progetto: “Coccole Books è e vuole restare un editore indipendente, che vuole essere solidale a tematiche del territorio a cui appartiene e che vuole
raccontare con leggerezza e senza mai essere banale la verità anche ai ragazzi: integrazione, disabilità, mafie, scelta partigiana,
parità di genere, diritto al lavoro”.
La scelta dei titoli è curatissima, ogni libro e albo si inserisce in un progetto come tessere di un puzzle, che alla fine va a comporre l’identità della casa editrice.
Ci sono i grandi personaggi raccontati in modo spesso originale, diverso, come Martin Luther King, Papa Francesco, Tina Anselmi, Samantha Cristoforetti, rivoluzionari che parlano ai ragazzi e ai bambini di scelte coraggiose e controcorrente, dell’inseguire i propri sogni e fare la cosa giusta anche quando sembra la più difficile. Ci sono le storie piccole e quotidiane rivolte ai bambini delle scuole elementari, con al centro il loro mondo e la loro lingua. E i libri rivolti al target più complesso ed esigente di adolescenti e preadolescenti, per affrontare temi più o meno intimi, più o meno universali.
Un catalogo ricco e accuratamente selezionato, con uno scopo preciso:
“Pensiamo che fare libri per ragazzi possa rappresentare una concreta
azione politica in grado di produrre cambiamento”, spiegano i due editori:
“Una piccola rivoluzione, un segno per guardare in modo diverso le cose della vita, ma anche gli aspetti a volte complicati di un territorio”.
Un’identità tenace, quella legata al territorio, che si riflette anche nel modo di lavorare, moltiplicando le buone prassi come il rispetto dell’ambiente e del lavoro. Coccole Books stampa rigorosamente in Italia e su carta riciclata, perché non sono solo le storie a fare la differenza, ma anche i professionisti che ci sono dietro, e le loro scelte, nella filiera del libro per ragazzi che è un settore diverso da quello del libro tout court.
Ma per Ilario e Daniela essere editori non si consuma solo nel lavoro di selezione, produzione e promozione dei titoli. Da due anni lavorano a stretto contatto con le scuole con le Olimpiadi del Libro, che per l’edizione 2019 hanno coinvolto 13 scuole e 130 classi: circa 2500 ragazzi. E per il 2020 si replica, con già 18 istituti iscritti. Le Olimpiadi portano i libri nelle scuole attraverso il gioco, la scoperta e un po’ di sana competizione. Ogni classe sceglie un libro dal catalogo, gli alunni lo leggono e a fine progetto lo rappresentano, come spettacolo, cartelloni, canzone, progetti grafici, e nel giorno finale delle Olimpiadi la classe incontra anche l’autore scelto.
Un contesto territoriale che resta il fulcro della loro attività, portando il meglio
della Calabria nel mondo e il meglio del mondo in Calabria
“Nascendo in Calabria e scegliendo di restare in questa terra, la nostra prima esigenza è stata quella di emanciparci da un contesto provinciale e proiettarci da subito in una dimensione nazionale, sia nella scelta di testi e autori che dei destinatari delle nostre pubblicazioni. Avevamo ed abbiamo ancora la necessità di raccontare quello che siamo ma anche quello che vogliamo essere e diventare”.