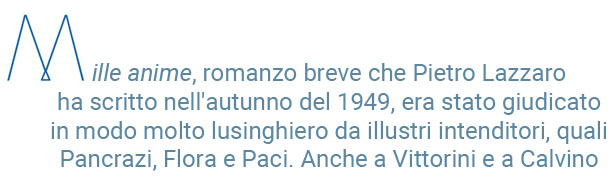MORREMO TUTTI QUI

erano piaciute le deformazioni espressioniste e grottesche della narrazione, ma ciò non era bastato per accordarle, infine, dignità di stampa, in quanto «la cornice di storia paesana [soffocava] − a detta di Calvino − l’interesse delle pagine più vive».[1] Questo difetto e altri convinsero Lazzaro, traduttore e poco conosciuto scrittore, nato nel 1912 in un più che sperduto paesino calabrese, a lasciare il manoscritto in un cassetto, fino a quando non venne pubblicato postumo, nel 1987, a diciotto anni dalla morte del suo autore. Pur tuttavia, a distanza di altri tre decenni, appaiono ancora evidenti quelle virtù intraviste dai lettori di allora.[2]
Al centro della vicenda c’è la vita − tanto miserabile quanto grottesca, nella descrizione che ne fa lo stesso Lazzaro − di un indefinito villaggio del meridione d’Italia, avvinto in un mortale silenzio, i cui mille abitanti
vengono sterminati da una misteriosa e fulminea epidemia.
È servendosi delle armi dell’ironia e dell’allucinazione che lo scrittore di Motta Filocastro[3] quasi arriva a suggerire come le cause del tragico evento vadano fatte risalire all’attitudine di quegli uomini per superstizione e fatalità o, più sinteticamente, a una bestemmia o, meglio ancora, a una specie di eccesso di immaginazione. Non può essere considerata trascurabile la portata di un espediente di ordine creativo in grado di legare così finemente l’oscurità della miseria alla luminosità della fantasia.
E, d’altronde, neanche un’evasione di massa salverebbe il villaggio di
Mille anime dalle persecuzioni dei santi o dall’attesa senza fine dei loro miracoli. Né, tutto sommato, risolverà alcunché
la scomparsa dei suoi abitanti:
bisognerebbe, piuttosto, ristabilire il corso del tempo, ricollocarsi nel ritmo della vita, oppure − secondo Michele, amico e maestro del protagonista − «mutare il corso del sole e delle stelle, la direzione dei venti, l’animo degli uomini»;[4] purtroppo, non si può. Tale consapevolezza provoca uno sgomento diffuso che, progressivamente, finisce in una inesorabile brama di morte, di autodistruzione, quasi di ritorno a uno stato inorganico.
Lazzaro racconta di una esistenza inerte, resa ancor più opprimente dall’immobilismo fascista (cui più volte si riferisce, neanche troppo sommessamente, lo scrittore)[5] e popolata da corpi senza vita,
oltre che da fantasmi.
Sogni, ombre e magàrie incombono sul villaggio, di volta in volta percepito come «un terribile e gigantesco ragno con volto umano che urla spesso di dolore»,[6] come un «carcere della miseria»,[7] «un morto lago da cui emergono grigi fantasmi senza epoca»,[8] spesso colto in «un’immobile e vitrea luce lunare, e, lontano, il mare come un gran lago di mercurio chiuso dalle ombre azzurre delle isole e dominato da Mahammetta»,[9] che non è che uno di quei fantasmi.
Eppure, si tratta di fantasmi − la Vergine di Romania, San Nicola di Bari, San Rocco di Mileto, San Giuseppe il Corto, San Giuseppe il Lungo e molti altri − le cui proprietà e azioni sembrano essere sottomesse alle medesime leggi del mondo visibile e che non posseggono, dunque, uno statuto soprannaturale. Sarà per questo che da essi non si genera alcuna azione, né essi costituiscono un motivo di evasione in un mondo misterioso all’interno del quale la ragione non possa penetrare. Un quadro così interamente improntato sulla reificazione collettiva dell’immaginario presuppone, sul versante opposto, un’idea di letteratura che, ironicamente, si ponga come osservazione razionale difficile da mettere nel sacco, ma che, tuttavia, allo stesso modo del quadro che delinea, è incline a quell’amarezza che erompe tanto dalla scrittura quanto dalla miseria.
Certo è che laddove, da un lato, troviamo la disperazione del villaggio, quell’«irreparabile merdaio»,[10] con le ottusità e l’apatia che pervadono chi vi abita, dall’altro, c’è l’enorme spettro dell’immaginazione,
dal quale l’autore di Mille anime recupera la materia − fatta di memorie, miti e superstizioni − diffusa tra il popolo, con l’intento di normalizzarla, il più delle volte mediante l’ironia. Esemplare, nel realismo fantastico che riesce a prefigurare, quella di un contadino che, entrato in chiesa a ora insolita, parla in questi termini ai suoi fantasmi:
O Vergine di Romania, se non sei una svergognata, mandaci la pioggia. O San Nicola di Bari, se non sei più cornuto delle tue vacche,
mandaci una goccia d’acqua.[11]
In nessuna occasione, tale processo di normalizzazione, è bene precisarlo, sfocia in una considerazione votata all’indulgenza; anela, invece, alla rottura del cerchio, a mostrare che quanto meno sia possibile porsi contemporaneamente nel tempo e fuori di esso. Possibilità che sembrerebbe essere negata dal finale del romanzo (e anche dall’inesorabile frase di Michele che ho scelto come titolo per questa nota), ma che forse risulta, anche solo per un istante, avvalorata dall’idea dalla quale la narrazione è generata e dalla struttura d’insieme acutamente canzonatoria per la quale Lazzaro propende e che neanche Calvino aveva compreso sino in fondo.
[1] Lo rivela lo stesso Lazzaro in una nota del 1968, pubblicata poi in appendice a P. Lazzaro, La stagione del basilisco [1968], Milano, Jaca Book, 2003, pp. 139-142; nella nota è inclusa una lettera di Calvino, datata 17 maggio 1957, dalla quale è desumibile il parere di lettura cui si fa rifermento (p. 142). [2] Delle mille anime di Motta Filocastro, da una prospettiva antropologica, si parla anche in V. Teti, Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati, Roma, Donzelli, 2004, pp. 361-370. [3] Si tratta di una frazione di Limbadi, paese di poco più di tremila abitanti, oggi in provincia di Vibo Valentia, situato tra Tropea e Rosarno. Dall’alto del centro abitato, sede di confino politico negli anni del fascismo, si vede tutta la piana di Gioia Tauro e il porto. Sul muro di una casa abbandonata di Mandaradoni, altra frazione di Limbadi, sta lentamente sbiadendo un dipinto che ritrae la faccia del duce (e che era accompagnata dalla seguente didascalia: « Solo Iddio può piegare la volontà fascista, gli uomini e le cose mai»). Sono state scattate nel 2017 da Annalisa Lentini le foto che ritraggono il Mussolini di Mandaradoni e uno scorcio di Limbadi.[4] P. Lazzaro, Mille anime, Milano, Jaca Book, 1987, p. 45. Anche il titolo di questo intervento è parte del concetto espresso qui da Michele. [5] Il riferimento, si intende, è sempre condotto in chiave ironica, come, ad esempio, nella frase che si trascrive: «Gridarono alalà quasi tutti, sconcertati dal tono di lui e dal mistero che quella incognita parola introduceva nel nostro Villaggio. […] E qualche caposcarico andava recitando la seguente banale filastrocca: Alalà, Alalà / tua sorella l’ha fatta o la farà?» (ivi, p. 87). [6] Ivi, pp. 24-25. [7] Ivi, p. 45. [8] Ivi, p. 46. [9] Ivi, p. 72. [10] Ivi, p. 9. [11] Ivi, p. 15.