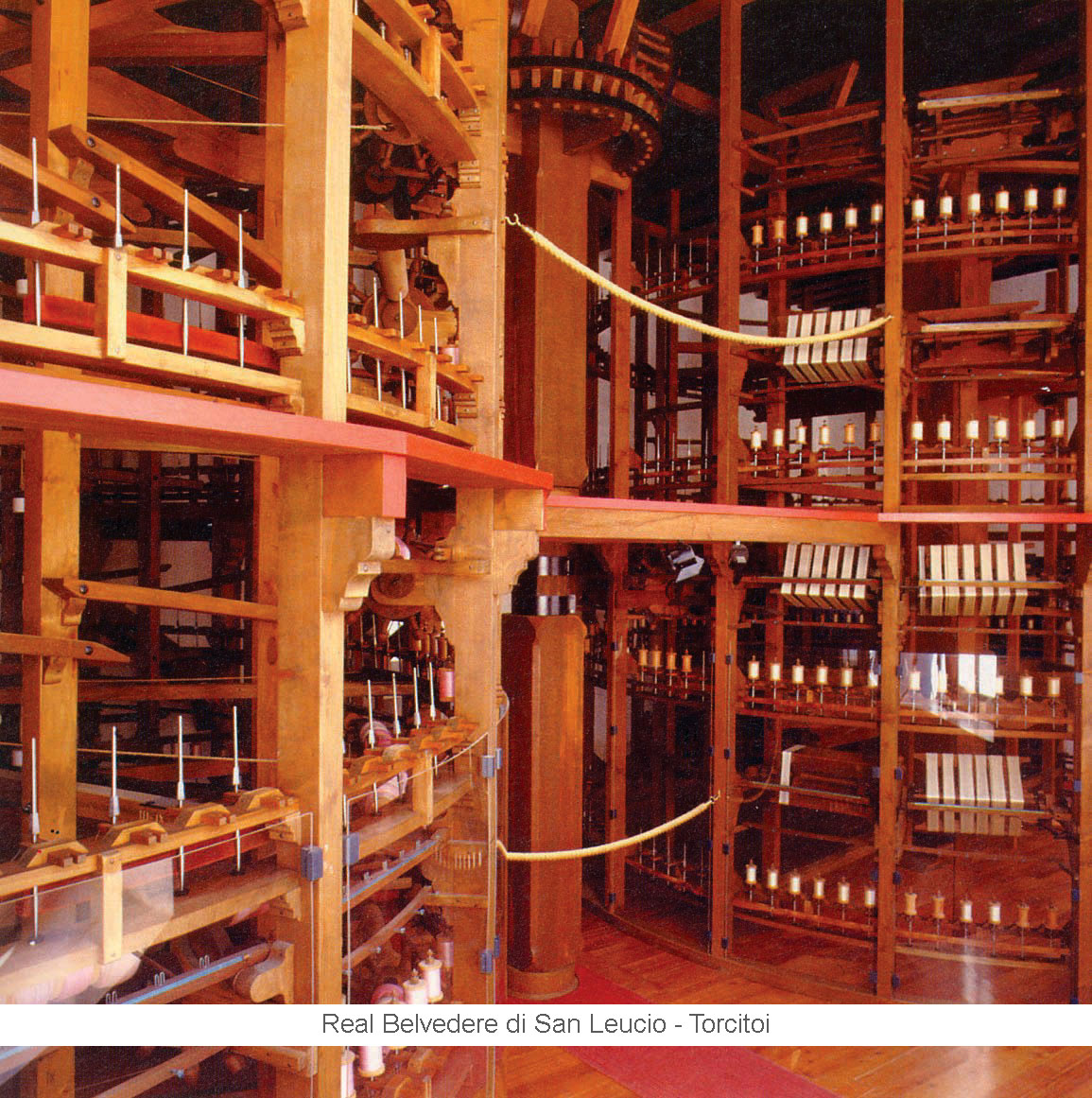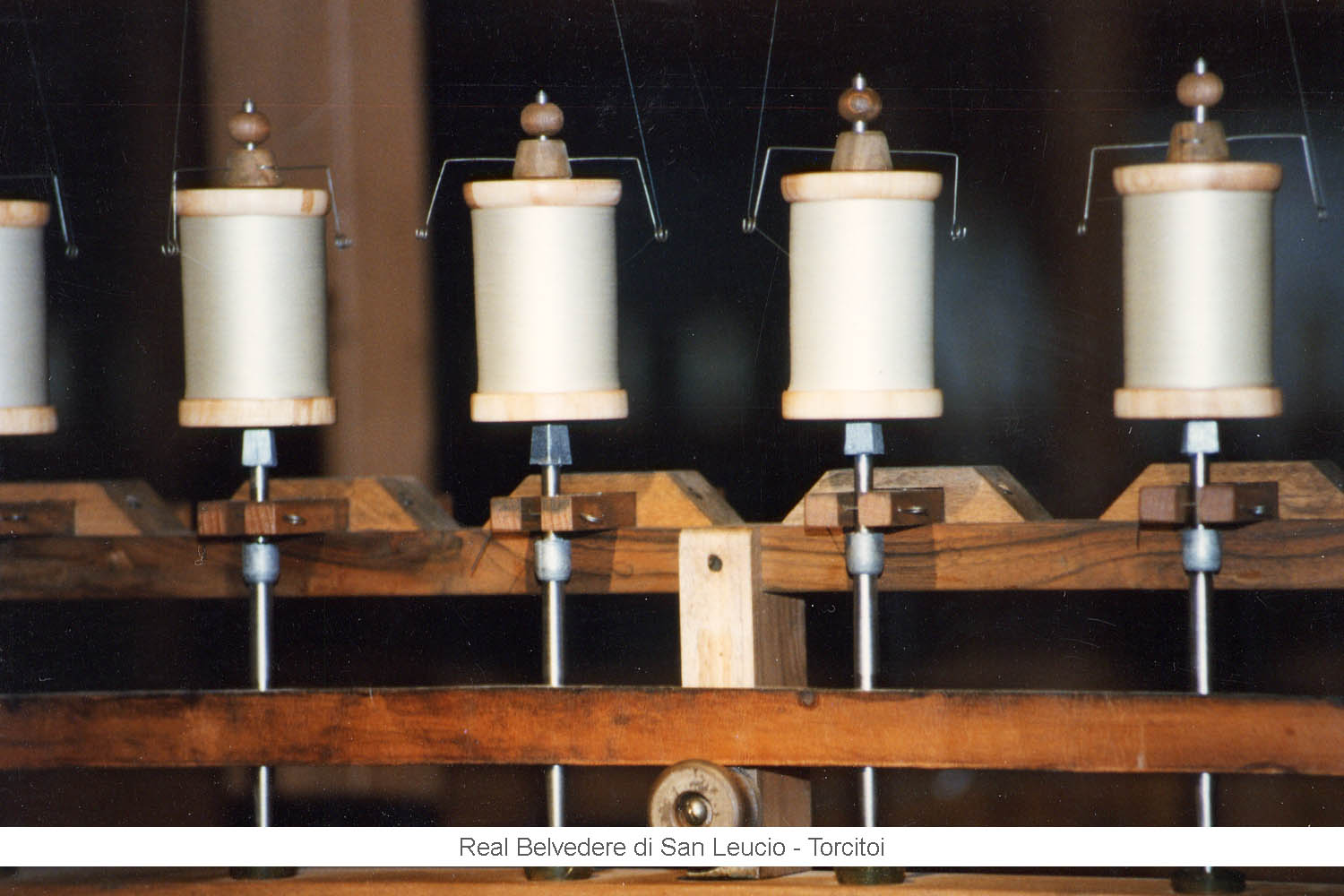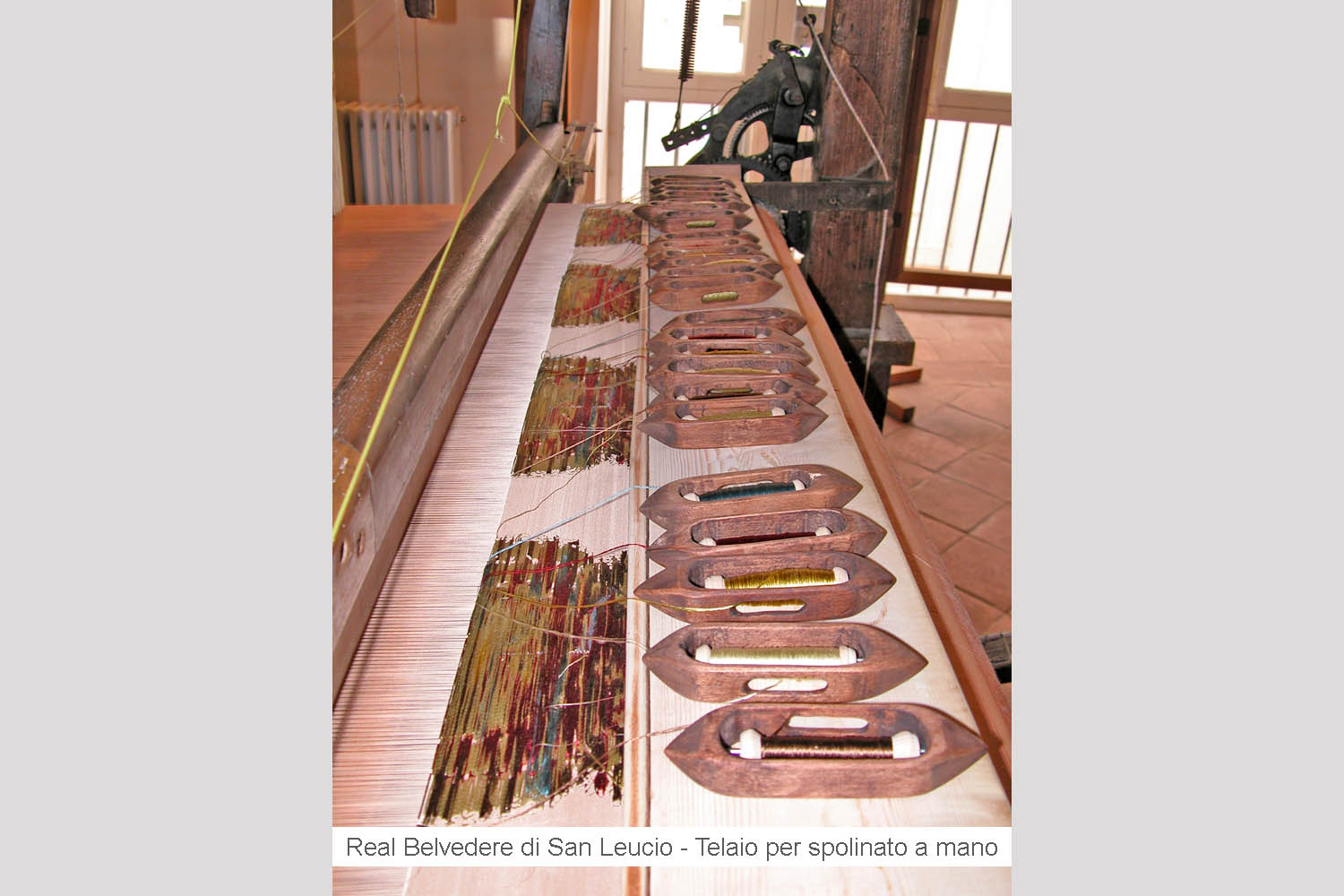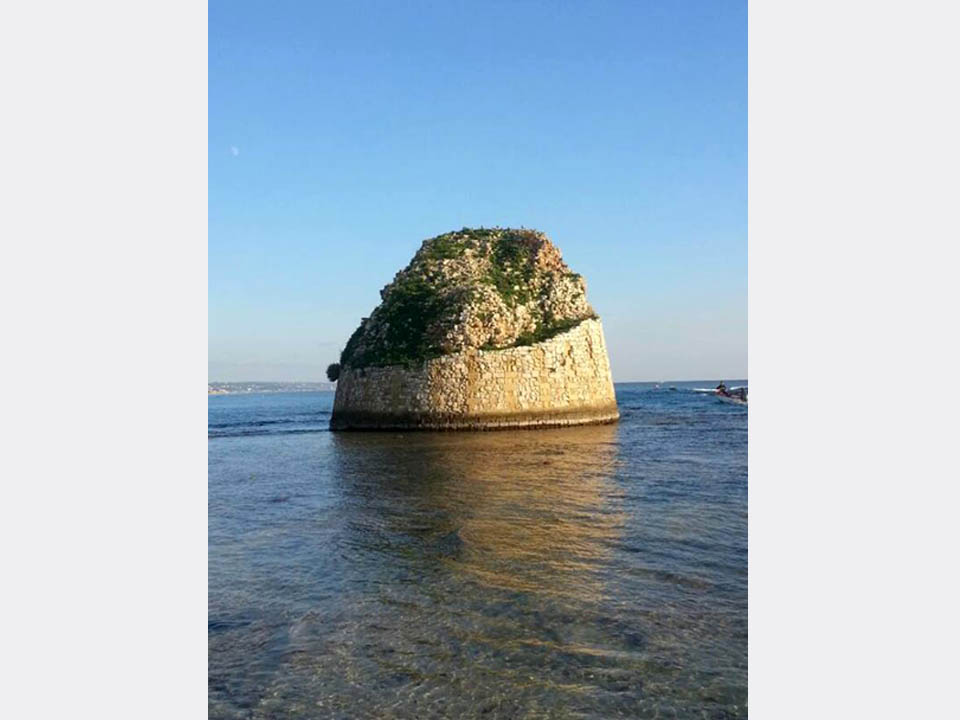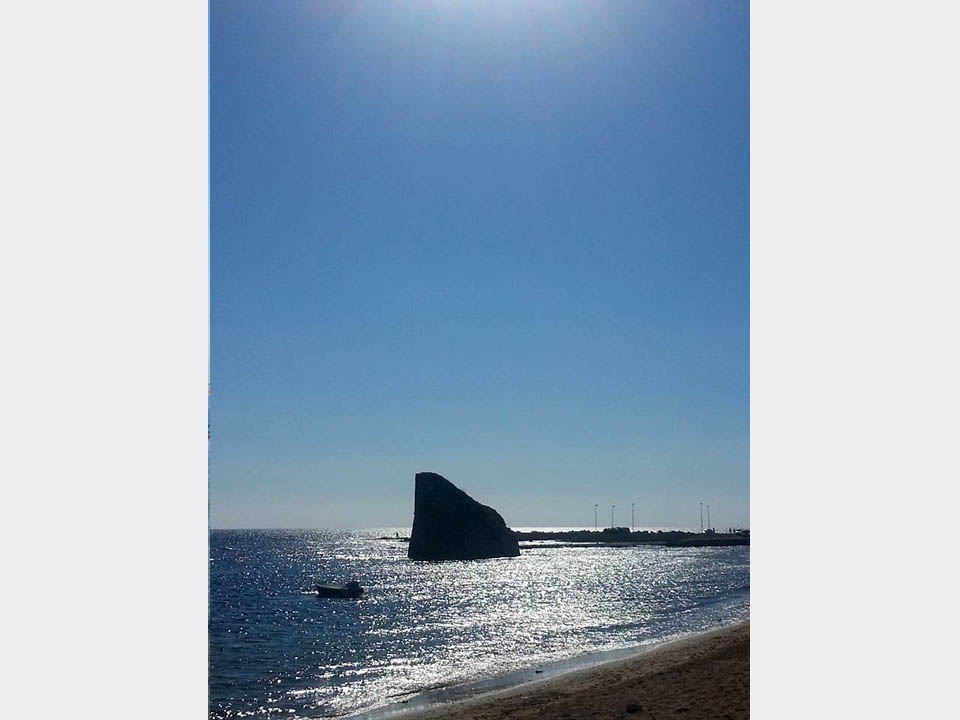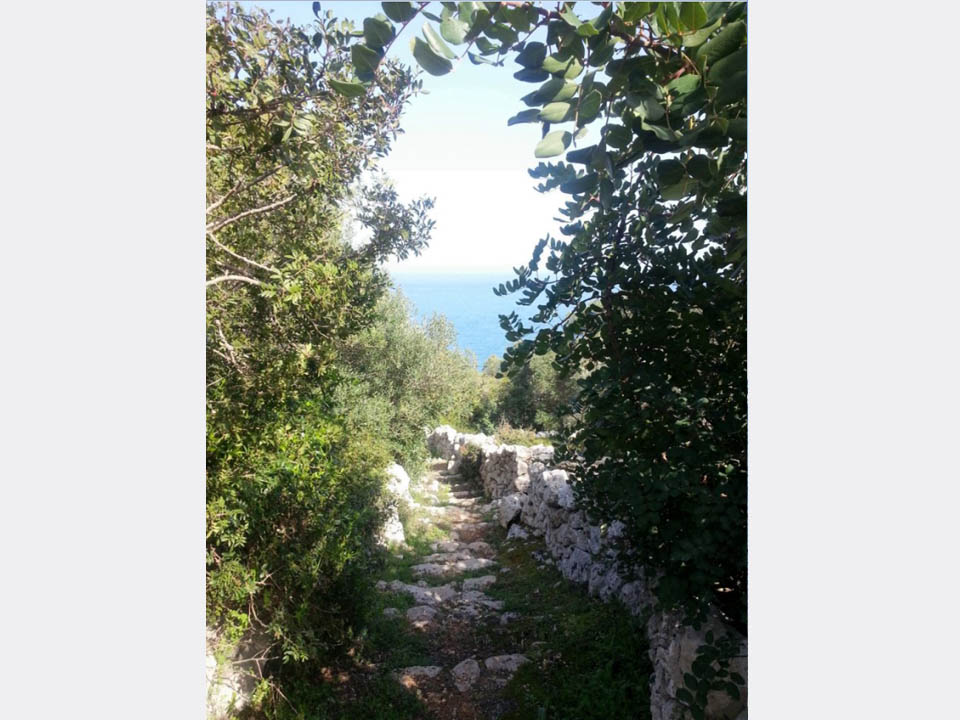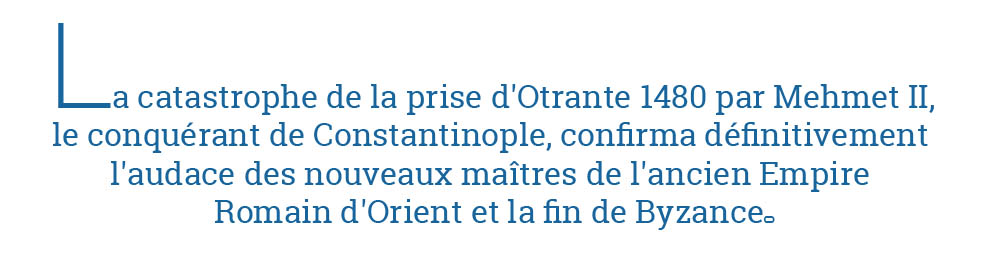JOE PETROSINO
operai, agricoltori, sarti, meccanici, ma anche avvocati e medici, e artisti di ogni genere. Soprattutto, gente povera che cercava fortuna oltreoceano.

Fra loro, purtroppo anche criminali, che a New York e in altre grandi città americane fondarono un’organizzazione di stampo mafioso chiamata la Mano Nera. Praticava sistematicamente l’estorsione all’interno delle stesse comunità italiane, con ramificazioni anche in Sicilia. Sin dai primi del Novecento le sue lettere, contenenti anche minacce di morte, erano firmate con due spade incrociate sotto a una mano nera.
L’organizzazione aveva ovviamente legami con la mafia italiana, ma anche
con la ‘ndrangheta calabrese e americana, con la camorra napoletana.
Ma al tempo stesso intratteneva legami stretti con la Tammany Hall, potente macchina politica dei democratici di New York, che aveva in mano tutte le leve del potere (dal municipio alla polizia) e era disposta a tutto pur di continuare ad ottenere voti ed esercitare un controllo politico sulla città.
In questo clima malavitoso si trovò a vivere e lavorare Joe Petrosino,
originario di Padula (Salerno) che, nel 1873 s’imbarcò giovanissimo con il padre Prospero, di professione sarto, la madre e i suoi due fratelli, con destinazione New York. Andarono a vivere a Little Italy, dove ben presto Joe, per aiutare la famiglia, si diede da fare con vari lavoretti, in particolare “strillone” di strada e lustrascarpe. Nel 1877 ottenne la cittadinanza statunitense e, pur sognando di diventare un poliziotto, iniziò a lavorare come spazzino comunale (allora i netturbini erano alla dipendenza del Dipartimento di Polizia). Era talmente in gamba che dopo un anno era già diventato capo squadra. Strinse amicizia con molti i poliziotti e col tempo divenne un prezioso informatore. Nel 1883, avendo contribuito proprio lui a sventare un colpo della Mano Nera, fu finalmente ammesso nella polizia – con distintivo n. 285.
Di statura piccoletto (circa un metro e sessanta) in mezzo ai “giganti” irlandesi – maggioritari nella Polizia newyorkese – non gli difettavano temperamento e scrupolosità, così come intelligenza e grinta. Oltretutto parlava perfettamente sia l’inglese che l’italiano. Presto si seppe che “non faceva passare nulla sotto gamba”: quando era di servizio a Little Italy, per le strade girava il passaparola sul pattugliamento di Petrosino…
Il suo lavoro preciso e rigoroso fu notato da Theodore Roosevelt, allora assessore
alla polizia, (nel 1901 diventerà poi presidente degli Stati Uniti), che appoggiò Petrosino e nel 1895 lo fece promuovere sergente, destinandolo alla conduzione
delle indagini. I gangster di Little Italy si trovavano ora di fronte a un profondo conoscitore della loro stessa lingua e dei loro metodi.
Al di là della diligenza nel lavoro, Petrosino provava comunque un rancore molto forte per i criminali che distruggevano il capitale di apprezzamento e rispetto che gli italiani avevano costruito così faticosamente. In quegli anni effettuò centinaia di arresti, sventò attentati e sganciò i commercianti dalla morsa delle estorsioni. Petrosino era perspicace, deciso, veloce e irremovibile, a volte anche rude con i criminali. In poco tempo era diventato il simbolo della battaglia alla criminalità, un mito del suo tempo. Le sue tecniche di lavoro erano assolutamente innovative: travestimenti, imboscate, assalti, disinnesco di ordigni. Nel frattempo Joe si sposò con Adelina Saulino, dalla quale ebbe una bambina, chiamata Adelina come la mamma.
Nel 1905 divenne tenente e fu incaricato dell’organizzazione
di una squadra di poliziotti italiani,
l’Italian Branch (poi chiamata Italian Squad), composta da 5 agenti tra cui il successore di Petrosino, Michael Fiaschetti (nativo di Morolo, Frosinone), uno sviluppo questo che diede forte impulso alla lotta alla Mano Nera.
Le minacce a scopo di estorsione arrivarono addirittura al grande tenore Enrico Caruso, che non cedette al ricatto e si affidò proprio a Petrosino, il quale riuscì a far arrestare due dei tre delinquenti e, grazie alle indagini, qualche anno dopo anche due importanti capi della mafia newyorkese
La lotta di Petrosino contro la Mano Nera ebbe u ulteriore salto di qualità nel 1906, quando Theodore Alfred Bingham divenne il capo
del dipartimento di polizia di New York.
Bingham potenziò l’Italian Squad e le affiancò un’altra squadra di Brooklyn. Petrosino e Bingham dichiararono guerra alla Tammany Hall con un’incisiva azione repressiva che prese ai fianchi le due basi di controllo: l’egemonia sulla polizia newyorkese e la complicità dei malviventi italiani, soprattutto della mafia siciliana. A questo punto, Petrosino e Bingham divennero obiettivi cruciali.
L’attentato a Petrosino fu costruito “a ragnatela”, con infiltrazioni ovunque, mentre seguiva una pista che lo avrebbe portato in Italia, per infliggere un grave colpo alla Mano Nera. L’operazione doveva essere ovviamente segreta, ma i criminali contavano sulla complicità di persone influenti, capaci di ottenere informazioni certe sulla missione di Petrosino. Persone potenti strettamente collegate con la Tammany.
La mattina del 9 febbraio 1909 Petrosino si imbarcò – apparentemente
in gran segreto – dal porto di New York a bordo del piroscafo Duca di Genova.
Ma nello stesso momento il New York Herald già usciva col titolo:
“Petrosino in viaggio per Napoli e poi per Palermo per andare
a debellare la Mano Nera e la Mafia”.
Addirittura, arrivato a Napoli, trovò una sorta di comitato di accoglienza fatto da giornalisti e poliziotti. La notizia del suo arrivo era arrivata anche a Palermo, ma Petrosino, pur consapevole dei pericoli, confidava che la criminalità non avesse il coraggio di eliminare un poliziotto.
La sera del venerdì 12 marzo 1909, proprio a Palermo due sconosciuti gli chiesero di parlare fuori dall’albergo. A piazza della Marina, alle 20.45 tre colpi di pistola lo colpirono in rapida successione e un quarto subito dopo alla testa.
Il console statunitense a Palermo telegrafò al suo governo:
“Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera.
Gli assassini sconosciuti. Muore un martire”.
Si tennero due funerali, uno in Italia e uno a New York, dove parteciparono circa 250.000 persone, un numero mai raggiunto fino ad allora per delle esequie.
Il feretro fu accompagnato da Theodore Roosevelt,
ormai Presidente degli Stati Uniti.
Gli indagati furono tutti prosciolti, anche perché la polizia statunitense, la cui collaborazione era stata più volte richiesta dalla procura di Palermo, rispose con un’indifferenza ai limiti del boicottaggio. È possibile che la Tammany Hall, con i suoi agganci importanti nella magistratura, volesse depistare le indagini; di certo essa aveva avuto la sua parte prima nel lasciar trapelare il viaggio di Petrosino, poi nell’evitare che notizie compromettenti giungessero agli inquirenti palermitani.
Solo nel 2014, nell’ambito di una intercettazione al gangster Domenico Palazzolo, gli investigatori vennero a conoscenza del ruolo di suo zio paterno, Paolo Palazzolo – già prosciolto per l’omicidio di Petrosino: “Ha fatto lui l’omicidio del primo poliziotto ucciso a Palermo. Lo ha ammazzato lui Joe Petrosino, per conto di Cascio Ferro” (boss mafioso italiano legato alla Mano Nera). Chi e cosa ci fosse dietro a questi due personaggi non è mai stato definitivamente chiarito.
Di certo idealmente, circa vent’anni dopo, Joe Petrosino fu vendicato da Fiorello La Guardia, altro grande, straordinario italiano d’America,
sindaco di New York, sotto il cui impulso venne affibbiato un duro colpo alla malavita e alla Tammany Hall.

Photo: New York City Police Department, Public domain, via Wikimedia Commons