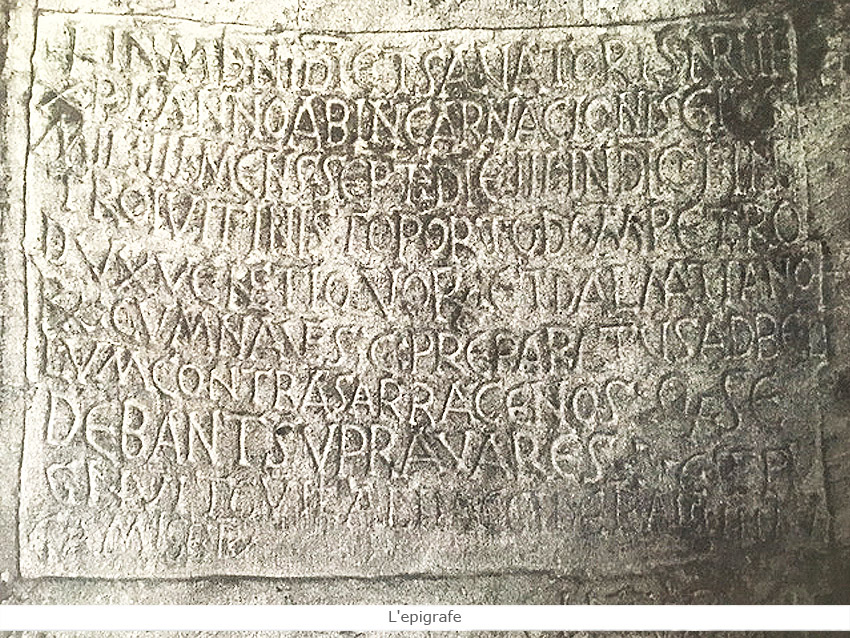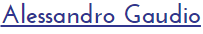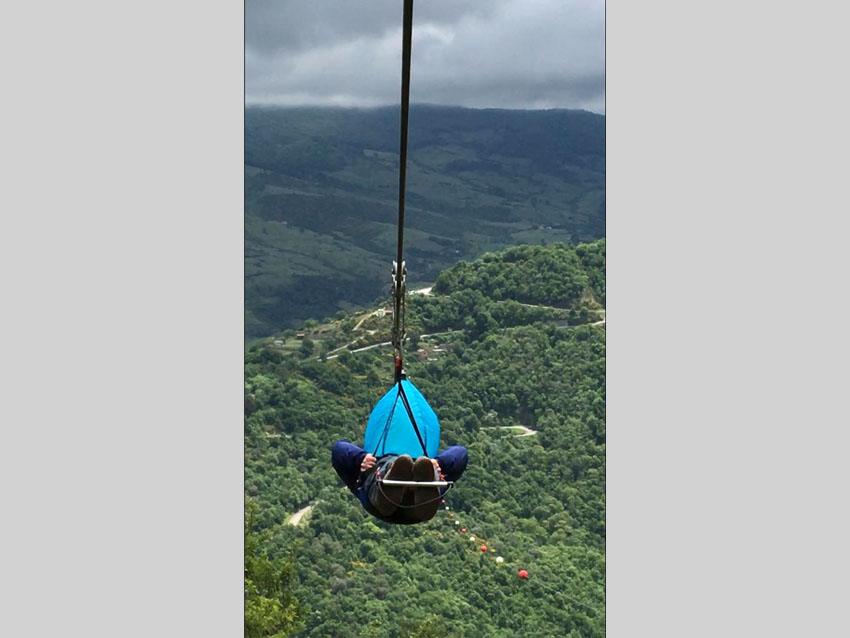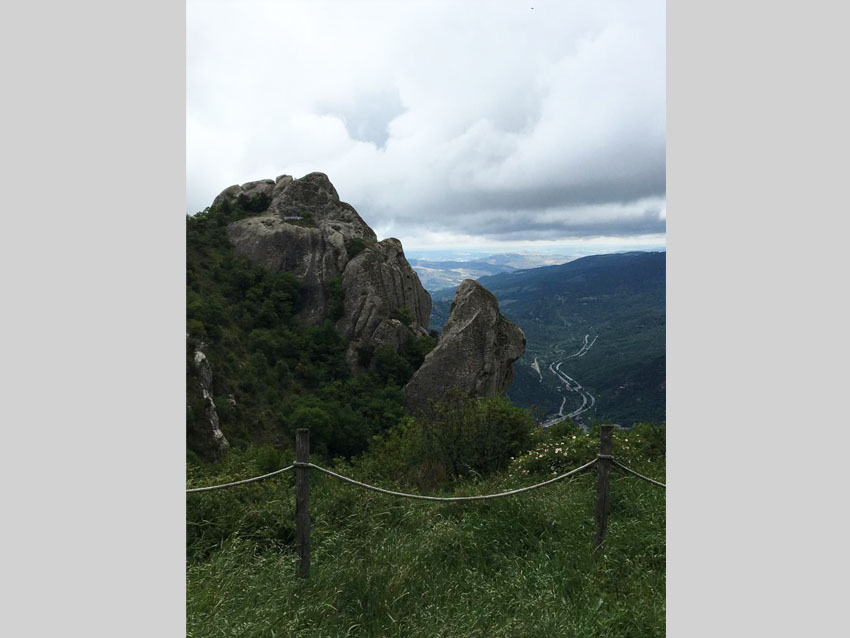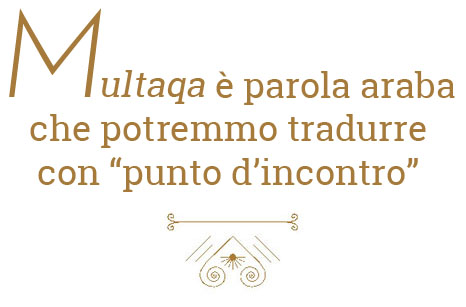1. Rionero città di frontiera. In che senso? Aveva ragione il compianto Nino Calice quando affermava che Rionero in Vulture, oggi importante centro dell’articolazione urbana della Basilicata, è stato (lo è ancora?) un paese di frontiera, nel senso di un luogo urbano senza conti da regolare con centri sociali e di potere preesistenti, feudali o clericali, spregiudicata, diversamente da Melfi, dove la presenza plurisecolare di vescovi e feudatari aveva dato luogo ad una società verticale, gerarchica e perciò timida, portata alla dipendenza1. Dopo la secessione dal Vescovo di Rapolla, fatta per ragioni fiscali dal 1314 al 1330, passando sotto la circoscrizione di Atella (e già questo dice del carattere della città), accogliendo nuove genti di ogni tipo, dagli albanesi di Scutari alle maestranze di ogni genere e provenienza (irpina, sannitica o pugliese: un melting pot unico in quella Basilicata moderna) in occasione dei tagli al bosco del Gualdo o alle pendici del Vulture, di commerci vari,
“Rionegro” divenne un paese aperto e mobile, passando dagli originari 500 ai 9000 abitanti nel secolo dei lumi, capace di sfuggire, per la sua connaturata diffidenza
e inquietudine, anche all’opera missionaria di un S. Alfonso dei Liguori.
Ne venne fuori una realtà urbana viva ma anche aspra, “senza esclusione di colpi, di intrighi, di malandrinerie, di calunnie, di bugie, di vendette”, in cui ogni volta “bisogna ricominciare daccapo”, ricucendo gli strappi “dei costumi, delle feste, delle classi, delle case, dei quartieri, delle piazze”2.
2. La Famiglia Fortunato e don Giustino a Rionero.
Secondo la ricostruzione di Calice, neppure i Fortunato sfuggirono a questa realtà conflittuale, nonostante le apparenze ieratiche delle due ultime figure rappresentative di questa importante famiglia del nostro Sud e della nostra storia nazionale: Ernesto e Giustino. Nel capitolo intitolato Dove è finito il barone Rotondo? Calice racconta di una vicenda di ordinaria turbativa degli incanti. Nel 1837, la Mensa vescovile di Melfi mette in vendita i diritti di enfiteusi sui beni della tenuta di Gaudianello, in agro di Lavello (città che con Venosa, assieme alle due già menzionate, completa il quadrilatero dei grandi centri della Basilicata settentrionale), estesi ben 3900 tomoli (terre a bosco e pascolo), quelli che diverranno dal 1872 il cuore dell’azienda modello cerealicolo-pastorale organizzata e diretta da Ernesto Fortunato3.
Alla gara i Fortunato offrirono 2400 ducati e i Rotondo 2600 ducati (i Tedesco di Minervino non erano competitivi) ma la tenuta venne aggiudicata ai Fortunato, con lo stratagemma dell’elevazione posteriore dell’offerta, passata da 2400 a 2800 ducati, non senza che una tale opportunità (non del tutto trasparente) fosse divenuta possibile grazie a qualche intervento extra ordinem: un favore del vescovo di Melfi ad Anselmo Fortunato (allora, a Napoli, Presidente della Corte dei conti) o la promessa di non riscattare il canone enfiteutico4. E la promessa venne persino imposta agli eredi da don Giustino con il suo testamento5. Sta di fatto che,
vincendo quella gara, i Fortunato innescarono il volano dello sviluppo della loro potenza economica, quella stessa (intelligentemente e progressivamente amministrata da Ernesto: la guida imprenditoriale della famiglia)
che consentì di garantire al più noto fratello Giustino di recitare
un ruolo di grande importanza nella politica
e nella vita civile nazionale.
Ci sarà poi da stupirsi tanto se, dopotutto, sui Fortunato, nel 1861, verranno riversate accuse di protezione verso i briganti e se gli accusati sdegnosamente abbandoneranno Rionero per trasferirsi a Napoli? Quello, Rionero, era pur sempre un Paese di frontiera, di lotte politico-sociali aspre, “senza esclusione di colpi, di intrighi, di malandrinerie, di calunnie, di bugie, di vendette”, in cui ogni volta “bisogna ricominciare daccapo”.
Il Palazzo Fortunato, perciò, resterà vuoto fino al 1878 quando avvenne la ricucitura tra la Città e il suo più illustre notabilato, con il sindaco (Pierro)
che va incontro ai due fratelli fuori dal paese e va a riverire
il candidato al Parlamento nazionale.
Ernesto, perciò, poté tornare a Gaudiano, a gestire l’azienda più avanzata dell’intera Basilicata (e fra le più avanzate dell’intero Mezzogiorno), mentre Giustino da parlamentare vivrà tra Napoli (la residenza di via Vittoria Colonna) e Roma, con brevi rientri estivi a Rionero e Gaudiano. Ci sarà da stupirsi ancora se nel 1917, passeggiando a Rionero con alcuni degli amici più fedeli, don Giustino verrà ferito da un esaltato che l’aveva accusato di essere responsabile, addirittura, della guerra? Ma stavolta Fortunato non tornerà più a Rionero, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 23 luglio 1932. Purtroppo, occorrerà solo quella per conseguire finalmente il desiderio “di vivere nella gratitudine vostra, miei concittadini”6?
3. Rionero si è veramente riappacificata con Giustino Fortunato?
A Rionero, sulla piazza principale c’è il Palazzo Fortunato, composto dal fabbricato di circa cinquanta stanze, da un giardino e da un cortile, per una superficie di circa 4000 metri quadri: un importante monumento architettonico che vide passare, ospiti della famiglia, personaggi storici di rilievo: Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti.
Oggi il Palazzo ospita la Fondazione Fortunato e la Biblioteca di famiglia, forte di circa 11.000 volumi, tra cui molte cinquecentine e libri dal Seicento all’Ottocento; nelle scuderie, un Museo della Civiltà Contadina e l’archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero nonché, quasi un paradosso,
anche una mostra permanente sul Brigantaggio.
La città sembra essere definitivamente riconciliata con il suo più importante personaggio, il grande intellettuale e meridionalista che gli ha dato prestigio e fama.
Ma le iniziative della comunità locale non si può dire che siano del tutto all’altezza del grande concittadino e della sua storia, basti vedere anche semplicemente il sito internet che dovrebbe orientare il visitatore ed il curioso, per non dire lo studioso del pensiero e dell’organizzazione familiare.
Ma forse sarebbe anche il caso di pensare ad un Parco Letterario Giustino Fortunato, per far conoscere i luoghi della sua vita
(perlomeno di quella non vissuta a Napoli): un’iniziativa – possibile anche solo in sede locale, sebbene non riferita strettamente ad uno scrittore o un poeta, ma a uno storico, a un politico e politologo di razza, a uno statista come pochi – che farebbe svanire del tutto il dubbio circa il fatto che la sua città natale abbia mantenuto ancora qualche ombra sull’intellettuale nazionale di cui può invece trarre incondizionato vanto.
Sembra allora che la città si sia fatta perdonare per quegli screzi sol perché un altro intellettuale e politico rionerese, Nino Calice, ha dedicato ai Fortunato alcune opere importanti della sua complessiva produzione storica e politologica.
Non solo. La casa editrice da Lui fondata ha anche stampato alcune opere di don Giustino e, tuttora, dopo la morte del fondatore, mostra di proseguire la sua preziosa attività
4. Un erede rionerese per don Giustino: Nino Calice.
La verità è che Nino Calice (1937-1997), professore di storia e di filosofia nei licei, ma poi anche consigliere regionale (eletto con il PCI), Sindaco del Comune di Rionero, deputato al Parlamento e poi Senatore della Repubblica, componente del Consiglio d’Europa, fondatore del centro studi Giustino Fortunato, storico, e protagonista di tante iniziative culturali e politiche, oltre che di importanti ricerche storiche anche sulla vita della Basilicata, è indubbiamente – si proprio Lui – il vero erede di don Giustino e non solo per le ragioni legate alla comune origine cittadina.
Il ponte di passaggio tra le due figure mi pare ascrivibile alla grande tradizione democratico-liberale nazionale, quella che ha avuto varie declinazioni,
fino al sacrificio personale, di importanti e prestigiose figure,
da Salvemini a Fortunato, dai Fratelli Rosselli a Giovanni Amendola, da Gobetti a Nitti, di cui si è detto, in gran misura, erede il cessato Partito comunista italiano (o importanti parti di esso), che se ne è intestato, pur tra distinguo e precisazioni, il filo della continuità.
La coscienza di tale linea è ancor viva, come si è visto e sentito, nel corso di un convegno svoltosi di recente (il 5 dicembre 2017) nel Castello di Lagopesole (Avigliano), non lontano da Rionero, proprio dedicato alla figura di Nino Calice. Giorgio Napolitano, ad esempio, ha scritto del suo commilitone politico:
“Se noi avessimo dieci, venti Rionero nel Mezzogiorno, coltivate, dissodate
da organizzatori culturali come Nino Calice, credo che sarebbe un po’ diverso
il Mezzogiorno da quello che è,
o potremmo essere meno allarmati di come, purtroppo, dobbiamo esserlo. Io mi auguro che davvero i giovani, ai quali tocca l’impresa del rilancio della politica, prendano esempio dalla lezione di Nino Calice”. Emanuele Macaluso, a sua volta, ha dichiarato: “Quando penso a figure come Nino Calice penso subito a cos’è stato il Partito comunista italiano, perché io penso che Calice è stato quello che è stato, nella sua specifica complessità, perché c’è stato il Partito comunista. E il Partito comunista è stato quel che è stato perché ci sono stati uomini come Nino Calice”.
Più specificamente, sul rapporto tra Calice e Fortunato, uno storico di matrice cattolico-democratica, Giampaolo D’Andrea, ha affermato:
“Nino Calice ci ha lasciato una grande passione civile e per la storia della sua terra
e del Mezzogiorno. Passione ereditata da tutta una tradizione che in Basilicata
è molto viva e che lui riannoda spesso con quella di Giustino Fortunato.
Una lettura non dico sorprendente ma non consueta negli intellettuali della sua generazione e della sua ispirazione culturale è la rivalutazione che fa del meridionalismo fortunatiano insieme alla rivalutazione del meridionalismo classico e con le spinte alla modernizzazione che inevitabilmente sono venute. In uno dei suoi ultimi saggi fece una riflessione lucidissima sull’illuminismo diffuso in Basilicata e su quello che aveva rappresentato, caratteristiche di una riflessione culturale che ha influenzato anche le sue posizioni politiche nel dibattito sui temi che di volta in volta si presentavano alla sua attenzione. Ha cercato di inserire la Basilicata in un contesto più ampio del Mezzogiorno per riconnetterlo all’Italia e in sintonia con la tradizione dei grandi meridionalisti della nostra terra come Fortunato e Nitti non ha mai pensato alla Basilicata come un’isola né felice né infelice e mai ha pensato al Mezzogiorno separatamente dall’Italia. Questo era un punto fermo della posizione dei meridionalisti: non rivendicavano attenzioni per il Mezzogiorno ma solo perché il Mezzogiorno potesse contribuire meglio al futuro dell’Italia.”7
C’è solo da sperare che la città di frontiera, se tale essa è ancor oggi, nel suo continuo dubitare, non sia troppo irriconoscente anche con Nino Calice,
poiché sono certo che il più giovane intellettuale, vissuto nel secolo scorso, avrebbe approvato (e lavorato per) la creazione di un Parco letterario dedicato alla complessa e poliedrica figura di Giustino Fortunato. Un simile Parco, coinvolgendo una gran parte del territorio della Basilicata Settentrionale (le ricerche storiche di Giustino, da sole, creerebbero una mappa-reticolo dei luoghi storici da lui riscoperti e individuati, traendoli dall’oblio e dalla dimenticanza; senza dire dei luoghi delle Strade ferrate propugnati come direttrici di sviluppo o dell’azienda familiare di Gaudiano o dei giovani intellettuali lucani, provenienti da tanti piccoli centri, da lui seguiti, valorizzati ed incoraggiati), si inserirebbe nello stesso rilancio dell’immagine della Regione, perché percorsa da un tenace filo di pensiero liberal-democratico, di respiro nazionale.