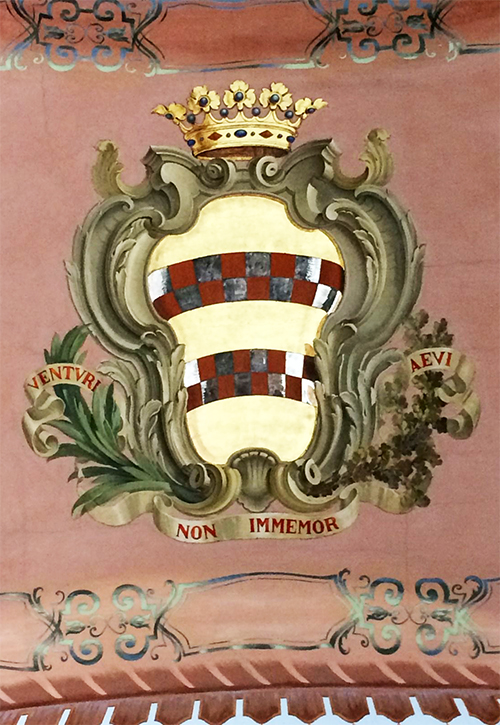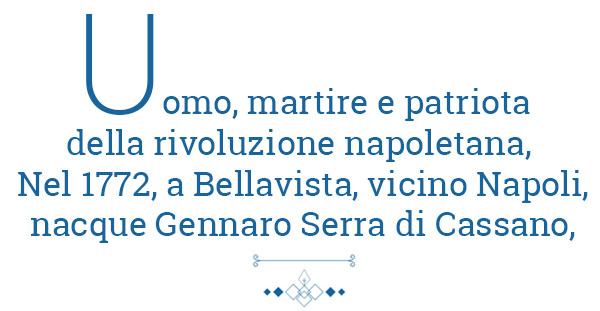Studiò insieme al fratello Giuseppe in Francia, nel collegio di Sorèze,
durante gli avvenimenti rivoluzionari e ne acquisì lo spirito repubblicano
condividendo il motto “Liberté, Égalité, Fraternité”, che influenzò
tutta la sua breve vita sino alla morte.
Aderì sul nascere alla “Società Patriottica” insieme ai primi giacobini napoletani, alcuni di origine massonica: Eleonora Fonseca Pimentel, insigne letterata e giornalista, la nobile Luisa Sanfelice, il duca Ettore Carafa, l’avvocato Nicola Fasulo, l’imprenditore della seta Domenico Piatti, l’ufficiale di Marina Giambattista de Simone, il dottor Pasquale Baffi e Filippo de Marini, marchese di Genzano. All’inizio la loro attività libertaria fu quasi tollerata dalla regina Maria Carolina, moglie del re Borbone Ferdinando IV, che vedeva nel loro agire la meta di una monarchia costituzionale, ma poi, in seguito agli avvenimenti di Francia, la sovrana mutò radicalmente il suo atteggiamento, scatenando una feroce e viscerale repressione.
A Parigi regnava il terrore e iniziò a lavorare alacremente la ghigliottina.
Il 21 gennaio fu mozzata la testa del re Luigi XVI
davanti ad una folla festante. Il boia Charles Henry Sanson vendette poi all’asta il suo copricapo, ciocche di capelli e frammenti del cappotto. La folla ne godette. Il 16 ottobre toccò a Maria Antonietta, sorella di Maria Carolina, prematuramente invecchiata dalla paura, con il viso pieno di rughe e i capelli imbiancati. Il suo carnefice, Henry Sanson junior, mostrò la testa mozzata in segno di trionfo, col sangue che gocciolava sul tavolato della forca. La folla fu entusiasta.
La morte violenta della sorella terrorizzò Maria Carolina che vedeva nemici dappertutto, non dormiva più nello stesso letto
e faceva assaggiare il cibo ai servitori.
Scrisse su una stampa dell’esecuzione pervenuta da Parigi: “Perseguirò la mia vendetta sino alla morte”. Perquisizioni, pedinamenti, retate. I servizi segreti lavoravano quotidianamente e riferivano ai sovrani di cene patriottiche, di cospirazioni misteriose, di piani eversivi tra i cosiddetti “idealisti”, che si battevano in nome della “filosofia” e della “virtù”. La reazione dei Borboni diventò atroce, selvaggia, spietata. Il 18 ottobre del 1794, a mo’ di esempio, salirono sul patibolo al Largo Castello tre ragazzi meridionali: Emmanuele de Deo, Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani, primi martiri innocenti della libertà.
La frattura tra il re, la regina e i libertari napoletani si allargò a dismisura
e i giacobini Francesco e Gennaro Serra di Cassano, sentitisi in pericolo,
agivano in segreto, preparando l’arrivo dei francesi.
I genitori, il duca Luigi e sua moglie Giulia Carafa di Roccella, condividevano le loro scelte, ma temevano per la sorte dei figli. Giuseppe Serra di Cassano venne arrestato e condotto in carcere, con lui anche Eleonora Fonseca Pimentel. Gennaro si salvò miracolosamente.
Intanto i fatti precipitarono, Il generale francese Jean Étienne Championnet avanzava con le sue truppe verso la capitale, al suo seguito molti giacobini, Ettore Carafa, Carlo Lauberg, Vincenzo Russo e altri che erano esuli. L’ammiraglio Orazio Nelson era alla rada con la sua flotta. L’esercito borbonico marciò verso Roma. All’inizio sembrò una guerra facile, poi scattò la controffensiva dei francesi e Championnet li travolse sbaragliandoli. Il re, attraverso percorsi segreti, lasciò la Reggia, s’imbarcò sulla nave ammiraglia di Nelson e puntò su Palermo.
Nel Regno, due delegati cercarono di controllare la piazza inutilmente. Da un lato i Lazzari che erano filo monarchici, dall’altro i giacobini che lavoravano per favorire la vittoria dei francesi. L’anarchia era al massimo,
i Lazzari presero il sopravvento, ma si sentirono traditi dalla fuga del Re.
Bruciarono le forche fatte issare dal Borbone e liberarono i prigionieri.
Giuseppe Serra di Cassano ed Eleonora Pimentel tornarono liberi.
I Lazzari non parteggiavano per i francesi che si preparavano a combattere, ma non obbedivano ai delegati del re. Gennaro lavorava assiduamente con tutti gli altri giacobini per la battaglia decisiva, l’armata di Championnet era vicina. Si impadronirono di Forte Sant’Elmo; un gruppo di donne vestite da uomo, capeggiate da donna Eleonora Pimentel, si unirono a loro e nel cortile del Forte fu piantato l’Albero della Libertà e proclamata la Repubblica Napoletana.
Championnet invase Napoli, sbaragliando i Lazzari che finirono per unirsi a lui. Fu insediato il primo governo provvisorio e Giuseppe Serra di Cassano fu tra i rappresentanti comunali, al posto del padre. Furono nominati vari ministri tra i giacobini, ma l’ultima parola spettava ai francesi.
Gennaro Serra di Cassano ebbe il grado di comandante in seconda
della Guardia nazionale, con il compito di organizzare la cavalleria.
Per ordine del Direttorio di Parigi iniziarono le riscossioni dei tributi, le confische, nuove e vecchie gabelle, il passaggio alla Francia di tutti i beni della Corona, le banche, la Zecca, i possedimenti nelle provincie. Il popolo era scontento, i Lazzari ripresero l’offensiva lanciando pietre e vasi dai balconi, Championnet fu sostituito e al suo posto arrivò il cinico generale McDonald che mise in vendita anche gli arredi reali.
Intanto, con la benedizione del Papa, il cardinale Ruffo avanzava
per riconquistare il Regno con l’esercito della Santa Sede,
uccidendo, saccheggiando, stuprando, violentando, lasciando dietro di sé una scia di terrore, di sangue, di morte, di cadaveri. Un’incredibile ecatombe. Nel Regno, i governanti rivoluzionari vararono leggi giuste. Abolirono la gabella sulla farina, avviarono la stesura di una nuova Costituzione, si organizzarono per resistere all’avanzata del cardinale Ruffo. La Pimentel pubblicava il Monitore dando informazioni democratiche ai cittadini.
Giulia Carafa di Roccella, la madre di Gennaro, e sua sorella Maria Antonia,
duchessa di Popoli, considerate le donne più belle di Napoli, delicate e colte, trasportavano intrepide sul molo pietre e calce per rafforzarne la difesa
e proteggere la fragile conquista democratica,
fianco a fianco con il popolo,
gomito a gomito con gli uomini, instancabili, indomite, combattive. Bussarono alle case dei ricchi per chiedere offerte per la difesa, vestiti e viveri per i più bisognosi, solidarietà per i poveri. Aiuti, donazioni, sostegni. Tutto serviva per la causa. Furono chiamate “madri della Patria” per la loro azione nobile, generosa, altruista, solidale, spinta da un ideale repubblicano che permeava il loro animo femminile.
La regina Maria Carolina manifestò il suo sdegno per le due nobildonne che tra l’altro, scandaloso per lei, non portavano più il busto e la parrucca, ma sostenevano la rivolta.
McDonald, incapace di fronteggiare Ruffo, si trasferì presso Caserta e da lì a poco si avviò verso il nord, lasciando campo libero. Il re Ferdinando ordinò a Ruffo di fare molti casicavalli, di impiccare molti nemici come i caciocavalli che vengono appesi col cappio sino alla maturazione. Il forte di Vigliena fu uno degli ultimi baluardi contro i sanfedisti. Erano duecento, comandati da Antonio Toscano, contro i mille nemici. Alzarono una bandiera con su la scritta “Vincere, vendicare, morire” e, di lì a poco, chiusi nel magazzino delle munizioni, saltarono in aria disintegrati in un botto infernale insieme a molti dei loro nemici.
A Napoli, Gennaro Serra di Cassano difendeva con la sua colonna Capodimonte, il capitano Campana, Ponticelli. Il generale francese Basset, Foria. Furono ben presto travolti e si rifugiarono nel Maschio Angioino e in Castel dell’Ovo, in un ultimo tentativo di sottrarsi alla furia devastatrice sanfedista.
Nelle strade si susseguirono scene di ferocia, di violenza, di terrore. Massacri, saccheggi, incendi, stupri, scene di follia inusitata. La gente fuggiva
inorridita, terrorizzata, sgomenta. Si era creato l’inferno.
Si scatenò una caccia all’uomo, al democratico, all’oppositore. Giulia e Maria Antonia Carafa di Roccella furono spogliate, denudate, si dice violentate. Coperte da un lenzuolo, con le carni nude, sottoposte al pubblico ludibrio, offese, vilipese, derise. Trattate come bestie, sputate in faccia. Gli Alberi della Libertà furono abbattuti e trasformati in latrine puzzolenti. I giacobini venivano trucidati sommariamente, senza alcun processo, senza possibilità di difesa. I sanfedisti si sedevano sui loro cadaveri sbudellati, sui loro corpi martoriati, con le viscere di fuori, per mangiare, bere, gozzovigliare. Alcuni abbrustolirono le loro carni e le trangugiarono avidi in un macabro banchetto.
Altri prigionieri furono portati al Ponte della Maddalena e donne monarchiche imbestialite sputavano loro addosso, lanciavano scorze di cibo, li deridevano. In breve, anche le ultime sacche di resistenti furono spezzate via e il cardinale Ruffo prese pieno possesso di Napoli e di tutto il Regno. La Repubblica Napoletana era sconfitta.
Memore di essere uomo di chiesa, il cardinale trattò con i capi repubblicani superstiti asserragliati nel castello e raggiunse con loro il “patto di capitolazione”.
I giacobini ebbero l’onore delle armi e la possibilità di andare in esilio.
Al suono cadenzato dei tamburi dei soldati vincitori, vinti ma a testa alta,
lasciarono il Forte per prendere posto sulle navi in partenza per Tolone.
Il 24 giugno del 1799 arrivò a comando della sua poderosa flotta l’ammiraglio Orazio Nelson e affermò che il “patto” era carta straccia; il re delle Due Sicilie, il Borbone, non avrebbe mai trattato con i ribelli che non meritavano indulgenza, e così fu.
Vecchie navi da trasporto funsero da prigione. I prigionieri furono legati ai ferri, esposti al sole, con poca acqua e con poco cibo disgustoso, dormivano su un giaciglio di sabbia ed evacuavano a turno su pochi buglioli schifosi e maleodoranti. La loro vita si era trasformata in un inferno.
Le ultime sacche di resistenza furono travolte. Un pescivendolo, si dice, tagliò, come se fossero pesci da pulire, molte teste di giacobini superstiti e i sanfedisti le fecero rotolare lungo la strada, giocandoci come se fossero palloni.
Gennaro Serra di Cassano si rifiutò di chiedere clemenza al cardinale Ruffo,
per orgoglio e per diffidenza. Secondo la leggenda, travestito da marinaio,
tentò di riparare nel suo palazzo al Monte di Dio,
ma fu visto da un libraio che lo tradì.
Condotto nelle carceri comuni, da dove forse non si era mai mosso, aspettò con dignità che si compisse il suo destino di uomo libero. La Giunta di Stato, implacabile, emise la sentenza di condanna alla ghigliottina. Sarebbe stato giustiziato insieme ad altri sette cospiratori.
Il 20 agosto del 1799, la Piazza Mercato, palcoscenico storico delle esecuzioni, fu invasa da una folla di tutti i ceti sociali, assettata di sangue e di violenza. Sadicamente eccitata per lo spettacolo che si stava per rappresentare, si agitava come un branco di lupi famelici, vogliosa di scene raccapriccianti, di morte, di terrore. Intorno, imponenti misure di sicurezza, soldati armati, cannoni puntati, armigeri pronti. Gennaro aprì la macabra danza della morte. Aveva chiesto di avere l’oppio per placare l’angoscia dell’attesa, ma gli fu negato. Per il suo titolo doveva essere accompagnato da servitori, ma gli fu proibito. Doveva avere un palco addobbato di drappi neri, ma non gli fu concesso.
Salito sul patibolo, guardò davanti a sé quel mare di facce in attesa,
quella moltitudine di uomini e donne compiacenti, quegli sguardi sadici,
e disse al frate che gli era accanto: “Ho sempre lottato per il loro bene
e ora li vedo festeggiare per la mia morte”.
Offrì la sua testa al boia e la lama gliela recise di netto, un colpo solo e rotolò in terra. Aveva ventisei anni, era giovane, ricco, nobile di animo e di censo. Morì per perseguire i suoi ideali sotto gli occhi festanti del suo popolo, ingrato e inconsapevole.
Seguirono le altre esecuzioni: Domenico Piatti, Vincenzo Lupo, Nicola Pacifico, Michele Natale, Antonio Piatti e, ultima, la passionaria della rivoluzione, Eleonora Fonseca Pimentel. A lei le guardie strapparono le mutande in segno di disprezzo. Lei disse in latino: “Un giorno sarà utile ricordare tutto questo”.
Il suo corpo penzoloni, con il cappio al collo, oscillò sul patibolo spinto dal vento. La folla soddisfatta se ne compiacque: la signora aveva smesso di fare l’eroina.
Il duca Luigi Serra di Cassano, addolorato, chiuse il portone del suo palazzo
di fronte alla Reggia e per due secoli questo ingresso
è rimasto sbarrato in segno di lutto e di protesta.
Maria Antonia Carafa si suicidò dopo qualche anno gettandosi in un pozzo. Giulia Carafa visse a lungo tormentandosi nei ricordi e finì per impazzire. La morte di Gennaro Serra di Cassano non fu inutile, il suo sacrificio resterà per sempre a testimonianza di una vita “illuminata”.