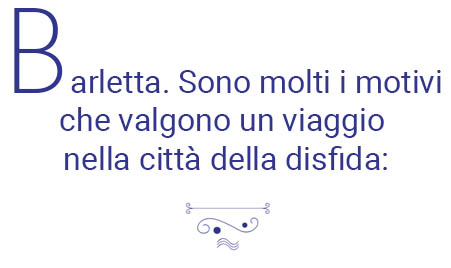Ai primi di maggio del 1882 un giovanissimo, ma già celebre, Gabriele d’Annunzio visitò la Sardegna in compagnia di altri due autori parimenti noti: Edoardo Scarfoglio, in seguito co-fondatore de Il Mattino di Napoli, e Cesare Pascarella, affermato poeta in dialetto romanesco.
I tre viaggiavano come inviati del giornale satirico Capitan Fracassa, il cui titolo era ripreso dall’omonimo romanzo di Gautier.
D’Annunzio vi scriveva con il nome de plume di Mario de’ Fiori, pseudonimo che era stato anche quello di un pittore del 1600, cui è intitolata una via del centro di Roma.
Secondo il racconto che Scarfoglio fece del viaggio, inizialmente d’Annunzio, nonostante le insistenze del Pascarella, non doveva essere della partita, ma all’ultimo momento aveva cambiato idea e si era imbarcato sulla nave. Il repentino ripensamento era dovuto al fatto che, ad un tratto, gli era balenata in mente la prospettiva di vedere il plenilunio sul mare e questo solo pensiero era bastato a vincere le sue resistenze. Malgrado le iniziali aspettative, il poeta aveva sofferto la traversata, tuttavia l’accoglienza trionfale che lo attendeva in Sardegna, dove la sua reputazione l’aveva preceduto, gli fece presto dimenticare i disagi patiti durante la navigazione
L’itinerario del tour sardo, intrapreso per fare un reportage dell’isola,
all’epoca non ancora meta dei vacanzieri e sconosciuta ai più,
dopo lo sbarco a Terranova (oggi Olbia)
prevedeva varie tappe,
che dovevano fornire gli spunti per gli articoli da inviare al giornale: il Nuorese, Cagliari, l’Iglesiente, il Campidano, Sassari e forse – relata refero perché notizia desunta da un quotidiano locale dell’epoca – anche Alghero.
Il dubbio sorge perché la pubblicazione dei resoconti sul Capitan Fracassa rimase incompiuta. Iniziata in quello stesso maggio del 1882, venne interrotta, infatti, per dare spazio alle notizie relative alla morte di Giuseppe Garibaldi, avvenuta il 2 giugno, e non fu più ripresa. Dal viaggio in Sardegna doveva scaturire anche un saggio del quale era stato già deciso il titolo – Libro d’oltremare – eppure alla fine non se ne fece nulla.
Di questo viaggio lo scrittore sardo Stanis Manca dirà: “D’Annunzio, Scarfoglio e Pascarella percorsero tutta la Sardegna, descrivendo con entusiasmo i suoi costumi e i suoi paesaggi“.
D’Annunzio, dal canto suo, aveva collaborato alla stesura degli articoli per il Capitan Fracassa, che nelle intenzioni dovevano essere sei, però a sua firma comparve solo Masua, reportage sulla testata Cronaca Bizantina, nel quale descrisse la miniera iglesiente come “un pezzo d’inferno seppellito nel paradiso terrestre”.
In effetti
d’Annunzio era stato subito conquistato dalla “solitudine ampia e serena” dell’isola
e dalla sua “civiltà taciturna”,
come poi efficacemente la definirà. In Sardegna stringerà immediate e durature amicizie e rimarrà così ammaliato dal canto sardo – che gli era parso “…antico quanto l’alba” – da ospitare più di quarant’anni dopo, nel 1927, il Coro di Aggius al Vittoriale. Della musica sarda dirà inoltre: “…da più giorni vivo nel cerchio magico di quelle melodie. Non è possibile ascoltare un canto della Planargia e dell’Anglona senza restare imprigionato da un fascino misterioso…”.
La fascinazione del poeta per l’isola era passata anche attraverso il vino cannonau di Oliena, da lui – che si definiva orgiaste astemio – ribattezzato Nepente (dal greco ne penthos, letteralmente “no” “dolore”), nome dato nell’antica Grecia ad una portentosa bevanda che leniva il dolore e procurava l’oblio, con il quale da allora è conosciuto. A proposito del Nepente, anni dopo, nel 1909, scriverà nella prefazione al libro Osteria del tedesco Hans Barth: “…non conoscete il nepente di Oliena neppure per fama? Ahi lasso! Io son certo che se ne beveste un sorso non vorreste mai più partirvi dall’ombra delle candide rupi e scegliereste per vostro eremo una di quelle cellette scarpellate che i sardi chiamano Domos de janas, per quivi spugnosamente vivere in estasi…”
Benché la sua permanenza fosse stata appena di una ventina di giorni, d’Annunzio affermerà in seguito di avere
“…nostalgia della Sardegna da dodici anni, come d’una patria già amata
in una vita anteriore”, e di amare “…filialmente codesta terra”,
nella quale, tuttavia, non ritornerà più, sebbene negli anni ne avesse sempre mantenuto il proposito: sia, un decennio dopo, per assolvere l’incarico di censire tutti i monumenti artistici dell’isola, affidatogli nel 1893 dal Ministro dell’Istruzione, sia per una progettata opera sulla Barbagia, della quale il personaggio Rudu, nella tragedia Più che l’amore (peraltro un clamoroso fiasco), è l’unica cosa che resta.
Frutto del soggiorno dannunziano in Sardegna fu anche il trittico di sonetti Su Campidanu (Il Campidano), pubblicato sul Capitan Fracassa, oggi pressoché inedito perché non figura in nessuna raccolta delle opere del poeta.
I versi sono quelli di Sa Spendula (che in sardo significa “la cascata”), dedicati all’omonima cascata di Villacidro; Sotto la lolla (Sotto il loggiato), ambientati nelle campagne del nuorese e celebrativi della venustà femminile sarda; Sale, ispirati alle saline cagliaritane di Molentargius.
Delle tre poesie Sa Spendula è senz’altro quella più rinomata. La cascata, malgrado non sia la più alta dell’isola, è forse la più conosciuta, presumibilmente grazie ai versi del medesimo d’Annunzio.
L’acqua scaturisce dalla sommità rocciosa del Monti Mannu (‘monte grande’, una delle montagne che delimitano a sud ovest la vasta pianura del Campidano), “fende come una lama la foresta” ed in tre salti precipita per 60 metri, formando tre piscine naturali.
Lo scenario della Spendula è quello che ispirò al d’Annunzio probabilmente
le rime più potenti dei tre componimenti sardi, con sonorità che, in abbozzo, richiamano e precorrono – in un analogo contesto silvestre – le onomatopee
e le allitterazioni de La Pioggia nel pineto,
la sua lirica più famosa, che vedrà la luce vent’anni più tardi.
Sa Spendula
Dense di celidonie e di spineti
le rocce mi si drizzano davanti
come uno strano popolo d’atleti
pietrificato per virtù d’incanti.
Sotto fremono al vento ampi mirteti
selvaggi e gli oleandri fluttuanti,
verde plebe di nani; giù pei greti
van l’acque della Spendula croscianti.
Sopra, il ciel grigio, eguale. A l’umidore
della pioggia un acredine di effluvi
aspra esalano i timi e le mortelle.
Ne la conca verdissima il pastore
come fauno di bronzo, su ‘l calcare,
guarda immobile, avvolto in una pelle.
E così, come la Cascata delle Marmore ebbe nel Byron il suo bardo, anche la cascata sarda – e la Sardegna stessa – troverà nel Vate il suo (imparziale) cantore.