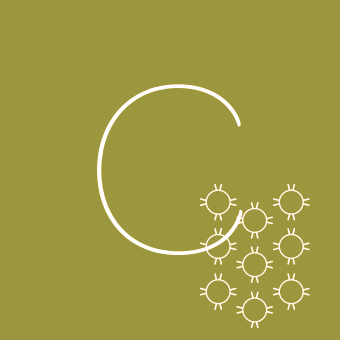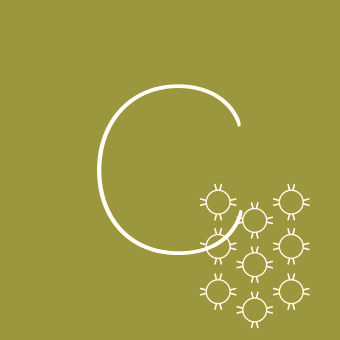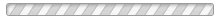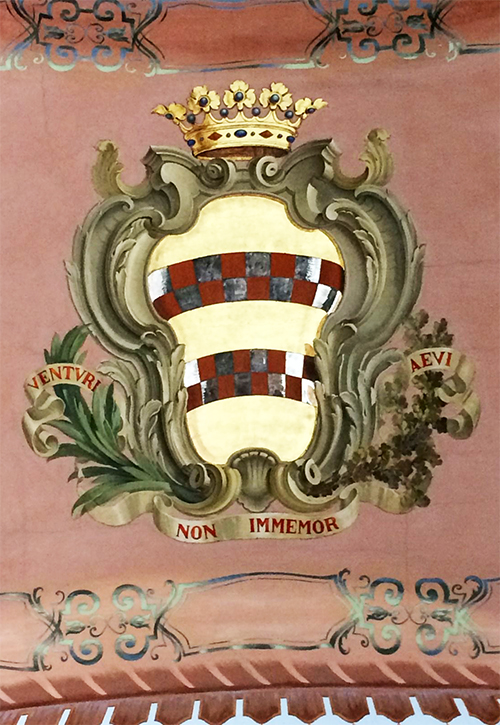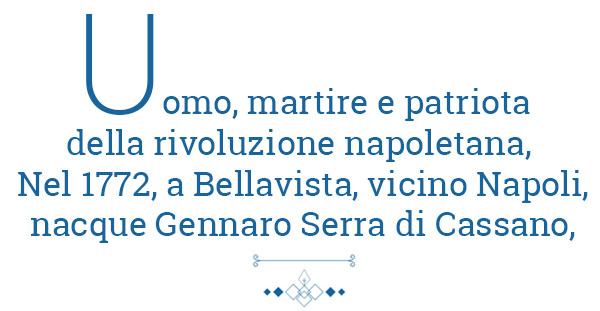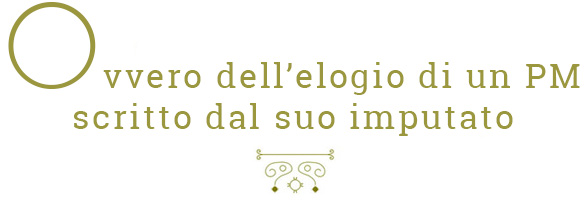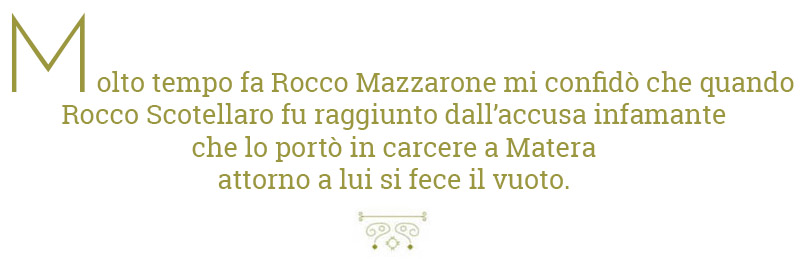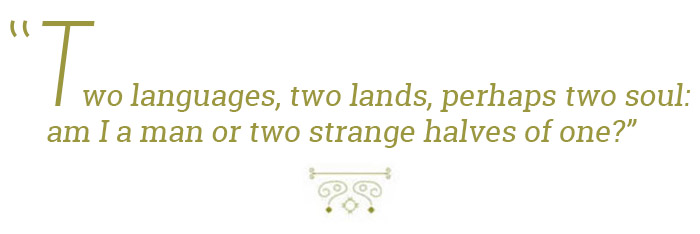fiorello LA.guardia: incorruttibile come il sole
ci troviamo già in pieno fascismo e la Germania si sta avviando al regime nazista con l’ascesa di Hitler a Cancelliere tedesco.
Negli Stati Uniti, il Presidente Roosevelt inaugura la politica del New Deal per tentare di contrastare la Grande Depressione dovuta al crollo di Wall Street del 1929. Viene inaugurato l’Empire State Building che diventa il grattacielo più alto del mondo, viene prodotta la prima pellicola in Technicolor, appaiono sulle rispettive scene Frank Sinatra e “Via col vento”, divenendo dei cult, mentre Superman e Batman fanno il loro ingresso nel mondo dei fumetti.
Proprio in quegli anni un terzo supereroe appare sulla scena,
è Fiorello La Guardia,
che nel 1933 diventa sindaco di New York e, in poco tempo, il più amato sindaco della storia degli Stati Uniti, una vera leggenda. Truman alla sua morte lo definirà “un uomo incorruttibile come il sole” e De Gasperi “il più grande italiano d’America, colui che ci ha salvato dalla fame nei giorni più drammatici della nostra storia”1.
Figlio di Achille La Guardia, maestro di corno e compositore, proveniente
da Cerignola (Foggia)2 e Irene Coen Luzzatto, discendente
di una autorevole famiglia ebraica italiana di Trieste
(allora Impero austro-ungarico), è il secondo di tre figli. Fiorello ha un’infanzia e un’adolescenza vissute seguendo il lavoro del padre, direttore della banda dell’11th U.S. Infantry Regiment, tra North Dakota, Stato di New York e Arizona. Fin da giovane sente parlare di malcostume pubblico, scommesse e gangster, leggendo l’edizione domenicale del “New York World”, che rivelava costantemente episodi di corruzione del sistema Tammany Hall (Tammany Hall era la macchina politica del Partito Democratico a New York, accusata anche di commistione con malavita e mafia)3.
Quella dei La Guardia è una famiglia povera ma colta che permette a Fiorello
di imparare, grazie al padre, a suonare il banjo e il corno, mentre
grazie alla cultura della madre apprende alcune lingue
(parlerà negli anni, oltre all’inglese e all’italiano, anche il tedesco, il francese, l’ebraico, il croato, l’ungherese e l’yiddish), ricevendo l’educazione poliglotta che caratterizzava la tradizione mitteleuropea4. Nonostante ciò, Fiorello agli occhi della gente rimaneva sempre un italiano meridionale, figlio di immigrati, mezzo ebreo e americano, molto lontano dai WASP dell’upper class statunitense. Questo significava, per lui, essere deriso e bullizzato, ma soprattutto sentire la difficoltà di essere una parte debole. Non lo aiuta neanche il fisico, essendo basso e tarchiato (1 metro e 58 per 56 chili). Anche per questo motivo, così come per il suo nome, Fiorello, più avanti sarà soprannominato dagli americani “The Little Flower”. Ma è proprio dalle sofferenze di questi anni che nascono la sua forza e la determinazione di volersi occupare delle fasce più deboli della popolazione e la sua rabbia contro la corruzione e l’illegalità.
La Guardia, dall’età di 16 anni, quando diventa reporter per il “St. Louis Post-Dispatch”, non smette più di lavorare e crescere umanamente e professionalmente:
alla morte del padre, diventa addetto consolare a Belgrado e poi a Fiume.
Tornato a NYC nel 1906, lavora come interprete nel centro accoglienza
immigrazione di Ellis Island. Di notte studia legge ai corsi serali
della New York University, dove si laurea nel 1910.
L’ultimo anno capisce come tutta la situazione degli immigrati sia in realtà un ennesimo giro d’affari per oliare determinati ingranaggi che girano intorno a polizia, avvocati e giudici, tutti al servizio dei politici corrotti della Tammany Hall5.
Fiorello La Guardia è già deputato al Congresso per il Partito Repubblicano, quando gli Stati Uniti entrano nella Grande Guerra nel 1917. Lui, per limiti di altezza, decide di presentarsi volontario come aviatore. In brevissimo tempo diventa comandante dei piloti statunitensi a Foggia, terra paterna, dove si reca per l’addestramento dei suoi uomini sugli aerei Caproni.
Con Pietro Negrotto attraversa il cielo straniero, colpendo
le linee nemiche austriache. Questa impresa finisce sulla stampa
e il nostro diventa famoso in tutta Italia.
Il Re d’Italia lo invita a un ricevimento dove incontra anche Gabriele D’Annunzio6. Vittorio Emanuele III si sente chiamare Manny (diminutivo di Emanuel) da Fiorello e ascolta anche affermare che “la monarchia aveva i giorni contati”7.
Alla fine della guerra, rientra a New York e viene rieletto al Congresso per altri cinque mandati. Tra le altre cose, si oppone in maniera decisa al Volstead Act del 1919 con cui si era aperto il Proibizionismo. Si vietavano la fabbricazione, la vendita e l’importazione di prodotti alcolici, con il risultato di far prosperare e crescere i capi clan mafiosi che vivevano di contrabbando, come Al Capone e molti altri gangster.
Nel 1926, per dimostrare l’inutilità della legge, Fiorello invita i giornalisti
all’interno degli uffici della Camera perché fossero testimoni di come
miscelava e poi beveva un drink illegale, combinando due liquidi legali
e aggiungendo estratto di malto e birra analcolica.
Il risultato di questo intruglio aveva una gradazione alcolica illegale. Nessuno pensa di arrestarlo e lui dichiara che “la gente si sta avvelenando, i distillatori clandestini si arricchiscono e i funzionari del governo si fanno corrompere”.
Nel 1933 diventa sindaco di New York. In quel ruolo La Guardia
rimarrà sino al 1945, divenendo una vera icona della città.
Si era presentato alle elezioni a capo di una lista di coalizione in aperta opposizione a Tammany Hall per “una limpida, onesta, efficiente amministrazione municipale”. Con la sua vittoria, finiscono la corruzione, i favoritismi, il clientelismo e finisce tutto ciò che lui aveva sempre combattuto: ai suoi sostenitori egli dice di non aspettarsi un lavoro, perché “avrebbe assunto soltanto il migliore in assoluto per ogni incarico, anche se quella persona non avesse votato per lui”8.
Fiorello La Guardia governa con estremo vigore, licenziando dirigenti e impiegati inutili e incapaci di ogni schieramento,
riuscendo inoltre a far arrestare Lucky Luciano che, in una autobiografia
scrive: “Io semplicemente non riesco a capirlo. Gli abbiamo offerto
di diventare ricco, ma non ha neanche voluto ascoltarci”.
La Guardia mette poi al bando le slot machine, il principale business della malavita, ma da personaggio istrionico e colorito qual era, e avendo capito perfettamente l’importanza dell’uso dei media, si fa fotografare in piazza mentre prende a martellate decine di macchinette.
Fiorello, in quegli anni di Grande Depressione, promuove la ripresa economica, collaborando con il Presidente Roosevelt. Nel frattempo si occupa di politica sociale e di servizi ai cittadini: crea strade, parchi, ponti, case popolari, trasformando New York in una metropoli moderna ed efficiente.
Una volta eliminata la corruzione e la malavita, passa al sistema sanitario,
alla pubblica istruzione e alla polizia, riorganizzando
completamente le rispettive strutture.
Organizza una fiera mondiale, dedicata al futuro: “Building the World of Tomorrow”, che viene visitata da 44 milioni di persone in due anni9; crea un Centro per la musica, il balletto e il teatro che sia alla pari delle altre capitali europee, che sia accessibile anche alla working class10. Pensa a scuole speciali adatte ai ragazzi di talento e riesce con molti sforzi a far sì che New York abbia due aeroporti internazionali (il secondo di questi, pochi mesi prima della sua morte gli sarà intitolato, non solo per il suo eccellente ruolo di sindaco ma anche per il suo valore come aviatore).
Riesce infine anche a contenere i dissidi razziali ed etnici in tutta la città.
“The Little Flower” i suoi concittadini se lo ritrovano un po’ ovunque: mentre dirige un’orchestra al Metropolitan, mentre gioca a baseball o a bowling per beneficenza, mentre guida aerei, treni o metropolitane; lo sentono alla radio che legge Dick Tracy ai bambini durante lo sciopero dei giornali. Ama mangiare pizza o spaghetti in mezzo agli italiani, ma la sua passione più grande sono i Vigili del fuoco: fa installare sulla sua macchina la radio a onde corte sintonizzata sulla banda dei pompieri per poterli raggiungere quando avesse voluto. E spesso lo vuole, accorrendo per ogni tipo di emergenza, dagli incendi al crollo di edifici ai guasti degli impianti idrici. Sembra che, in quei frangenti, una battuta molto diffusa fosse: “Qualcuno vuole tirare il sindaco fuori da lì?”
Questi sono gli anni che precedono e che attraversano la Seconda Guerra Mondiale.
Il suo rapporto con il nazi-fascismo è molto critico, e quando i nazisti parlano
di lui come “il sindaco ebreo di New York”, lui risponde candidamente:
“Non avevo mai creduto di avere abbastanza sangue ebraico
nelle vene da giustificare il fatto di potermene vantare”.
La Guardia detesta i nazisti tedeschi ed è molto preoccupato per il proliferare dei simpatizzanti americani. Così non può non apprezzare la copertina di Captain America che da un pugno dritto in faccia a Hitler, pubblicato prima che gli Stati Uniti entrino nella Seconda Guerra Mondiale e ritenuto inaccettabile dai simpatizzanti nazisti americani11. Alcuni di questi sono molto arrabbiati con gli autori dell’immagine e inviano loro lettere minatorie. I due ricevono ben presto una telefonata del sindaco: “Voi ragazzi laggiù state facendo un buon lavoro,” dice la sua caratteristica voce. “La città di New York farà in modo che non vi venga fatto alcun male.”
Durante la Seconda Guerra mondiale, a partire dal 18 gennaio 1942, mentre i newyorkesi possono sintonizzare la radio sulla WNYC e ascoltare “Talks to the people”, gli italiani, sulle onde corte, potevano ascoltare settimanalmente “Sindaco La Guardia chiama Roma”. Il programma inizia sempre con: “È il vostro amico La Guardia che vi parla”, e racconta loro la storia di Roma sin dall’Impero Romano, esortando gli ascoltatori ad opporsi a Hitler e a battersi per la loro dignità. Alla fine della guerra l’Italia è allo stremo delle forze, mancano i viveri a partire dal pane.
Alcide De Gasperi si rivolge a Fiorello La Guardia, in quel momento
direttore generale dell’UNRRA, per chiedere aiuti.
E questi arrivano velocemente perché, diceva Fiorello: “I popoli hanno fame, al diavolo i protocolli”12: 60mila tonnellate di cereali e 450 milioni di dollari in altre derrate alimentari che sbarcheranno da quattro navi ogni mese fino al 194713.
Fiorello La Guardia muore di tumore al pancreas alle 8.06 di sabato 20 settembre 1947. La campana del dipartimento antincendio di New York batte i tradizionali quattro rintocchi, cui straordinariamente seguono le sirene dei Vigili del fuoco e poi quelle delle ambulanze, dei taxi e di tantissime auto di New York, creando un concerto assordante e lamentoso:
gli abitanti della città intera partecipano in massa al saluto all’uomo che,
come ha scritto la Yale University motivando la sua laurea honoris causa,
“ha strappato la democrazia ai politici e l’ha ridata al popolo”14.



[1] Cfr. Luca Martera, Si può essere italiani, politici e onesti? Sì, se il tuo nome è Fiorello La Guardia, lucamarterablogspot.com, 31 gennaio 2013
[2] Alcuni sostengono che fosse proprio di Foggia, cfr. Maurizio De Tullio, Il padre di Fiorello La Guardia era foggiano. Ed ecco perché, letteremeridiane.org, 1 novembre 2015.
[3] Cfr. Ronald H. Bayor, Fiorello La Guardia Ethnicity, Reform, and Urban Developement, John Wiley & Son, 2017, p.6
[4] Ronald H. Bayor, cit., p.
[5] Cfr. H. Paul Jeffers, Fiorello La Guardia. Un imperatore a New York, cit. pp.36 e ss.
[6] Cfr. Cfr. Gigi Speroni, Fiorello La Guardia, Il più grande italiano d’America, Rusconi 1993, p.103; cfr. anche Piotr Podemski, Un D’Annunzio italoamericano in guerra. Mito bellico e success story nell’autobiografia di Fiorello La Guardia, in “In guerra con le parole. Il primo conflitto mondiale dalle testimonianze scritte alla memoria multimediale”, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2018, p.581
[7] Cfr. H. Paul Jeffers, Fiorello La Guardia. Un imperatore a New York, cit. p.97; cfr. anche Gigi Speroni, Fiorello La Guardia, cit. p. 104
[8] H. Paul Jeffers, Fiorello La Guardia. Un imperatore a New York, cit. p.174
[9] AA.VV., Viaggi fantasmagorici: l’odeporica delle esposizioni universali (1851-1940), Franco Angeli 2019, p. 140
[10] Jennifer Homans, Apollo’s Angels: A History of Ballet, Random House Publishing, 2010, cap.11
[11] New York City Mayor Fiorello La Guardia Loved Comics So Much, in gizmodo.com
[12] Cfr. Servizio TG1 Impariamo l’italiano youtu.be/YWUUhNmXUxrU
[13] Cfr. Giuseppe Audisio, Alberto Chiara, I fondatori dell’Europa unita secondo il progetto di Jean Monnet: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Effatà Editrice 1999, p.71
[14] Cfr. Gigi Speroni, Fiorello La Guardia, cit., Rusconi 1993 p.236-237