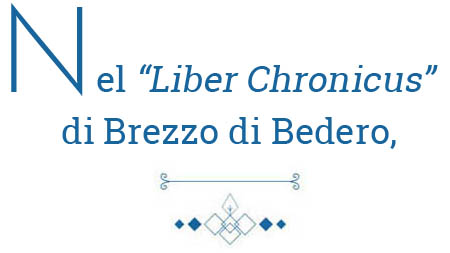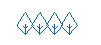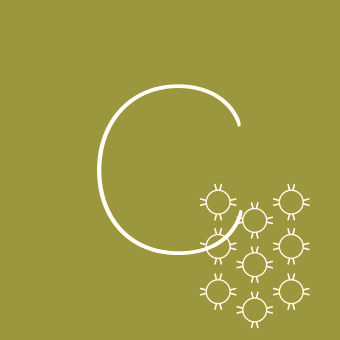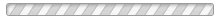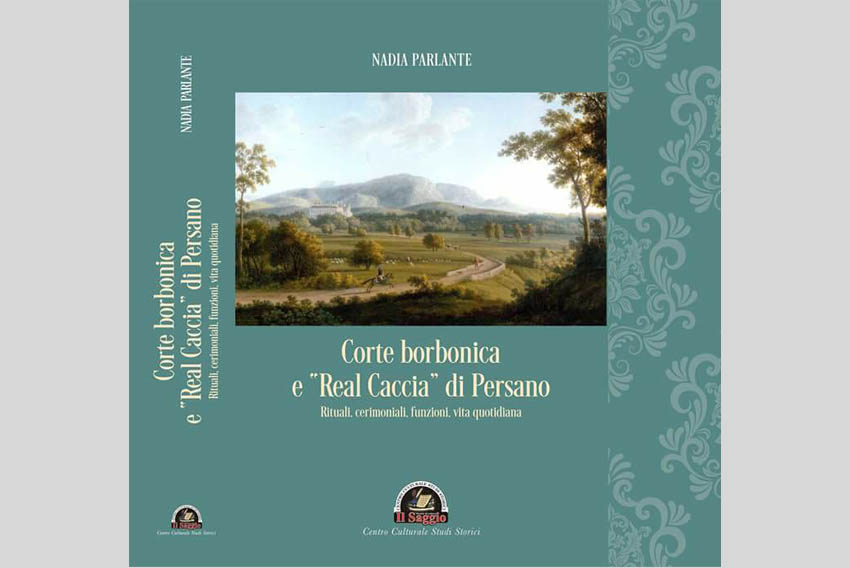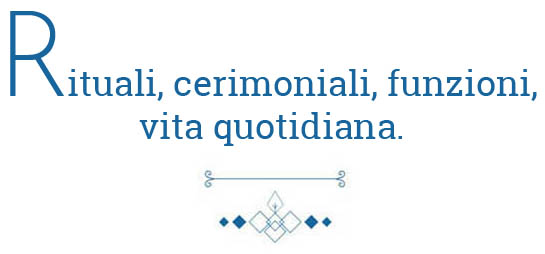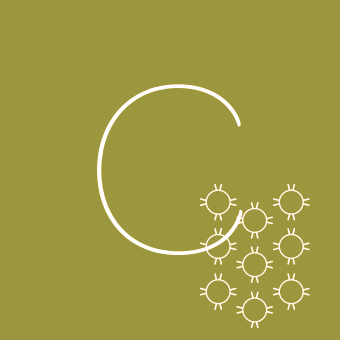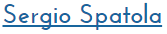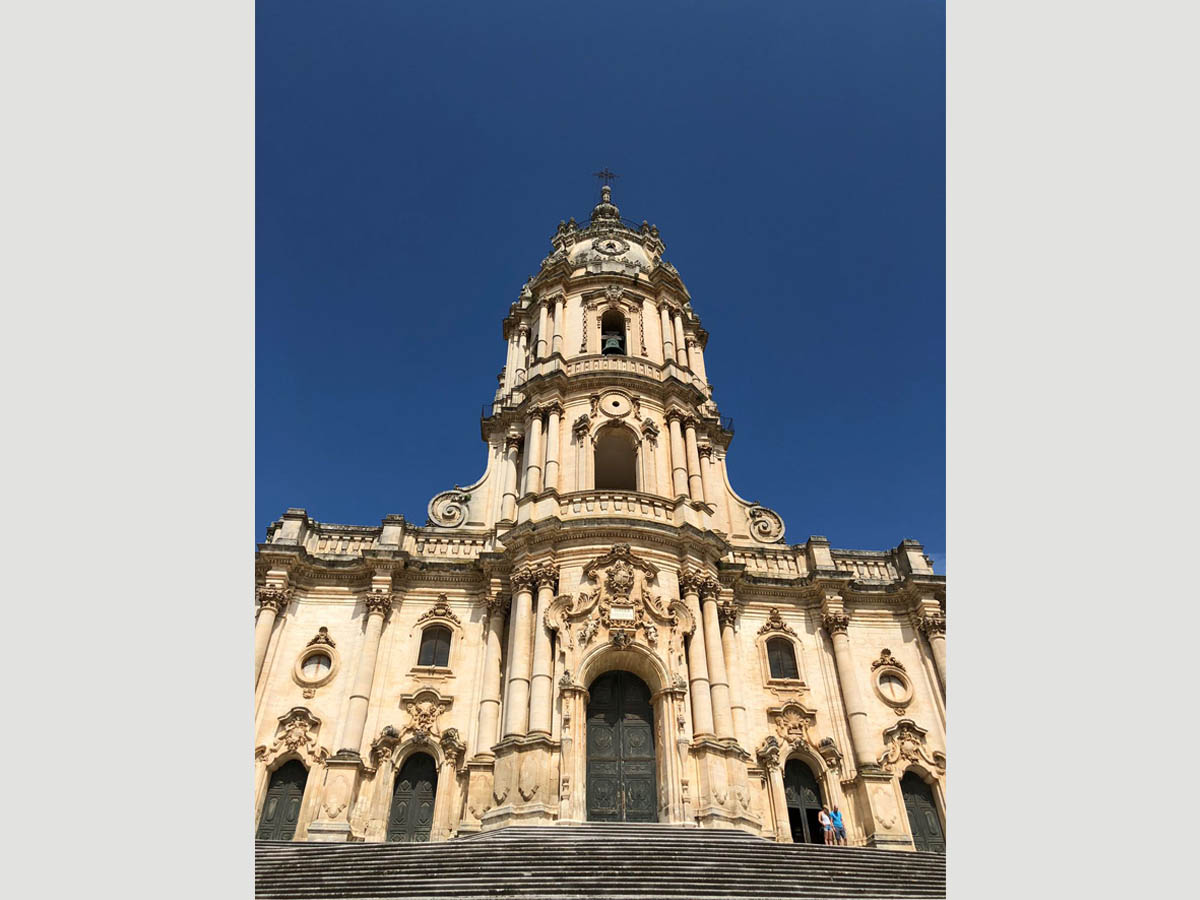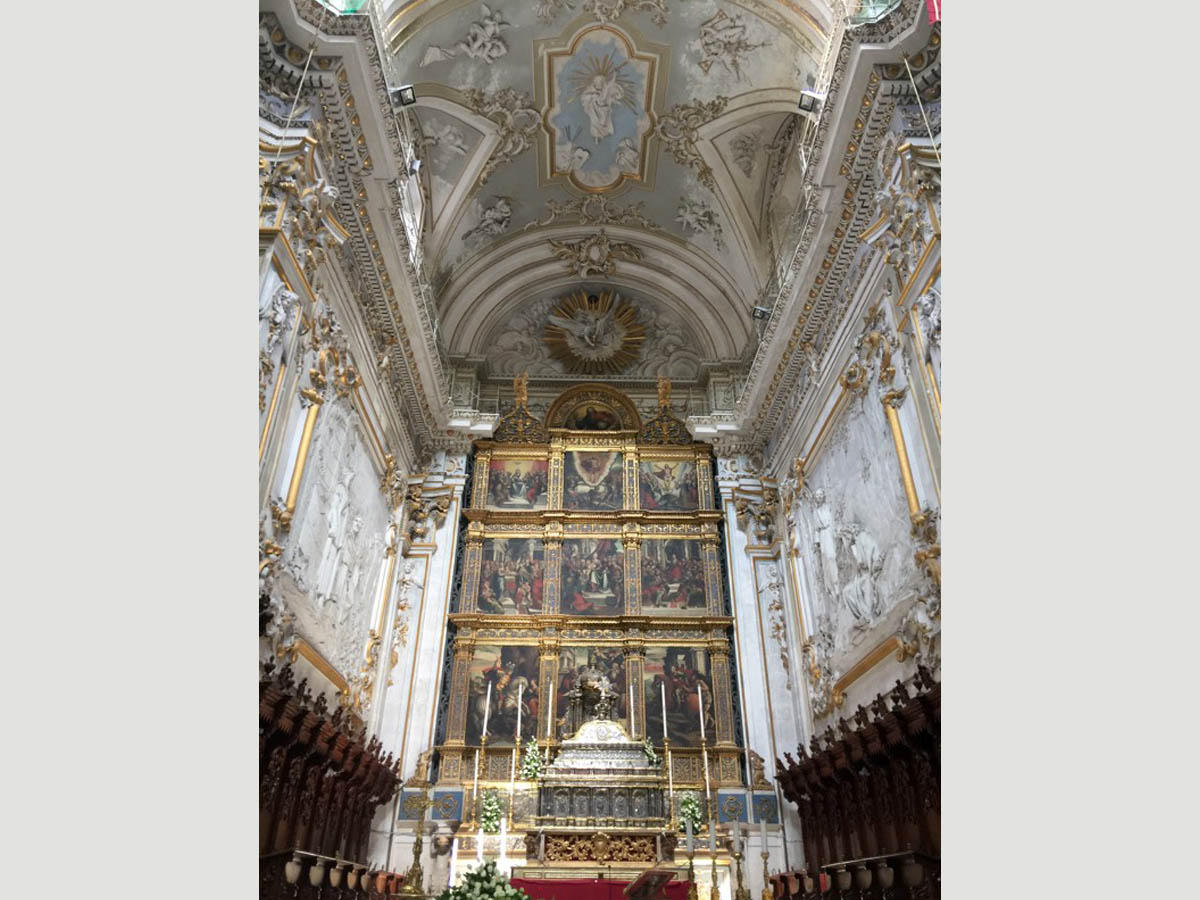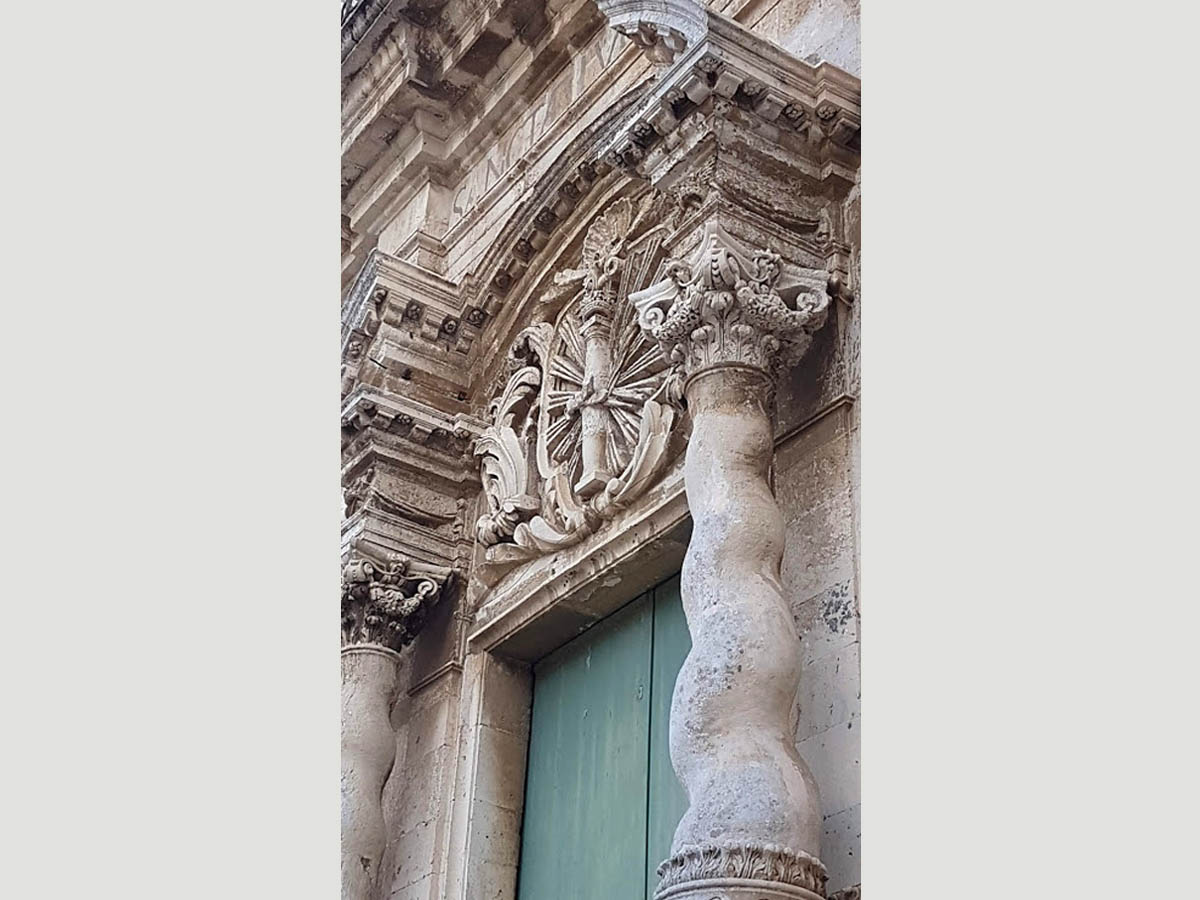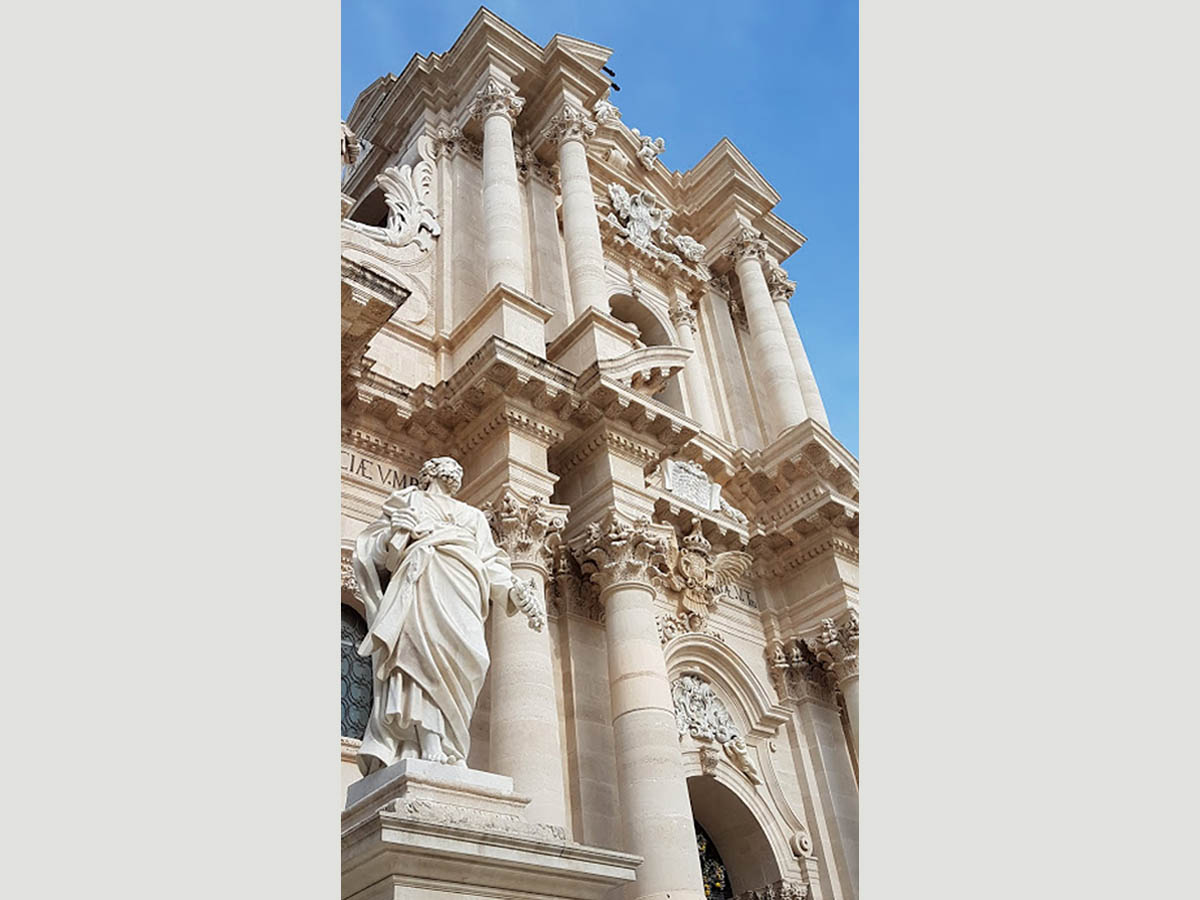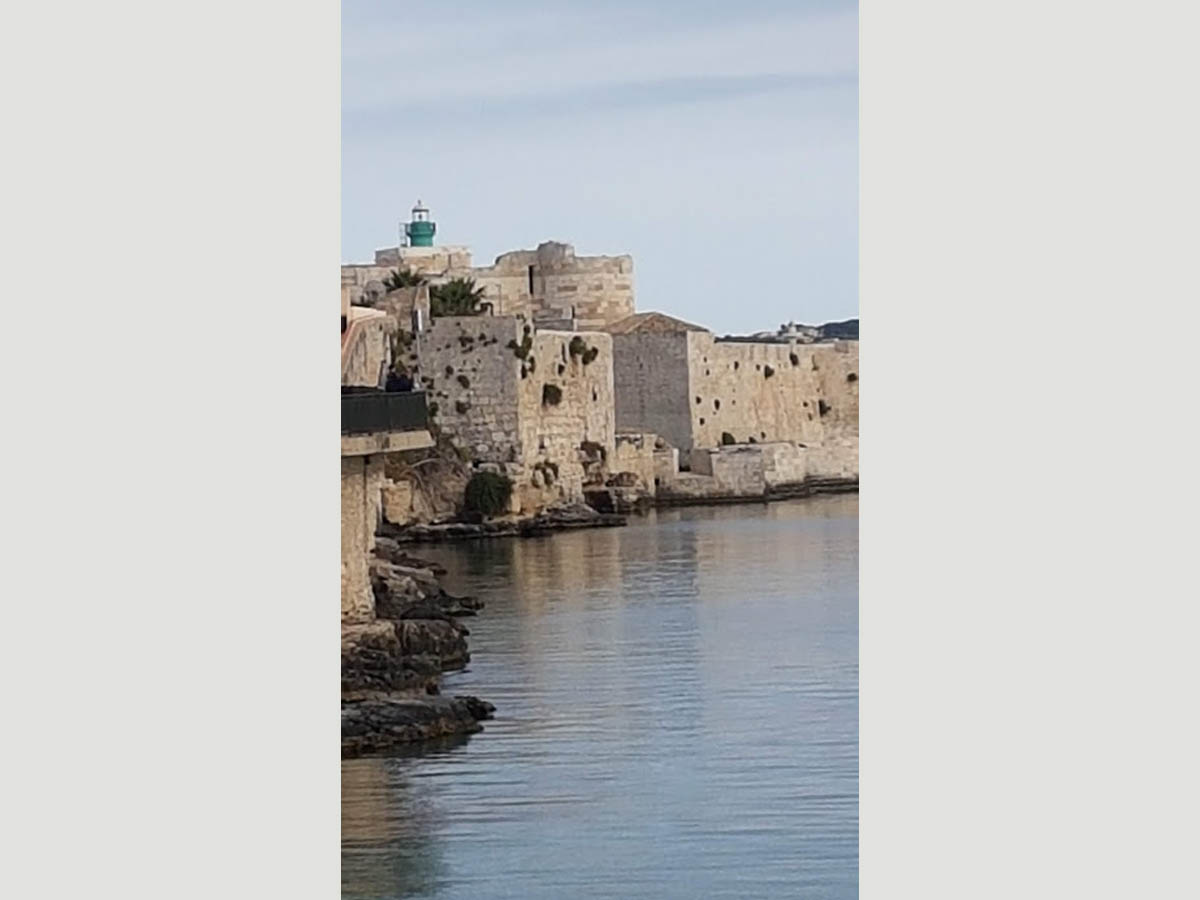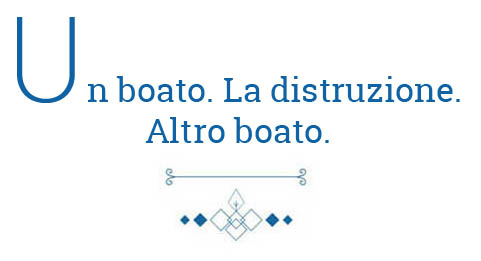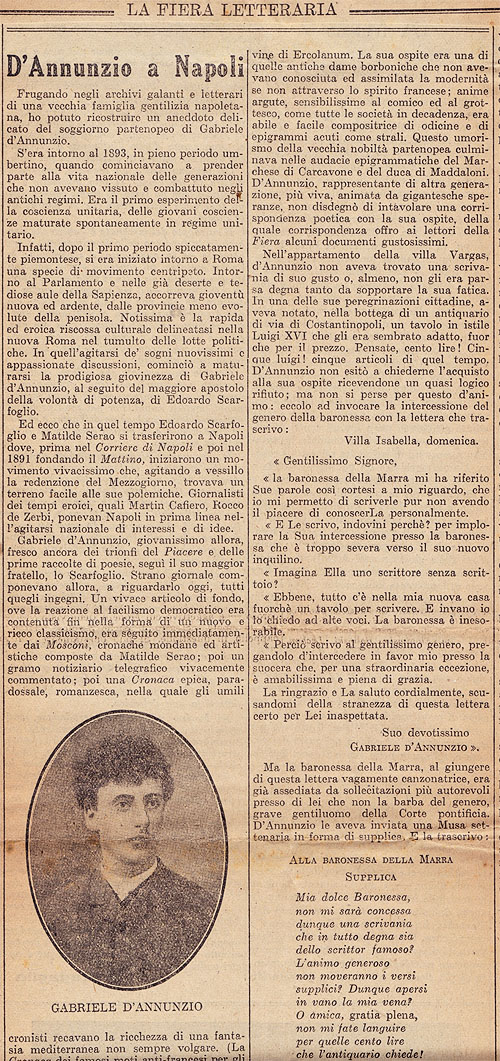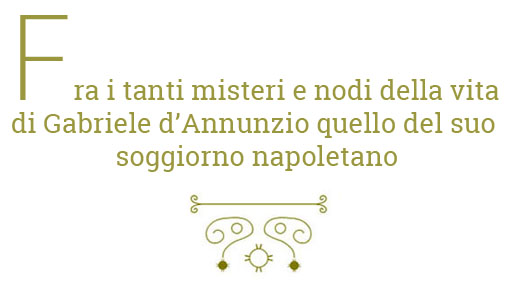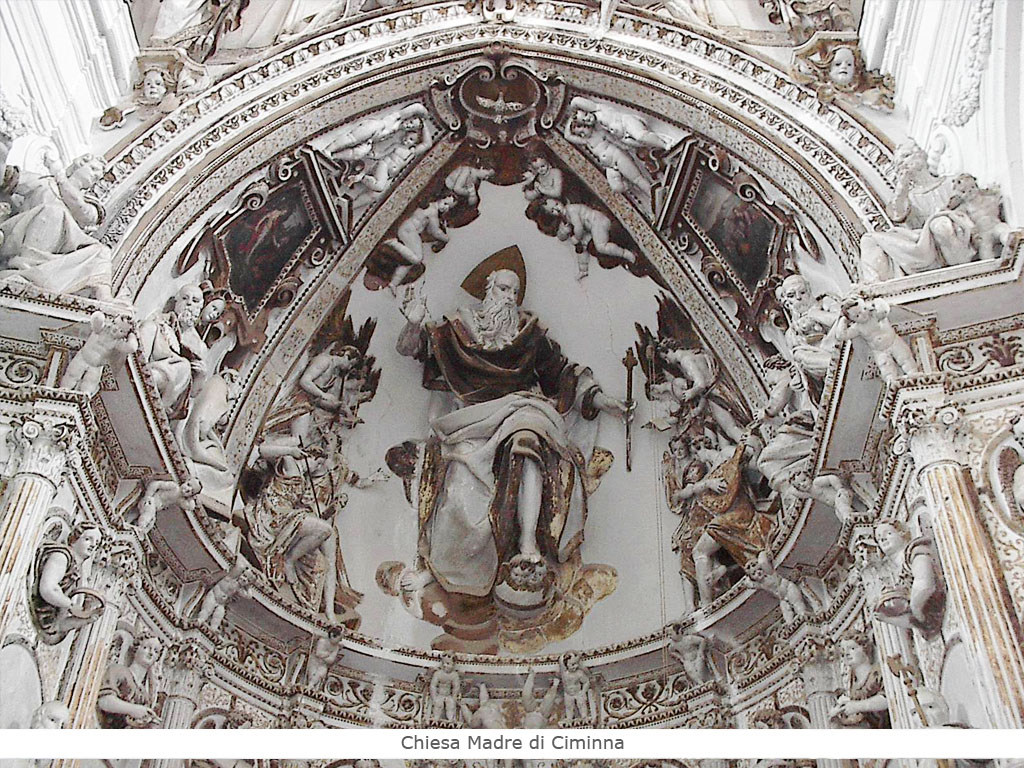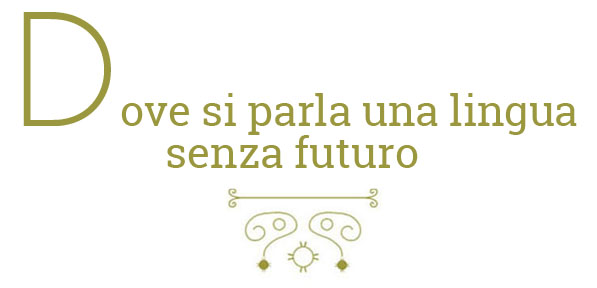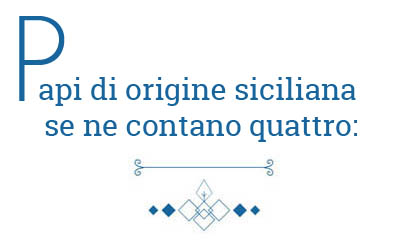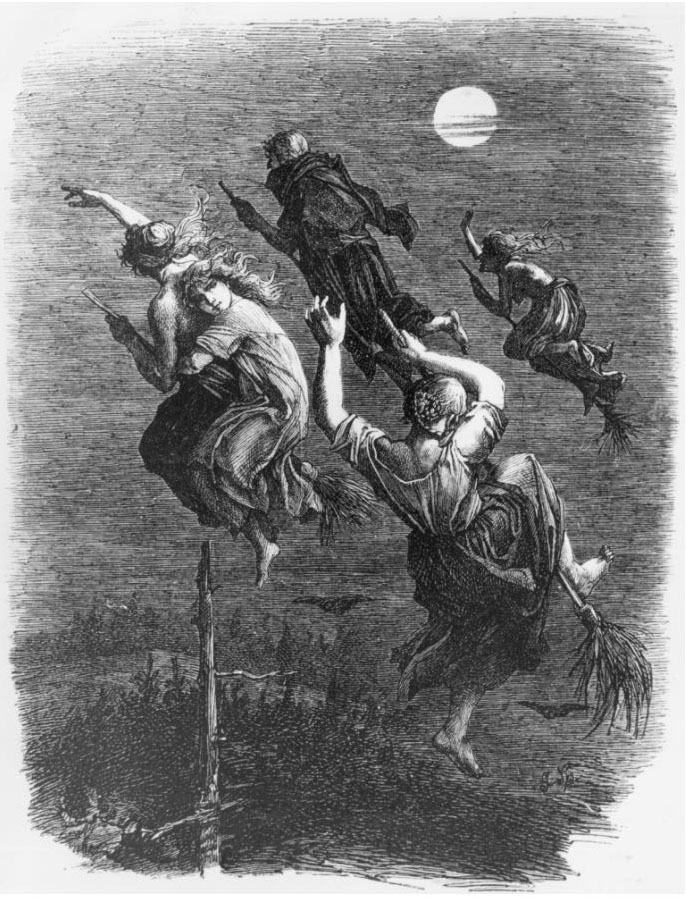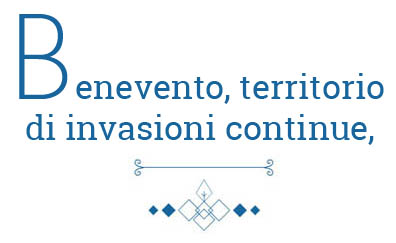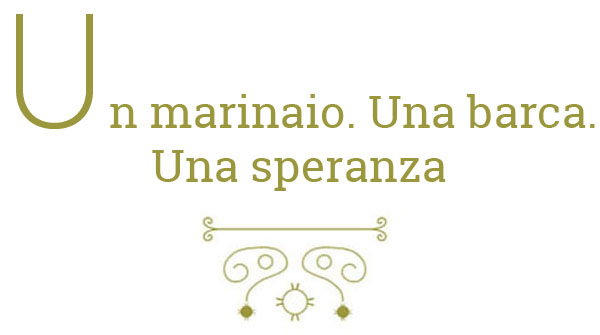AUDENO, VESCOVO DI CASSANO
Il foglietto è tuttora conservato nel Liber ma da una più attenta lettura si evince che a consacrare l’altare il 6 settembre 1578 fu sì un “episcopus cassanensis”, ma non l’Owen, bensì Giovanni Battista Serbelloni che resse quella diocesi dal 1561 fino alla rinuncia avvenuta nel 1580.
Al parroco prealpino era evidentemente nota la storia antica
della lontana diocesi calabra
ed era a conoscenza che, dal 1553 fino all’Owen, era stata illustrata da tre eminenti prelati legati a Carlo Borromeo. Con il santo arcivescovo i tre intrattennero strettissime relazioni anche familiari: Gianangelo Medici, zio del santo, eletto poi pontefice con il nome di Pio IV; Matteo Sittico Altemps, cugino del Borromeo e, dopo la sua rinuncia, Giovanni Battista Serbelloni.
In queste brevi note sembra buona cosa riproporre la figura dell’Owen,
vissuto in un periodo tra i più tormentati della storia d’Europa
e della Chiesa, che proprio nella Diocesi di Cassano
attuò alcune delle più significative novità
successive al Concilio di Trento.
Nasce a Llangadwaladr, nell’Anglesey, dunque gallese, il 28 dicembre 1533. La sua educazione si forma a Winchester e al New College di Oxford, diplomandosi nel 1558 dottore in diritto civile, nell’atmosfera torbida della restaurazione cattolica tentata da Maria Tudor; ma la carriera di docente avviene in concomitanza con l’avvento al trono di Elisabetta. Non accetta l’Atto di supremazia e ripara nelle Fiandre.
Nominato alla cattedra di diritto civile e canonico nella nuova Università di Douai
col titolo di regius professor, prevosto nel capitolo di Cambrai, dal suo arcivescovo viene inviato a Roma per discutere un delicato affare giuridico e svolge l’incarico
con tale competenza che papa Gregorio XIII lo trattiene, intuendo le sue capacità soprattutto nell’attuazione dei decreti tridentini riguardanti i seminari.
Diventa referendario dell’una e dell’altra Segnatura. Era attivo a Roma, dal 1362, l’Ospizio inglese della SS Trinità e di S. Tommaso, meglio conosciuto sotto il nome di Ospizio dei Pellegrini inglesi in via Monserrato: Owen convince il pontefice a trasformarlo in Collegio-Seminario rendendolo aderente alla realtà del momento storico. Nell’autunno del 1579 Carlo Borromeo è a Roma, conosce Owen, ne apprezza le qualità e lo porta con sé a Milano, nominandolo suo confessore e quindi vicario generale, affidandogli la riforma dei seminari, incarico che svolgerà con impegno guadagnandosi l’apprezzamento dell’arcivescovo che lo definisce “ottimo personaggio e mio amico carissimo e come fratello”. Sono ambedue vicini a Maria Stuarda, l’infelice regina che dimostra stima per il gallese. Incarcerata, scrive a Carlo Borromeo chiedendogli preghiere e l’arcivescovo risponde confortandola. Avviandosi alla conclusione così si esprime: “Lewis Audoeno, mon vicaire, m’a dit que votre Majesté désiderait vivement que la recommandasse à Jésus Christ”. Si dice a disposizione ma quando nel 1587 Maria sarà decapitata, egli sarà da tempo nella tomba.
L’attenzione della Curia romana su Owen non era mai mancata e il 3 febbraio 1588 papa Sisto V lo nomina vescovo di Cassano, oggi Cassano all’Ionio, dominio spagnolo. Consacrato il 14 febbraio, parte il 26 marzo per la sua “montagnosa Diocesi calabrese”. Amministrarla non era impresa facile. A parte l’estensione
del territorio popolato da latini ed albanesi di rito greco, il vescovo godeva anche
del temporale dominio su Mormanno e Trebisacce con la giurisdizione
“in criminalibus” eccettuati due casi, “videlicet ubi venit imponenda
poena mortis et mutilationis membri”.
In quell’estremo lembo della penisola non erano stati pochi i vescovi che vi avevano soggiornato con scarsa continuità; non così Owen, che sente l’importanza dell’incarico e, memore degli insegnamenti controriformisti borromaici, si impegna anzitutto sull’istruzione dei preti, organizza il IV Sinodo Diocesano, conduce la prima Visita pastorale al territorio, istituisce la Congregazione per l’insegnamento della dottrina cristiana, l’orazione delle “Quarant’ore”, il registro dei poveri, fonda diverse Confraternite di laici e altre iniziative di uguale peso. Secondo il dettato tridentino era teso alla razionalizzazione della diocesi di cui il seminario doveva essere struttura portante. Già nel 1565 nel sinodo indetto dal vescovo milanese Giovanni Battista Serbelloni si erano nominati quattro ecclesiastici per avviarne la costruzione, ma evidentemente non se n’era fatto nulla perché il suo successore Tiberio Carafa lo fondava per decreto nel 1588. L’Audeno (il nome sarà sempre latinizzato) lo conferma e passa immediatamente all’organizzazione entrando nel concreto e stabilendo in 12 il numero dei seminaristi. Nella sua Diocesi, il Nostro ha lasciato anche tracce lapidee. Sul piede del fonte battesimale della cattedrale di Cassano e sulla parete di fianco è conservato il suo blasone definito dagli esperti “di sobria eleganza geometrica, triangolato col capo alle tre stelle in fascia” assai raro nell’araldica italiana. Lo stemma è riportato su una formella lignea applicata nella parte bassa del vicino altare. Un terzo bell’esemplare del blasone si reperta su una parete esterna dell’antico seminario di Mormanno
Nel 1591, grazie ai buoni rapporti con papa Gregorio XIV, ottiene per la Diocesi
di Cassano, alcune indulgenze perpetue conservate in una pergamena
con sigillo datata 10 maggio 1591.
In quei giorni doveva trovarsi a Roma perché il papa stesso il 20 giugno gli comunica la nomina a Nunzio Pontificio in Svizzera. Il vescovo obbedisce ma senza nascondere una certa riluttanza perché, dichiara, era necessario seguire le iniziative del concilio tridentino felicemente avviate in Cassano: si nota ancora una volta quale peso abbiano avuto su di lui gli insegnamenti borromaici ai quali si ispirava la sua azione riformatrice. Ciononostante, parte per la nuova destinazione e a Bologna incontra il cardinale Ottavio Paravicini che era stato Nunzio in Svizzera negli ultimi quattro anni e gli presenta un fosco quadro della situazione in quel paese. Fa cenno soprattutto alla irrisolta questione del pagamento dei mercenari da parte della corte papale, ragion per cui gli svizzeri, se il debito non fosse stato saldato, avrebbero rifiutato di accogliere un altro Nunzio. Roma viene messa al corrente e ordina il rientro con grande sollievo di Owen come si evince da una lettera nella quale parlando della Svizzera, il paese che avrebbe dovuto accoglierlo, afferma che “l’aria freddissima, il brusco et barbaro proceder et la conversatione soldatesca di quella natione haveria bisogno di complessione di ferro, d’età manco di 60 anni, et di Nuntio che saperia fare il buon compagno et supportare il brindisi di molte hore, et d’esser quasi mezzo-soldato alle volte con loro”.
Nel 1592 è ancora lontano da Cassano perché risulta al seguito di papa Aldobrandini, Clemente VIII, nella visita alle chiese di Roma con l’incarico di esaminare la preparazione teologica degli ecclesiastici. Avrà a fianco Ludovico de Torres, l’eminente e coltissimo arcivescovo di Monreale, in quei giorni impegnato nella liberazione di Torquato Tasso che, al presule, dedicherà due sonetti.
Secondo alcuni storici dopo queste nuove esperienze l’Owen non avrebbe più fatto ritorno nella sua diocesi calabra. Pare non sia così se dà corso ad un’altra iniziativa di profondo significato sociale, la fondazione, il 24 novembre 1593,
del Monte di Pietà nel borgo di Papasidero
(dal greco “Papas Isidoros”, capo di una comunità basiliana), organismo dalla duplice finalità. Lo statuto del Monte e il relativo regolamento per il maritaggio delle ragazze povere sono contenuti in un manoscritto apografo, copia ottocentesca dell’originale. Sono 52 gli articoli che definiscono la costituzione dell’organismo caritativo-assistenziale, e 12 quelli del maritaggio. Dopo la morte di Owen, avvenuta a Roma il 14 ottobre 1595, la diocesi cassanese sarà gestita da altri personaggi eminenti e la sua storia ecclesiastica si misurerà con quella civile. Un’opera inedita conservata manoscritta nella Biblioteca nazionale di Vienna, opera di Francesco Cassiano de Silva datata 1693, ne racconta brevemente la storia così concludendo: “Fu Marchesato dei Signori Sanseverini, hoggi è della nobile Famiglia Serra Genovese, e co’ suoi Patrizj 284 Fuochi li ha’ numerati la Regia Corte”.
ameno paese dell’alto lago Maggiore in Diocesi di Milano, ad un tiro di schioppo dal confine elvetico, un parroco alla fine dell’Ottocento annotava di aver rinvenuto, durante lavori di restauro ad un altare dell’antica Canonica, un foglietto stinto e scarsamente leggibile attestante la consacrazione della mensa da parte di Ludovico Lewis Owen, “episcopus cassanensis”.