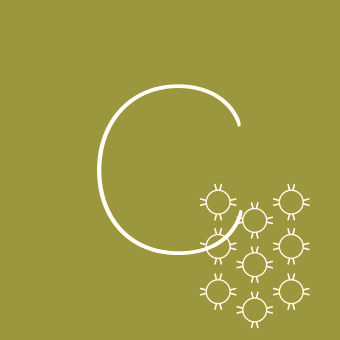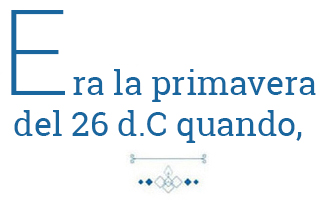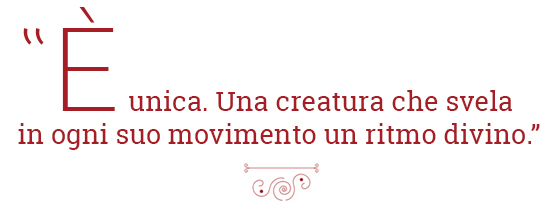AVEZZANO L’AIA DEI MUSEI

tra l’antico ed il contemporaneo, un’operazione culturale riuscita ed il mecenatismo degno di questo nome rendono l’Aia dei Musei un imperdibile luogo dove approdare.
Il tutto deve essere condito da impegno, straordinaria forza di volontà e amore per quello che è intorno a noi, che spesso vediamo senza guardare.
Quando cultura e comunicazione rendono con efficacia le correlazioni tra territorio, tradizione, innovazione ed informazione, ecco allora
l’Aia, nome evocativo di un luogo di incontro e di lavoro, di tradizioni custodite
e storie raccontate, dello stretto rapporto tra uomo e ambiente, oltre che
della particolare ricchezza dell’Abruzzo in questi ambiti.
Nel caso dell’Aia dei Musei, polo museale di recente impianto, ecco come una struttura culturale degna di questo nome interconnette storia ed attualità. L’occasione per guardare con attenzione all’impresa così brevemente accennata viene da una mostra temporanea, “Sculture a colori”. L’esposizione porta ad Avezzano il movimento artistico chiamato “Cracking Art”, che connette un ‘prima’ così lontano ed un ‘oggi’ grazie alla relazione tra l’ambiente e l’artefice delle sue trasformazioni, utilizzando, per l’opera di creazione, il riciclo di materiali inquinanti.
La contingenza di una mostra d’arte contemporanea, degno tributo di un mecenate che non delude mai, rende evidente una storia durata quasi duemila anni:
quella del Lago del Fucino.
Terzo bacino per grandezza in Italia, al centro, nel corso della storia, di importanti progetti di ingegneria idraulica, da quello di Giulio Cesare fino a quello del banchiere Alessandro Torlonia (divenuto principe grazie al completamento dell’opera cui si accennerà), il bacino era destinato ad essere prosciugato per farne risaltare le potenzialità agricole.
Esso, infatti, per le caratteristiche geofisiche – prime fra tutte la mancanza di un emissario che potesse farne defluire le acque – era soggetto ad eccessivi sbalzi volumetrici che non permettevano di creare stanziamenti agricoli in una terra conosciuta per la fertilità.
Il progetto pensato da Giulio Cesare, assassinato prima di poter iniziare i lavori,
fu portato ad un primo completamento dall’Imperatore Claudio
che creò un emissario artificiale sotterraneo per salvare gli abitanti dalla risalita di quasi 12 metri del livello delle acque. Le manutenzioni, necessarie per il tipo di pietra impiegato, erano tante e tali che, alla caduta dell’impero per l’avvento delle orde barbariche, il sito venne lasciato in stato di abbandono, riconsegnando il livello delle acque all’imprevedibilità delle condizioni atmosferiche.
Fu nella metà dell’Ottocento che venne data la concessione di ripristinare
le opere claudiane ad Alessandro Torlonia
il quale, per essere riuscito nell’impresa di bonifica, non solo ottenne le terre strappate alle acque, ma venne titolato principe da Vittorio Emanuele dopo la dichiarazione di avvenuta bonifica del 1878. Le parole di Alexandre Dumas del 1863 rendono più di ogni racconto: “Il principe Alessandro Torlonia portò a termine un’opera ideata da Cesare, ritenuta impossibile da Augusto, tentata da Claudio, rilanciata invano da Adriano e Traiano e che, nel corso di diciassette secoli, aveva vanificato gli sforzi di Federico di Svevia, Alfonso I d’Aragona, i dubbi Colonna e Ferdinando IV, che valeva la pena fare una deviazione di qualche chilometro per ammirare quel lavoro dell’antichità, che, se avesse saputo come farlo, l’avrebbe chiamato l’ottava meraviglia del mondo”.
Questa la storia raccontata oggi in uno dei due musei dell’Aia, chiamato, per l’appunto, “Il Filo dell’Acqua”.
Con la mostra “Cracking Art”, l’Aia dei Musei, luogo ricco di storia e tradizioni,
si trasforma in una variopinta e contemporanea Arca di Noè, con sculture
di conigli, orsi, lupi, elefanti, tartarughe e chiocce come simbolo
di rappresentazione di tutte le specie e del potere che viene loro attribuito.
Il messaggio che arriva allo spettatore è di un’impellente
necessità di rigenerazione della natura stessa.
Come il luogo in cui è realizzata è stato trasformato dall’uomo per il miglioramento della vita di chi vi abitava, così questa mostra innovativa sottolinea come l’utilizzo di materiali considerati deleteri per la flora e per la fauna possa essere destinato alla creazione di opere d’arte. Le “sculture a colori”, realizzate da un gruppo di artisti che si definiscono crackers, fanno entrare il pubblico in un mondo surreale composto da forme e colori diversi.
Il messaggio del ‘prima’ e del ‘dopo’ è quello secondo cui l’attività umana plasma oggetti e materiali, trasformandoli in capolavori portatori
di un profondo messaggio di rinnovamento.
Il coronamento di tanta forza evocativa si deve, ancora una volta, alla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dall’illuminato Emmanuele Emanuele, che ha avuto modo di affermare come “la sede espositiva ancora poco nota rispetto alla sua bellezza […] merita sicuramente di essere conosciuta, e che la Fondazione intende contribuire a farla diventare un nuovo polo di eccellenza per l’arte contemporanea”.