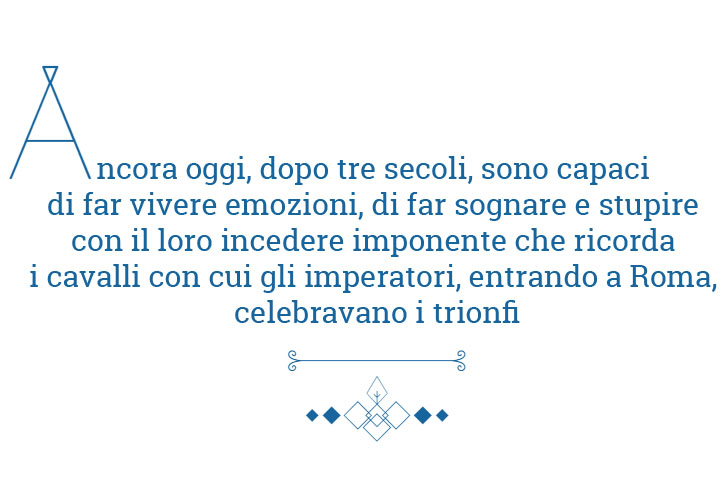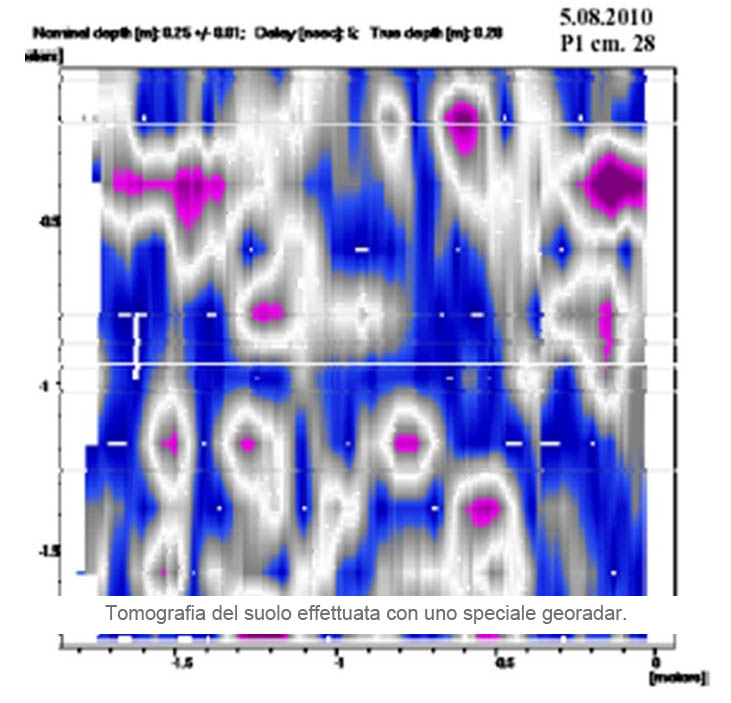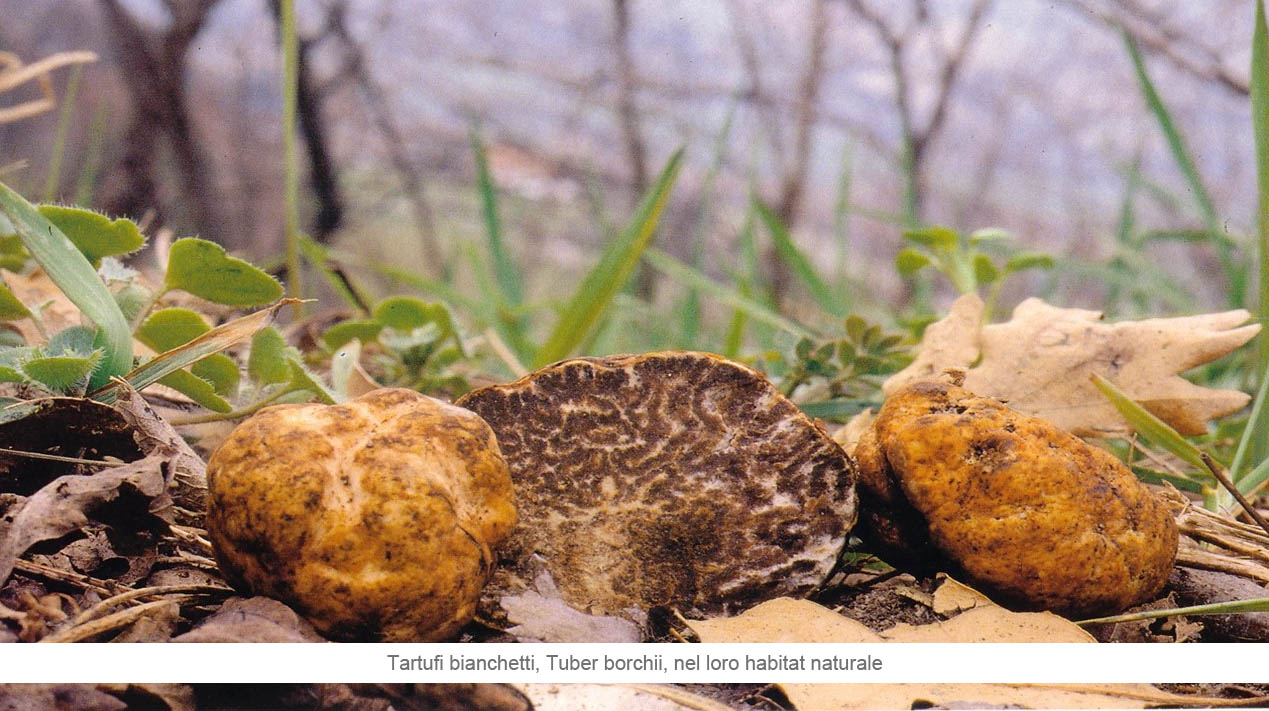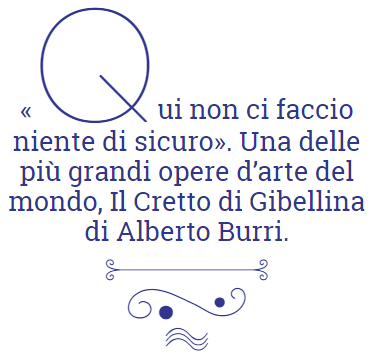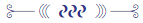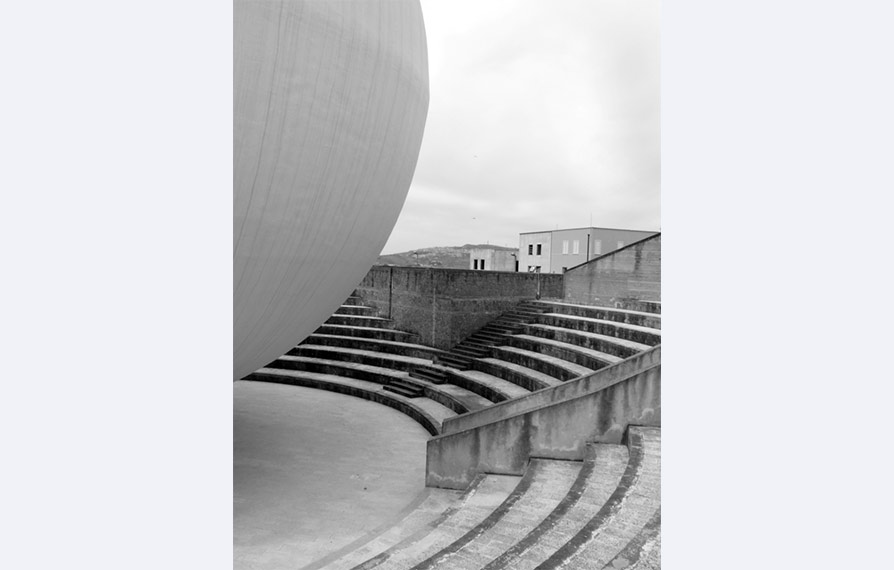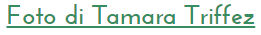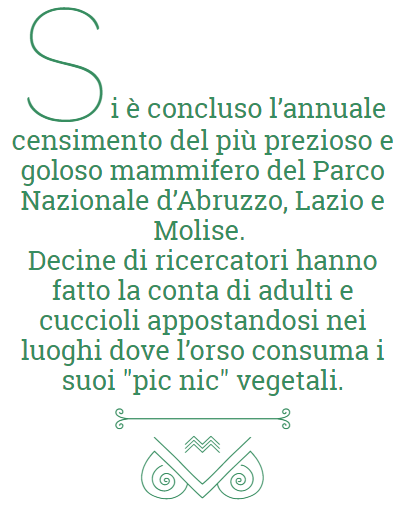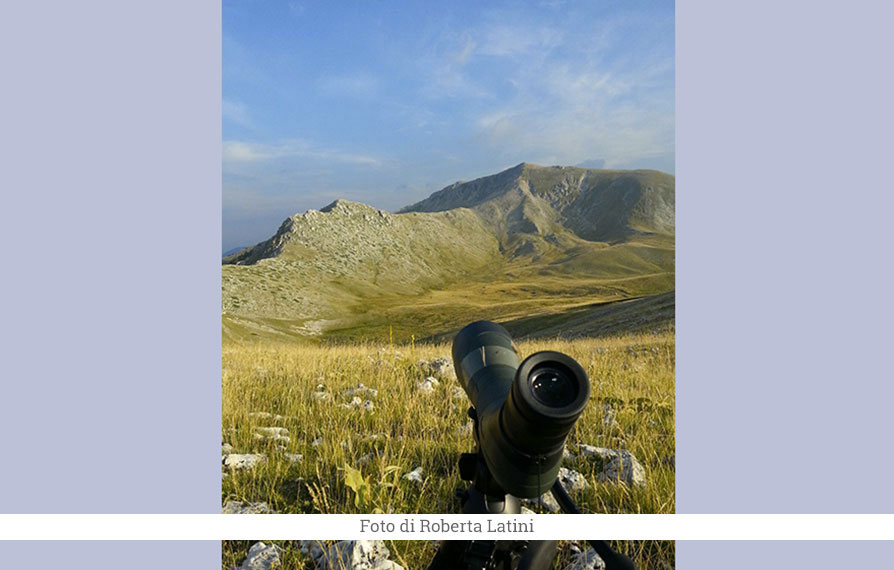La manna dunque fece il suo ingresso nella storia come cibo celeste e dono divino, caricandosi da subito di una spiritualità che l’accompagnerà sino ai giorni nostri come simbolo dell’alleanza tra l’uomo in cammino e Dio che si prende cura di lui. Durante l’attraversamento del deserto la manna cadeva abbondante ogni giorno e gli Ebrei, come racconta il sedicesimo libro dell’Esodo, la raccoglievano “ciascuno secondo il suo bisogno”. Al mattino del sesto giorno ne cadeva il doppio, perché il settimo giorno – lo Shabbat, istituito proprio la prima settimana di caduta della manna – gli Ebrei dovevano rispettare il riposo. Tuttora nelle case ebraiche, quando si prepara il cibo per il sabato, si cuociono due pagnotte, chiamate Challot, che vengono riposte fra due panni di cotone uno sopra e l’altro sotto per ricordare lo strato di brina che ricopriva al mattino la manna nel deserto.
Oggi, anche senza levare gli occhi al cielo, è possibile visitare un luogo dove si trova questo alimento preziosissimo. E’ il Parco delle Madonie, in Sicilia, alle spalle di Cefalù e a un golfo di distanza da Palermo: dal tronco dei frassineti che vi crescono si estrae la manna sin dai tempi della dominazione araba, tra il nono e il decimo secolo.
Da allora la coltivazione dei frassineti si estese in tutte le regioni del centrosud fino ai monti della Tolfa nel Lazio e alla Maremma, e nel 1500 vi venne imposto un dazio doganale per aumentare le entrate del Regno. Oggi invece la manna si raccoglie solo in Sicilia, tra Pollina e Castelbuono, Cefalù e San Mauro, Geraci e Isnello. Ormai la superficie coltivata è ridotta e in pochi praticano l’antico mestiere dello “Ntaccaluoru”. La manna è dunque la linfa estratta dalla corteccia di una varietà di frassino chiamato Orniello. Il frassinicoltore attende che la pianta entri nel periodo di quiescenza estiva fino a spingerla allo stress idrico quando il terreno completamente asciutto si stacca dalle radici e le foglie verdi cominciano a virare verso il giallo. Quello è il momento per la prima incisione che viene praticata a circa dieci centimetri da terra con un coltello chiamato “mannaruolu”. Dalla metà di luglio alla fine di settembre, ogni mattina, si fanno le “ntacche” a distanza di un paio di centimetri l’una dall’altra:
dai tagli fuoriesce una melata azzurrina prima amarognola e poi dolce che, a contatto con l’aria e al sole della Sicilia, diventa bianca
e prende la forma di piccole stalattiti, o cannoli.
La manna a cannolo è la più pregiata perché priva di residui. Poi c’è la manna in sorte (o manna di pala) che è quella che si va a depositare sulle pale di ficodindia disposte alla base del tronco. E per finire la manna rottame che scorre lungo la corteccia e viene staccata con la “rasula”. I cannoli di manna vengono messi ad asciugare, prima, all’ombra e, poi, al sole su degli stenditoi per far loro raggiungere il giusto grado di umidità. Infine, viene inscatolata in appositi contenitori di legno riposti in luoghi asciutti e pronti per la vendita.
Le proprietà curative della manna erano conosciute sin dai tempi
della scuola di medicina di Salerno.
Essa è in primo luogo un blando lassativo privo di effetti collaterali e molto indicato in età pediatrica. A differenza della senna (o cassia) contenuta in tutti i lassativi in circolazione – che alla lunga può causare problemi anche seri – la manna agisce contro la stipsi attirando acqua nell’intestino e facilitando dunque lo svuotamento del colon. E’, poi, un regolatore e rinfrescante delle vie intestinali in quanto è in grado di purificare l’apparato digerente da tossine, parassiti intestinali e residui di cattiva alimentazione. E’ un fluidificante emolliente, sedativo della tosse e un dolcificante naturale a basso contenuto di glucosio e fruttosio indicato per i diabetici. La manna si assume a pezzetti, sciogliendoli in bocca oppure diluendoli in una tisana o nel tè.
Dal 2002 la manna è dal un Presidio Slow Food con un proprio disciplinare di produzione che ne garantisce la provenienza e la qualità.
La “Manna eletta delle Madonie” rientra nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del ministero delle politiche
agricole e forestali.
Il Presidio coinvolge sette produttori che usano il moderno sistema del filo di nylon su cui cola la manna, novità introdotta nella metà degli anni ‘80 che ha rivoluzionato la tecnica di raccolta consentendo di ottenere molto più prodotto puro di quando gran parte del raccolto scendeva lungo la corteccia riempiendosi di numerose impurità. Oltre ai sette produttori del Presidio, ce ne sono altri, qualche decina, fra cui parecchi anziani che lavorano alla vecchia maniera. Il raccolto complessivo è di 300-400 chili all’anno. Il presidio ha aiutato i produttori anche nella vendita diretta che prima non era possibile in quanto l’intero prodotto veniva conferito alla grande industria senza possibilità di contrattare sul prezzo. Per avere un’idea: il costo della manna-cannoli è di 16 euro per 50 grammi e di 8 euro per 20 grammi di prodotto. La manna da drogheria invece ha un prezzo di 18 euro circa per 100 grammi.
La manna è leggera e se ne produce un chilo con tre o quattro piante a stagione. Profuma di macchia mediterranea, ha un gusto fra il dolce
e il lievemente amaro con un retrogusto di mandorla o miele
e un colore tra il bianco e il giallo caramello a seconda
del cultivar e del terreno.
Con la manna si fanno dolci, liquori e saponi (una importante casa cosmetica francese la impiega come componente della crema per le mani). Interessante è poi il suo impiego in cucina: nei ristoranti di Castelbuono si può gustare il filetto di maialino nero in crosta di manna con mandorle e pistacchi. Il pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro, circa 20 anni fa, ha creato il Mannetto, dolce molto particolare ricoperto di una candida glassa di manna. Provare per credere.

LA MANNA DAL SUD
Ma cos’è la manna? Se lo chiesero – “Man Hu?” letteralmente in ebraico: “cos’è?” – anche gli Israeliti in fuga dall’Egitto verso la Terra Promessa quando videro cadere dal cielo quel cibo sconosciuto che Dio aveva mandato loro per sfamarli e che da allora fu chiamata, appunto, “ManHu”.