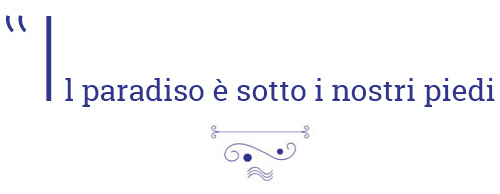IL MEDITERRANEO AFFASCINA E CORROMPE
che affascina e che corrompe”.
Ad affermarlo è stato Sebastiano Tusa, prima della tragedia aerea che lo ha portato via nel 2019, in Etiopia. Palermitano, archeologo, docente di archeologia subacquea all’Università tedesca di Marburg e di Paleontologia alla Scuola Suor Orsola Benincasa di Napoli, Tusa è stato, in primis, lo straordinario Soprintendente del Mare della Regione siciliana.
La Soprintendenza del Mare venne istituita nel 2004
con il fine di tutelare e valorizzare i beni culturali, ambientali e le risorse archeologiche sottomarine, con compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari siciliani e delle sue isole minori.
Ma torniamo a Tusa ed al suo Mediterraneo “che corrompe”.
Corrompe perché impone a chi abita le sue coste una notevole capacità
di adattamento alle diverse morfologie esistenti; e perché la facilità
con cui permette gli scambi e le relazioni provoca contaminazioni,
“corruzioni” in senso positivo e talvolta anche negativo.
Tra le scoperte più importanti di Sebastiano Tusa, l’esatta localizzazione della battaglia delle Egadi, lo scontro navale con i Cartaginesi che concluse la prima guerra punica a favore dei Romani, il 10 marzo del 241 a.C.. Per una sorta di strano scherzo del destino, proprio il 10 marzo l’incidente mortale ci ha privati per sempre del nostro archeologo del Mediterraneo,
un mare “esso stesso un museo, il Mare Nostrum”, come usava dire.
Già. Il Mare Nostrum, come lo chiamavano i Romani, è da sempre “culla di civiltà”, sin dalle prime forme di sedentarietà nelle culture pre-neolitiche (come quella natufita in Palestina) e poi con i progressi successivi verso società più evolute.
Oggi come allora il Mediterraneo, “mare tra le terre”, crogiuolo di colori e di costumi, è il punto d’incontro di Europa, Asia e Africa. Sulle sue coste si possono trovare oltre venti fra Paesi e territori, che parlano più di venti lingue e credono nelle tre grandi religioni monoteiste (cristianesimo, ebraismo ed islamismo).
Queste civiltà che si sono succedute nel Mediterraneo hanno lasciato vestigia
che fanno parte del patrimonio culturale mondiale e vanno assolutamente preservate, nella consapevolezza del fondamentale valore della varietà e molteplicità culturale.
Pensiamo alla Libia, dove si trova uno dei più grandi centri romani del Mediterraneo, Leptis Magna, o al suo corrispondente greco, a Cirene. Ma anche alla Turchia, al Marocco, passando per Siria, Giordania, Israele, Libano, Egitto, Tunisia ed Algeria. I Paesi della sponda Sud-orientale del Mediterraneo sono custodi di testimonianze uniche di millenni di storia che, insieme a quelle inestimabili nei Paesi della sponda Nord, formano il maggior giacimento culturale del mondo.
Non a caso, i Paesi mediterranei raccolgono oltre la metà
dei siti dichiarati“patrimonio dell’umanità” dall’Unesco.
Un capitale artistico, storico e culturale che, oltre a costituire idealmente un’identità comune, può diventare anche un fattore aggregante e determinante per lo sviluppo, in un prossimo futuro, di tutta l’area.
La protezione del passato, oltre al valore “archivistico” e conservativo,
diventa quindi la premessa per costruire un futuro migliore.
È questo uno degli aspetti della cooperazione internazionale che l’UNESCO ha promosso in tutto il mondo, con l’aiuto di organizzazioni intergovernative tra cui spicca l’ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali), organismo per la conservazione e la protezione del patrimonio culturale mondiale. L’ICCROM è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguito dei bombardamenti che avevano distrutto un’impressionante quantità di beni culturali. I suoi obiettivi principali erano quindi rappresentati dalla conservazione, dalla salvaguardia e dal restauro di quanto la tragedia bellica aveva distrutto.
Oggi lo sguardo dell’ICCROM sul futuro è simbolizzato anche
da un programma che riguarda le fondamentali questioni
di conservazione preventiva e gestione del rischio.
Un tema, questo, particolarmente sentito poiché le guerre purtroppo non accennano a fermarsi e le stesse calamità naturali tendono ad aumentare. Pensiamo al terremoto che ha sconvolto L’Aquila, città d’arte per eccellenza, o al bombardamento di una città patrimonio culturale del mondo come Dubrovnik, o ancora al traffico illegale di reperti e beni artistici dell’isola divisa di Cipro. Esiste una lista di patrimoni dell’umanità in pericolo, compilata dall’UNESCO, per instabilità politica, guerre o calamità naturali, che lo scorso anno vedeva Stati come la Libia, la Siria, l’Egitto e la Palestina (considerando solo quelli dell’area mediterranea) con molti dei loro siti sotto minaccia.
Diventano dunque
sempre più attuali i temi trattati sin dal Forum sulla “Protezione e conservazione
del patrimonio culturale nel Mediterraneo”, promosso nel 2012
dall’Ordine di Malta, dall’isola di Cipro, dall’UNESCO
e dalla Commissione Europea,
che hanno dedicato una riflessione importante proprio all’impatto delle catastrofi naturali e dei conflitti sul patrimonio culturale. Il Mediterraneo, quindi, non solo quale giacimento di ricordi carichi di valore, ma anche luogo da progettare per il futuro, per tutelare un patrimonio culturale che è anche risorsa economica da preservare e valorizzare: un “Mediterraneo culturale” davvero idem sentire.
In un’epoca in cui deboli sono le economie dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, solo un fronte unico, con consapevolezza e valori comuni, può rendere
il Mediterraneo àncora come nel mondo antico, vero baricentro
dello sviluppo culturale internazionale.
Al tempo stesso, come richiesto dall’Ordine di Malta, occorre comprendere in questo programma comune anche il rispetto per la dignità umana, la democrazia, il ruolo del diritto, la solidarietà, la giustizia e la tolleranza. E la libertà religiosa, una delle chiavi principali per consentire a tutte le altre libertà di esistere.
È in questi valori che si deve cercare una nuova coesione. L’uomo mediterraneo, cui dobbiamo l’ineguagliata scuola universale della Grecia antica o dell’Italia rinascimentale, con il suo individualismo non è riuscito finora a unificare l’impegno verso una prospettiva comune, ma ha anzi portato un fattore di debolezza. Si deve invece ripartire da un Mediterraneo comune, per costruire una base del nostro futuro e non solo rimpiangere il nostro passato.
Un mare, eccezionalmente raccontato da Fernand Braudel nella sua opera fondamentale La Méditerranée, mentre era prigioniero in un campo di detenzione durante la Seconda Guerra Mondiale: “Che cosa è il Mediterraneo? Mille cose insieme.
Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi
di mari. Non una civiltà, ma molte civiltà, disseminate le une sulle altre…
un crocevia antichissimo.
Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. E piante.” E oltre a questo, è il più ricco, di storia, cultura, dinamismo e fascino, di tutti i mari della terra.
È da qui che tutti Paesi del Mediterraneo debbono ripartire per tornare a casa, tra mythos e logos, come novelli Ulisse che cercano la via del ritorno, del nostos. Anche se stanno affrontando continue tragedie, solo Paesi uniti saranno in grado di superare le Scilla e Cariddi del nostro tempo, per ritrovare alla fine il loro mitico, antico mare. Perché, citando nuovamente Braudel: “Essere stati è una condizione per essere”.