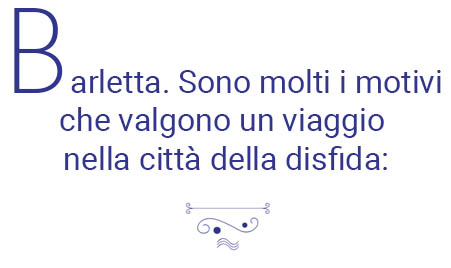LA PINACOTECA “GIUSEPPE DE NITTIS” a BARLETTA
il fascino austero della cattedrale, la severità marziale del castello, l’aura di corrucciata enigmaticità del Colosso. E anche Palazzo della Marra, splendida dimora aristocratica ceduta al demanio dello Stato nel 1958: un edificio elegante, che oggi ospita la Pinacoteca De Nittis.
Come si vedrà più avanti, questa collezione di quadri è uno dei più toccanti attestati d’amore che, per interposta persona, un artista abbia mai tributato alla propria terra natia.
Già, perché Giuseppe De Nittis, tra i più originali protagonisti della pittura europea dell’800, nacque il 25 febbraio del 1846 proprio a Barletta. Qui trascorse l’infanzia e la prima adolescenza fino al 1860, quando si trasferì a Napoli. Perse il padre prematuramente: dovette così imparare a rendere conto al fratello maggiore Vincenzo, a discuterci, a negoziare con lui le prospettive del proprio futuro. La diffidenza del nuovo capofamiglia rispetto al «mestiere dei disperati» non fu evidentemente abbastanza coriacea ed impenetrabile da impedirgli di iscrivere Giuseppe all’Istituto di Belle Arti. Nondimeno l’indole inquieta e burrascosa dell’apprendista generò presto conflitti con i vertici dell’Accademia, da cui venne espulso come un imbrattatele privo di stoffa artistica.
Eppure, gli anni napoletani furono determinanti nella formazione tecnica di De Nittis, che nel 1863 aderì, a Portici, alla cosiddetta “Scuola di Resina” e divenne sodale dei suoi fondatori: Marco De Gregorio e Federico Rossano. Privilegiò la pittura en plein air. Gli esordi in Campania consentirono a Giuseppe di scoprire e nutrire la sua passione per la natura e per i paesaggi, passione di cui si trova traccia nei suoi Notes et Souvenirs sotto forma di ammissione di debito e devozione sconfinata:
«La natura, io le sono così vicino! L’amo! Quante gioie mi ha dato! Mi ha insegnato tutto: amore e generosità». Il trasporto, la brama di conoscere i misteri della terra,
il desiderio tenace di capire, abbracciare, riprodurre le «belle nubi», le sfumature
del cielo e persino i colori dell’aria:
tutto questo entrò nel suo bagaglio per il trasloco a Parigi, dove giunse per la prima volta nel 1867. Nella capitale francese, ancora sfavillante prima della disastrosa guerra contro la Prussia, conobbe Léontine Gruvelle, la futura moglie che ebbe grande parte nell’introdurlo negli ambienti culturali più innovativi; alcuni dei massimi interpreti dell’Impressionismo, come Édouard Manet o Edgar Degas con i quali strinse amicizia; soprattutto il mercante d’arte Adolphe Goupil che intuì subito il talento del giovane e sconosciuto italiano, al punto da legarlo a sé con un accordo di esclusiva stipulato nel 1872.
Tramite l’esercizio, talora invadente, delle proprie pretese di controparte contrattuale, Goupil premeva sull’artista affinché, in una prima fase di produzione pittorica, rappresentasse panorami e soggetti del Mezzogiorno d’Italia: le atmosfere quasi esotiche, le tinte vivaci e i mondi rurali con biche e trulli solitari, così lontani dalla frenesia della ville lumière, catturavano l’attenzione e solleticavano la curiosità dei facoltosi compratori americani, che consideravano Parigi come la piazza principale per i loro acquisti d’arte. Quando invece la mondanità parigina e le frivolezze della Belle Époque si imposero come oggetto esse stesse di una promettente narrazione figurativa, Goupil sollecitò il Maestro al cambiamento. Fu così che, nel 1874, De Nittis realizzò una delle sue opere più celebri e accattivanti,
Che freddo!, un gruppo di donne investite da un gelido vento invernale,
che gli fruttò l’appellativo di “Peintre des Parisiennes” (pittore delle parigine)
e che soprattutto fu venduto per la cifra astronomica di diecimila franchi
Quel guadagno da capogiro rese Goupil quasi pazzo di gioia e persuase De Nittis che era giunta l’ora di voltare le spalle al suo passato italiano per immergersi totalmente nel suo definitivo presente francese. A questa nuova fase produttiva appartengono molte delle tele esposte a Barletta. Tra le tante meritano di essere citate: Figura di donna (Léontine De Nittis) del 1880; Il salotto della principessa Mathilde del 1883, pregevolissimo racconto di un momento di festa dell’alta società; Colazione in giardino del 1884 e la Signora con gattino nero, del 1880, la quale colpisce per l’avvenenza e il sorriso negli occhi.
Il pittore lavorò instancabilmente, anche per sostenere l’elevato tenore di vita cui aveva abituato la sua famiglia e se stesso. E viaggiò molto: tornò spesso in Italia, approdò a Londra che gli permise altre conoscenze ed inesplorati orizzonti di ricerca, rivide la sua Barletta che omaggiò il suo figlio illustre con una medaglia d’oro. Morì a Saint Germain en Laye, anche lui precocemente come suo padre, il 21 agosto del 1884.
La pinacoteca illustra chiaramente l’evoluzione artistica di Giuseppe De Nittis.
Il percorso espositivo è ricchissimo di opere, frutto del generoso
lascito testamentario disposto da Léontine, vedova,
in favore della città che aveva dato i natali
al suo Giuseppe:
portano la data del 3 Novembre 1912 le ultime volontà di colei alla quale oggi Barletta deve così tanto. Un’antologia di meraviglie che, seppure provvisoriamente, si è arricchita di un altro capolavoro del Maestro pugliese, forse il suo dipinto più commovente: La Strada da Napoli a Brindisi. Completato nel 1872, dopo un’impegnativa serie di disegni preparatori, fu esposto al Salon di Parigi di quello stesso anno. Recava il numero di serie 1177 della Maison di Adolphe Goupil, il quale ne era entusiasta e vi riponeva grandi aspettative di guadagno: rimase oltremodo deluso, come ammise furente in una lettera a Léontine, quando seppe che la piccola tela aveva ricevuto solo una menzione speciale anziché un premio vero e proprio. Ad ogni modo, l’11 ottobre 1872 riuscì a venderla, per milletrecento franchi, ad un magnate americano che, per l’acquisto, si servì di un prestanome per scongiurare incrementi di prezzo: fu così che la Strada da Napoli a Brindisi prese la via dell’America e, sempre restando dentro i confini statunitensi, passò di mano in mano fino ai primi anni Quaranta, quando fu acquisita dalla famiglia dell’attuale proprietario. È lui che ha acconsentito al prestito in favore del museo barlettano, dove oggi si può ammirare, anche se solo fino ai primi mesi del 2025. Dopo, tornerà oltreoceano, all’Indianapolis Museum, dove è custodito in comodato.
Una strada bianca. Molto più che un tratturo: una di quelle arterie volute dai Borboni per connettere tra loro le città. Due contadini avanzano insieme, vestiti dei loro poveri stracci: procedono stanchi, forse si parlano, e sembra quasi di sentirli mormorare nella melodia di uno dei numerosi dialetti pugliesi. E poi una carrozza, trainata da due cavalli: dentro c’è qualcuno, se ne intuisce la gamba sinistra. I contadini ci vengono incontro. La carrozza no: pare allontanarsi, diretta verso Napoli, Brindisi, chissà.
Eppure non siamo soli. Attorno a noi, la languida campagna pugliese, con le sue molteplici tonalità di verde e le sue voci selvagge, mandrie di bovini al pascolo. E poi un corso d’acqua, sarà l’Ofanto, il fiume di cui nessuno parla più se non Orazio nelle sue odi. E poi gli arbusti, i fiori, gli alberi e candide casette lontane: sembrano macchie di biacca, spruzzate qua e là. E poi c’è lui:
l’immenso cielo di Giuseppe De Nittis, la vastità di cui era deciso ad apprendere
i segreti e le potenzialità cromatiche, il reame percorso dalle «belle nubi»,
la divinità eterna nella quale tutti noi, qui al Sud, presto o tardi,
ci perdiamo incantati.
Stornare lo sguardo da un dipinto di De Nittis è come un risveglio.
La sua arte è fatta d’incanto e di emozioni, seduzione e ipnosi, sogni e sentimento. È un’arte in moto perenne, come le nuvole in transito o la vita breve e inquieta di colui che la produsse. Un’arte fatta di momenti e di visioni, di opportunità da cogliere al volo, come il Maestro stesso ci rivela: «una immagine di quella dolce vita da sognatore al quale basta una distesa di cose bianche, una pioggia di neve o una pioggia di fiori. È la vita per la quale son nato: dipingere, ammirare, sognare».