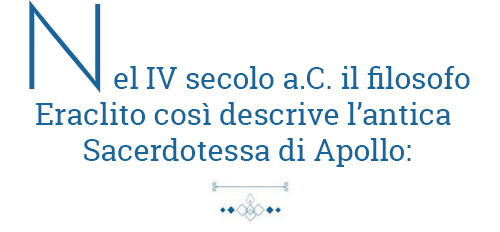LA SIBILLA CUMANA
“La Sibilla con bocca invasata pronunzia cose tristi, senza ornamento né profumi (indice di pessimismo) e attraversa con la sua voce migliaia d’anni (indice di decrepitezza) per opera del nume”.
Non se ne conosce l’etimologia, ma il probabile significato di Sibilla è “Vergine Oscura” proprio perché viveva in luoghi oscuri, luoghi misteriosi e inaccessibili. In ogni caso era una profetessa di sciagure, una misteriosa veggente femminile che svolgeva attività mantica in stato di trance, una figura che incuteva timore e rispetto in tutti.
Fu Marco Terenzio Varrone, nel I secolo a.C., ad elencare dieci diverse Sibille
collocate in regioni geografiche differenti: la Sibilla Persiana, quella Libica,
la Delfica, la Cimmeria, l’Eritrea, quella Samia, la Sibilla Cumana,
quella Ellespontica, la Frigia e la Sibilla Tiburtina.
Erano donne considerate esseri leggendari, mediatrici tra dio e l’uomo, spesso concepite come figlie di divinità e di ninfe, a volte divinità esse stesse. Non immortali, ma miracolosamente longeve, si diceva potessero profetizzare e vivere anche per un millennio. Una antica leggenda ci racconta che dalla città greca di Eritre in Lidia, la Sibilla Deifobe giunse a Cuma, in Campania. Deifobe era dotata di una bellezza straordinaria, a tal punto che Apollo se ne innamorò follemente. Nonostante la Sibilla fosse la “sposa” del Dio, mai si accoppiava fisicamente con lui: la Sacerdotessa, infatti, conservava intatta la sua verginità, poiché
“l’amore” di Apollo nei suoi confronti era solamente un “soffio” trasfuso in lei, conservandola nello stato di verginità.
Ciò nonostante il Dio Febo tentò invano con Deifobe ogni sorta di seduzione, e alla fine pur di averla le promise che, se gli si fosse concessa, le avrebbe esaudito ogni suo desiderio. Deifobe acconsentì, si chinò a raccogliere un pugno di terra, e chiese a Febo di vivere per tanti anni pari ai granelli contenuti nella polvere, che risultarono essere 1.000. Ma si scordò di domandare anche la perpetua giovinezza. Così, con il trascorrere del tempo (complice la promessa non mantenuta di giacere con il dio) divenne sempre più vecchia, raggrinzita, e piccola quanto una cicala, fino a quando di lei ne rimase solo la voce. A chi le chiedeva quale fosse il suo desiderio, da lontano e senza esser vista, rispondeva sconsolata: “La morte!”.
Tra le tante Sibille esistenti, quella Cumana è una delle figure
più inquietanti della mitologia greco-romana.
Il culto di Apollo era allo stesso tempo negromantico e ctonio, aveva a che fare sia coi morti che con il mondo sotterraneo. La Sibilla Cumana fondeva in sé l’elemento iniziatico e negromantico con quello oracolare e furente. La Sacerdotessa (dotata di poteri divinatori concessi da Febo) pronunciava infallibili responsi, e vaticinava in esametri greci scritti su foglie di palma, i quali, mischiati dai venti provenienti dalle 100 aperture del suo Antro, erano resi “Sibillini”.
Il poeta Virgilio ci racconta l’incontro tra Enea e la Sibilla Cumana:
“Un tempo Enea con i suoi marinai giunse sulle coste dell’Italia e al sacro tempio di Cuma dove Sibilla col custode e il sacerdote soggiornava. Lì c’è una porta ianua e orrenda. Enea strappò un ramo d’oro dal bosco e sacrificò pecore nere alla dea dei morti; allora Sibilla procedette per le ombre e per i vuoti regni dell’Orco. Innanzi il vestibolo giaceva lutto e preoccupazione della vigilia; in quel luogo tra i mondi dei vivi e dei morti anche bianche malattie, e la morte con altri mali dei vivi, e pensieri di vita e tormenti, guerra e discordia. Nel vestibolo l’olmo ombroso apre vecchi rami; sotto le foglie si fermano le ombre vane dell’olmo che sono considerate illusioni beate e incubi oscuri che spesso fanno visita agli uomini. Inoltre Enea vedeva molti mostri, vari tipi di belve, tra gli altri i Centauri, Scilla, Chimera e Arpia. L’inquieto Enea sguainò la spada contro i mostri poiché li credeva veri mostri. Ma Sibilla ammonì l’uomo con queste parole” deponi la spada Enea, perché i tuoi occhi fissano ombre, non forme vive”.
La Sibilla per vaticinare traeva ispirazione masticando foglie di lauro
(la pianta sacra ad Apollo) e con libagioni di acqua di Fonte Sacra,
ma soprattutto attraverso il respiro dei vapori effluvii che uscivano
da fenditure del terreno nei pressi dell’Antro in cui viveva, a Cuma,
località posta nella zona vulcanica dei Campi Flegrei.
Quando entrava in trance il dio Febo la possedeva completamente, prendendo il sopravvento sulle sue facoltà superiori dello spirito, sulla ragione, sull’intelligenza e sull’animo, sede della passione e dei sentimenti. Il cambiamento del colore del volto, il petto ansante e il cuore selvaggio che si gonfiava di furore, mostravano una ribellione della Sibilla al dio stesso, che cessava solo quando cessava il furore della possessione, e solo allora la rabbiosa bocca rimaneva quieta perché Apollo l’aveva abbandonata.
Nel 1932 a Cuma, durante una campagna di scavo condotta dall’archeologo Amedeo Maiuri, venne scoperta una grotta che lo stesso identificò come il famoso “Antro della Sibilla“.
Dopo la sua scoperta il Maiuri affermò: “Il lungo corridoio trapezoidale
alto e solenne come la navata di un tempio, e la grotta a volta
e a nicchioni, formano un unico insieme.
Era la grotta della Sibilla,
l’antro del vaticinio quale ci apparve dalla poetica visione di Virgilio e della prosaica e non meno commossa descrizione dell’Anonimo scrittore cristiano del IV secolo”.
All’antro si accede tramite una lunga galleria con 12 brevi passaggi laterali che si aprono sul fianco del colle, da cui filtra la luce. La galleria principale termina in un vestibolo contenente un paio di sedili scavati nella roccia e al di là di essi una camera a volta. Facilmente possiamo immaginare come, nell’imminenza della profezia (il responso di Apollo) i postulanti fossero fortemente emozionati. Erano seduti su gelidi sedili di roccia immersi nei vapori sulfurei. Giacevano nella penombra ascoltando la profetessa rabbiosa che vaticinava nascosta dalla porta che separava il vestibolo dal tempio interno. Erano in uno stato di esaltata aspettativa mistica mista a puro terrore.
Oltre alle folli grida di una vecchia di cui non se ne conosceva l’aspetto,
anche l’effetto ottico e la suggestione all’interno della grotta erano tremendi:
durante il giorno, l’alternarsi di fasci di luce e oscurità originati dai pozzi lungo la galleria, faceva sì che chiunque provenisse dall’interno per condurre i nuovi arrivati al tempio apparisse e scomparisse. Ancora oggi, senza le suggestioni mistiche di un tempo, l’impatto è fantastico, perché si entra in una lunga galleria rettilinea a sezione trapezoidale dove non si riesce a cogliere la fine del percorso. Ed è per questo motivo che si avverte una sorta di sacralità di fronte a questa struttura misteriosa.
La grotta identificata come l’antro della Sibilla ha subito interventi romani e bizantini, ma per il caratteristico taglio trapezoidale della parete, è databile in età molto arcaica, probabilmente risalente alla seconda metà del IV secolo a.C..
Chi oggi visita l’antro percorre un lungo corridoio di 131 mt con nove bracci,
nella parte occidentale di questi, sei comunicanti con l’esterno e tre chiusi.
Verso la metà del corridoio, sulla sinistra vi è un braccio articolato in tre ambienti rettangolari disposti a croce, usati in età romana come cisterne. Sul fondo delle cisterne alcune fosse in muratura e fosse sepolcrali indicano che questa parte della galleria svolse in età cristiana funzione di catacomba. Poco più avanti lungo il corridoio c’è una sala rettangolare. Da qui un vestibolo a sinistra, anticamente chiuso da un cancello, introduce in un piccolo ambiente che si suddivide in tre celle minori disposte a croce. Questa stanza venne interpretata dal Maiuri come l’Oikos Endotatos, in cui la Sibilla, assisa su un trono avrebbe pronunciato i suoi vaticinii.
Recentemente si è ritenuto che l’antro rinvenuto fosse una struttura difensiva. A sostegno di quest’ultima ipotesi vi sono la posizione della galleria posta sotto la sella che unisce l’acropoli di Cuma con la collina meridionale e l’analogia con altre strutture difensive.
Quindi la ricerca dell’antro della Sibilla non è ancora conclusa, ora lo si cerca
nei pressi del peribolo del tempio di Apollo, dove è situato un ambiente
quasi completamente sotterraneo, “la cisterna greca”.
Ma sono tutte ipotesi astratte, in concreto ci assiste sempre il poeta Virgilio che nel VI libro dell’Eneide così descrive l’Antro della Sibilla: “L’immenso fianco della rupe euboica s’apre in un antro: vi conducono cento passaggi, cento porte; di lì erompono altrettante voci, i responsi della Sibilla”.