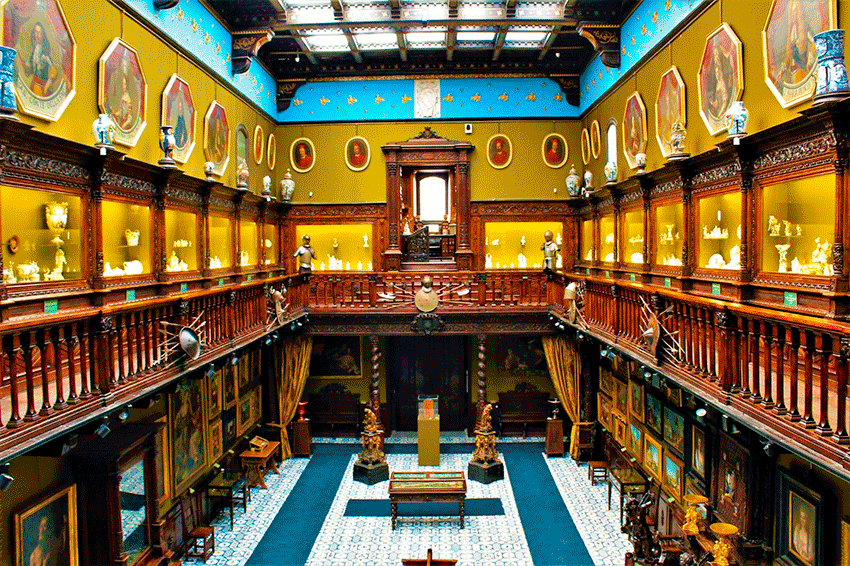Si può certamente affermare senza ombra di dubbio che i tre maggiori operisti italiani che hanno operato nella prima metà dell’800, Rossini, Bellini e Donizetti, hanno avuto con la città di Napoli e con il San Carlo un rapporto speciale in forza del quale hanno raggiunto grandi successi internazionali e confermato ancora in pieno secolo XIX il ruolo di Napoli come capitale europea della Musica e del Melodramma.Diverso è il caso di Giuseppe Verdi.
Si annoverano solo due opere del catalogo verdiano che furono tenute a battesimo
al San Carlo di Napoli: Alzira (1845) e Luisa Miller (1849),
va poi ricordato che Un Ballo in Maschera, commissionato dal San Carlo nel 1856 non poté essere rappresentato a causa delle richieste della direzione del Teatro, la quale, temendo i rigori della censura borbonica, impose al compositore tali e tante modifiche al libretto da indurlo a ritirarsi. Il desiderio di mettere in scena la sua opera spinse comunque il Maestro a prendere contatto con l’impresario del teatro Apollo di Roma, Vincenzo Jacovacci, il quale fu ben lieto della notizia, ma preannunciò che l’opera avrebbe dovuto subire qualche cambiamento per la censura pontificia. Il librettista Antonio Somma esortò Verdi a lasciar perdere e a dare il libretto a Milano dove sarebbe passato indenne in teatro, ma per il Maestro bisognava dare uno «schiaffo» al teatro napoletano, mettendo in scena l’opera «quasi sulle porte di Napoli e far vedere che anche la censura di Roma ha permesso questo libretto».
Occorre ricordare che successivamente i rapporti tra il San Carlo e Verdi migliorarono: infatti il Maestro vi mise in scena la ripresa del Simon Boccanegra nel 1858 e vi rappresentò la prima italiana del Don Carlo nel 1872 andato in scena per la prima volta a Parigi nel 1867. In ogni caso a Napoli furono riproposte subito dopo le prime rappresentazioni, quasi tutte le opere del compositore di Busseto e sempre con grande successo, al punto che tuttora questo repertorio è probabilmente quello più amato e apprezzato dal pubblico napoletano.
Fatta questa premessa, può essere interessante rievocare un altro episodio, non molto noto, della biografia del grande musicista che vede coinvolta Napoli e il suo teatro.
Nel 1873 Verdi è di nuovo a Napoli per la messa in scena dell’Aida andata in scena
al Teatro dell’Opera del Cairo, il 24 dicembre 1871 e poi a Milano
al Teatro alla Scala l’8 febbraio del 1872.
È l’opera che più ha amareggiato Verdi nel corso della sua intera carriera: «Mi ha procurato noje infinite e disillusioni artistiche grandissime». In effetti, il pubblico non aveva apprezzato granché, pur nel rispetto per quello che già allora era già considerato un “Padre della Patria”, ma soprattutto la critica aveva sollevato obiezioni di “imitazione wagneriana”. Per Verdi questo era troppo: «Finire imitatore alla mia età, dopo 35 anni di carriera!».
Durante le prove dell’opera al San Carlo, il soprano Teresa Stolz (già moglie del direttore d’orchestra Angelo Mariani e poi legata da “affettuosa amicizia” con il compositore), ingaggiata per la parte principale, si era ammalata. La prima era stata posticipata, e così
Verdi «nei momenti di ozio all’albergo Crocella» aveva scritto il suo unico
Quartetto per archi, in mi minore, eseguito privatamente in albergo,
presenti non più di sette-otto ascoltatori.
Fra i presenti c’era il corrispondente della Gazzetta Musicale di Milano, sulla quale, pochi giorni dopo, era uscito un grande articolo intitolato
“Un quartetto di Verdi!”.
L’esordio fu affidato ad un ensemble formato dalle prime parti dell’Orchestra del San Carlo: dai fratelli Finto ai violini, Salvadore alla viola e Giarritiello al violoncello.
L’atteggiamento di Verdi nei confronti di questa composizione strumentale fu molto ambivalente: da un lato il Maestro tendeva a disconoscere valore alla sua composizione, negando che essa fosse degna di essere conosciuta dal grande pubblico, dall’altro poteva comunque essere la dimostrazione che il grande operista era in grado di dare dei contributi originali anche nell’ambito della musica strumentale che proprio in quegli anni iniziava a diffondersi in Italia, intaccando il monopolio del Melodramma nei gusti del pubblico.
Basti pensare che nel 1878 gli era arrivata una richiesta da Parma,
in fondo la sua “patria” in cui si chiedeva il permesso di concedere
il Quartetto per l’esecuzione, alla quale egli risponde in modo piccato:
«Sono veramente dolente di non poter aderire a quanto ella domanda. Io non mi sono più curato del Quartetto che scrissi per semplice passatempo alcuni anni or sono a Napoli e che fu eseguito in casa mia alla presenza di poche persone che erano solite venire da me tutte le sere. Questo per dirle che non ho voluto dare nissuna importanza a quel pezzo e che non desidero almeno per il momento renderlo noto in nissuna maniera». Eppure era già stato eseguito a Vienna e a Parigi con successo enorme; stava per essere suonato a Londra, addirittura in una versione adattata per un’orchestra di 80 archi. E l’autore, al quale era stato chiesto l’assenso, lo aveva dato osservando che alcuni temi del primo e del secondo violino sarebbero risultati meglio in versione orchestrale.
Questo atteggiamento così contraddittorio nei confronti dell’unica composizione
da camera del grande operista si inserisce nel dibattito sulla musica strumentale tedesca, molto vivace in Italia fra gli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo.
Nel 1873, mentre componeva il suo unico Quartetto per archi, Verdi si sentiva coinvolto in una sorta di “conflitto musicale” che aveva un fronte interno e uno esterno. Quest’ultimo riguardava ovviamente quanto accadeva fuori dell’Italia nel mondo dell’opera, sotto le insegne del dramma musicale di Wagner e più in generale della cosiddetta “opera d’arte dell’avvenire”, che iniziava a fare breccia anche in Italia. Più singolare, nella prospettiva attuale, il fronte interno. Infatti, dopo il controverso debutto scaligero di Aida, il musicista mostrava spesso di sentirsi “nel mirino”. Non solo e non tanto nell’ambito operistico, nel quale in fondo continuava a non avere rivali, ma in quello della discussione sulla musica strumentale, che stava fiorendo vivacemente in Italia. Carattere forte e ruvido, imperioso e stizzoso, spesso impaziente, Verdi al giro dei suoi 60 anni si sentiva coinvolto al punto da voler condurre una “guerra” in un ambito che non era quello teatrale. E per questo – con intento a suo modo provocatorio e sicuramente polemico – aveva deciso di scrivere un Quartetto.
All’editore Ricordi aveva scritto: «È convenuto che noi italiani non dobbiamo ammirare questo genere di composizione se non porta un nome tedesco.
Siamo sempre gli istessi, noi italiani».
E aveva aggiunto un’annotazione particolare della quale in realtà non era convinto fino in fondo, visto che attenua in maniera senz’altro insolita il suo parere: «Credevo allora e credo ancora, forse a torto, che il Quartetto in Italia sia pianta fuori di clima». Nella stessa lettera spuntava la polemica “ideologica”: «Io vorrei che le nostre società, licei e conservatori, unitamente ai quartetti a corde, istruissero quartetti a voce per eseguire Palestrina, i suoi contemporanei e Marcello». E così anche la famosa frase verdiana, “Torniamo al passato e sarà un progresso”, riletta sotto questa luce assume una particolare evidenza. Il vero punto di riferimento di Verdi per replicare ai “modernisti” era la grande tradizione polifonica italiana del Cinquecento e i suoi sviluppi nella musica del Settecento.
Subito dopo la prima di Aida a Napoli, Verdi aveva scritto alla fedele amica la contessa Maffei, alla quale aveva raccontato che Aida aveva avuto un grande successo, probabilmente più che altrove in Italia, perché «Qui a Napoli non vi sono i critici che la fanno da “apostoli”». Ovvero, apostoli di una nuova religione musicale, della quale il compositore non aveva certo una grande considerazione. E aveva rincarato la dose: «Non c’è la turba dei maestri che sanno di musica soltanto quello che studiano sulla falsariga di Mendelssohn, Schumann, Vagner (sic!). Non il dilettantismo aristocratico che per moda si trasporta a quello che non capisce».
Molto lucidamente il Quartetto esprime chiaramente l’intenzione verdiana di definire una diversa pratica musicale, che sintetizzi nella forma classica un gusto
e uno stile tipicamente italiani, alieni da qualsiasi pedissequa “falsariga”
e imitazione di stilemi ad essi estranei.
Particolarmente significativa, da questo punto di vista, la scelta di concludere la composizione con una Fuga. Che non a caso era la parte cui il compositore teneva di più.
Nel Quartetto, la scrittura della Fuga è stringente, profonda eppure singolarmente lieve. In un primo momento, Verdi aveva pensato di farla precedere da una sorta di recitativo introduttivo. Poi, forse pensando che il tutto sarebbe suonato “sulla falsariga” di Beethoven, vi aveva rinunciato. E l’ultimo movimento era diventato, semplicemente, uno Scherzo-Fuga in tempo “Allegro assai mosso”, con il soggetto affidato al secondo violino chiamato a suonare pianissimo, staccato e leggero. Sorge a questo punto invitabile il paragone con il grandioso Fugato che conclude la sua ultima opera Falstaff (rappresentato nel 1893), quello in cui si dice che “Tutto nel mondo è burla”, lungo un contrappunto di voci e strumenti in 14 parti.
In modo sorprendente e modernissimo la polifonia si fonde con il gesto ironico dell’estrema maturità verdiana in una sintesi che ancora oggi,
a distanza di oltre un secolo, ancora ci sorprende.