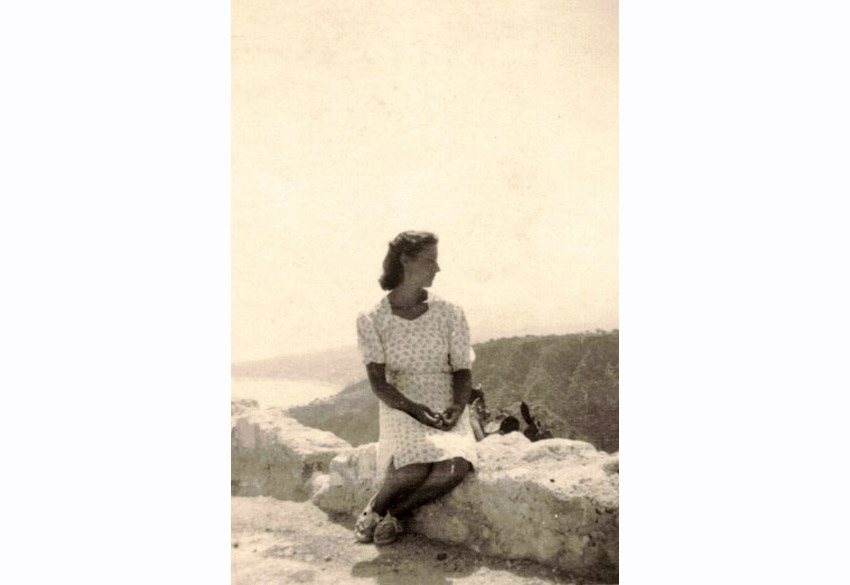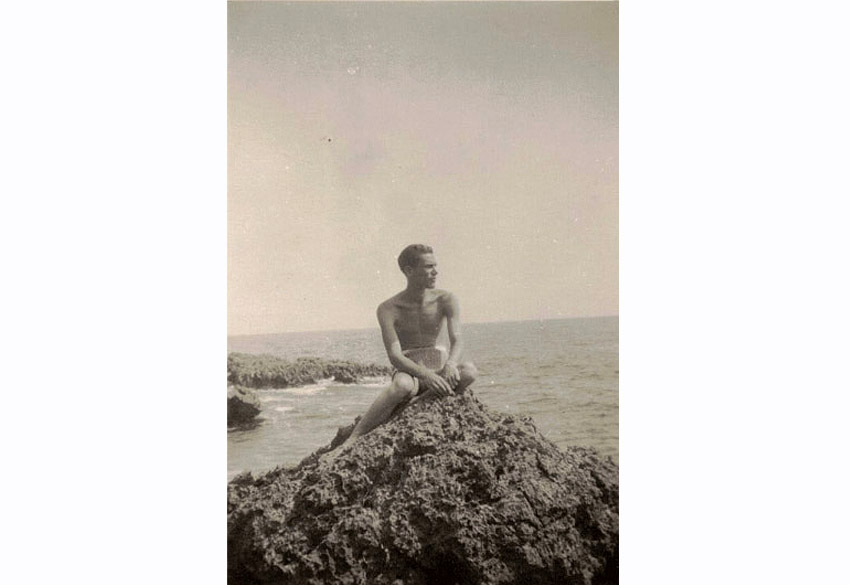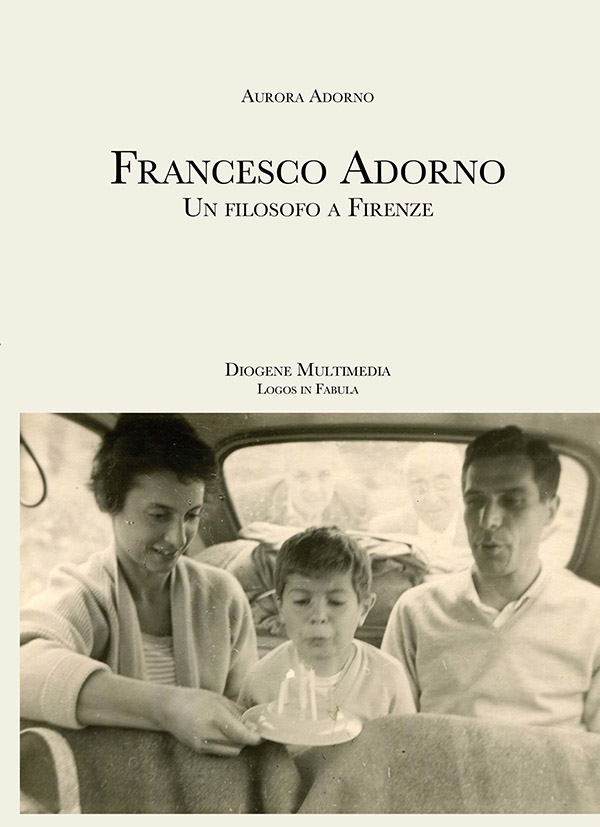UN PAESE, LA SCUOLA, LA MERICA
raccontano che in quel decennio, per effetto di un lungo e lento processo di crescita, Avigliano era diventato un importante paese in provincia di Potenza.
Contava 19.010 abitanti nel 1881, scesi a 18.841 nel 1901. Quello scarto di 169 abitanti non riuscì a compromettere la trama del suo territorio.
La campagna estesa ed ampia con più di ottante frazioni, con la sua economia degli orti e della pastorizia, con quella del seminativo e dei boschi, apparteneva a un principe, venuto da Genova, di nome Doria-Pamphili.
Egli ne aveva concessa molta parte a grandi affittuari borghesi e a piccoli contadini. Questi ultimi che mal sopportavano la burbanza feudale per difendere la loro dignità spesso lo trascinavano in giudizio oppure scioperavano. Per fortuna che quando finivano in tribunale erano difesi gratuitamente da avvocati socialisti o liberal massoni.
Il centro del paese aveva tutt’altre caratteristiche. C’era la pretura,
in cui bene o male, si amministrava la giustizia.
Dai paesi vicini e dalle campagne vi accorrevano avvocati, imputati, testimoni, familiari. Paesani e forestieri con la loro presenza animavano una fitta rete di negozi, di forni, caffè, osterie, trattorie, alberghetti.
Nelle strade cittadine avevano bottega orafi, sarti, calzolai, falegnami, figulai, bottai, maniscalchi. Nelle loro forge essi ferravano zoccoli per cavalli, per asini e muli, predisponevano ruote per carri, carrozze e carriole e per tutto ciò che potesse servire a spostare uomini, donne, famiglie e merci. Famose poi erano quelle botteghe in cui si fabbricavano e si vendevano coltelli a scatto con manici finemente intarsiati e lame affilate e luccicanti. Questo particolare artigianato aveva alimentato la leggenda che gli aviglianesi fossero uomini seri, onesti ma bravi di mano e veloci di coltello quando qualcuno veniva meno alla parola data.
A vivacizzare il paese provvedevano pure vari sodalizi, quello di mutuo soccorso, quello di previdenza e lavoro; poi la società agricola e quella di tiro a segno.
Avvocati, medici, dottori fisici, farmacisti, maestri, e poi braccianti, contadini, scalpellini, muratori, operai, erano iscritti e tutti impegnati in azioni di solidarietà, di mutualismo e cura.
Don Giustino Fortunato, grande intellettuale e meridionalista,
le volte che veniva colto da un qualche attacco di ipocondrìa
era solito vedere nero. E in genere non sbagliava.
Così, quando in Basilicata, negli anni Ottanta dell’Ottocento, si trovò di fronte a una opaca rete di banche popolari, di cooperative di credito, tuonò contro di esse dicendo che la misura era colma e che presto a quel carnevale bancario sarebbe sopraggiunta la quaresima. E così fu. Naturalmente Avigliano non sfuggì alla punizione divina. Era successo che ricchi borghesi pur di improvvisarsi banchieri, avevano chiesto prestiti al Banco di Napoli e li avevano garantiti ipotecando i loro beni immobili e fondiari. Così quando il tribunale dichiarò il fallimento della banca aviglianese, l’istituto di Via Toledo ne incamerò i beni. Su di essi, e sugli altri pervenuti in possesso del Banco per gli stessi motivi, vigilava attento e severo Nicola Miraglia, valente uomo della Terza Italia e meridionale di Lauria, che giustamente e a certe condizioni voleva immettere quote di quel patrimonio sul mercato per movimentarlo.
Fiore all’occhiello e vanto di Avigliano era il suo sistema scolastico.
L’istruzione domestica impartita da eruditi locali o da preti, quella funzionante nel convento e quella che si svolgeva nella scuola pubblica costituivano i pilastri di un solido edificio dove ogni mattina entravano frotte di bambini e bambine. Era il tesoro vivente del paese. I genitori avevano investito molto sul successo scolastico dei loro figli, così pure avevano fatto l’amministrazione locale e i nuclei borghesi che la governavano. Un caso raro in cui nessuna di quelle tre componenti aveva pensato che l’istruzione producesse spostati di capa, ma tutti ritenevano che da quell’edificio potessero uscire solo teste ben fatte come desiderava un filosofo francese Michel de Montaigne.
Ad Avigliano Gioacchino Murat, nel 1809, aveva voluto istituire il Real Collegio, un istituto pubblico per la formazione della classe dirigente regionale, ma aveva ordinato anche l’apertura delle scuole primarie maschili e femminili. La frequenza era gratuita ed il reclutamento delle maestre e dei maestri era in capo al Comune. Iniziava così il lungo, lento e difficile cammino della laicità della scuola elementare.
Nel 1851 Ferdinando II di Borbone volle aprire un ospizio-convitto
per trovatelli, orfani e per i figli di molti padri e di una sola madre.
Re-Bomba volle che fosse consacrato
alla Madonna della Pace.
E così fu.
Col passare dei decenni quel convitto diventò una bella istituzione educativa e formativa con tanti ragazzi bravi ed anche altri che diventarono importanti. In più il collegio mise in piedi una banda musicale che allietava le iniziative pubbliche delle società e dei sodalizi aviglianesi e le funzioni religiose.
Negli anni ‘70 dell’Ottocento gli amministratori comunali tentarono di aprire un ginnasio comunale ma le numerose difficoltà prima di tutto quelle economiche ne impedirono la partenza.
Dalla Scuola di Arti e Mestieri uscirono validi artigiani, orafi, falegnami, ebanisti, intarsiatori, sarti che poi andavano a Napoli a perfezionarsi in altre istituzioni pubbliche o private, fare ritorno al paese oppure emigrare. L’aviglianese Emanuele Gianturco, deputato a volte moderato, più spesso reazionario, l’aveva presa sotto la sua protezione per cui, a quella Scuola, arrivavano libri, calchi in gesso, materiale didattico e di laboratorio, abbonamenti a riviste specializzate. Supporti di tutto rispetto per stare aggiornati e al passo con i tempi. Nelle sue aule studiarono e si addestrarono fianco a fianco ragazzi di Avigliano e ospiti dell’ospizio-convitto offrendo un bell’esempio di integrazione, di reciproco apprendimento e di tolleranza.
Mentre ancora tuonava il cannone nelle campagne tra Turbigo, Boffalora s/Ticino
e Magenta, in quel giugno del 1859, e i feriti facevano ritorno nelle retrovie
come li dipingeva Giovanni Fattori, il conte Camillo Cavour
chiamò a sé l’amico milanese conte Gabrio Casati.
Di lui si fidava più che di Carlo Cattaneo, di Giuseppe Ferrari, o di Francesco Domenico Guerrazzi e non si fidava per nulla di Giuseppe Fanelli, Saverio Friscia, Carlo Gambuzzi. Ordinò al suo amico di mettere giù un testo di legge per le scuole del nuovo Regno. Per la verità il nobile piemontese ignorava ancora quali sarebbero stati i confini della nuova Italia, ma l’idea di fare le scarpe a quel plotoncino di federalisti, di repubblicani e di mazziniani del Nord, Centro e Sud Italia lo eccitava. Casati, forse in omaggio al modello istruttivo, di quello che diverrà in seguito il triangolo industriale, mise giù un testo di oltre 300 articoli dai toni autoritari e accentratori. Venne premiato diventando suo malgrado ministro della pubblica istruzione dal 24 luglio 1859 al 15 gennaio 1860. Lo schema della legge era semplice. Il regio ginnasio e il liceo erano statali (a prescindere dai comunali) perché servivano a preparare la nuova classe dirigente italiana. Una parte consistente dell’istruzione tecnica, commerciale, agraria era affidata al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. La scuola elementare invece veniva graziosamente regalata ai Comuni che su di essa dovevano vigilare, reclutare maestri e maestre, trovare i soldi e l’edificio, arredarlo, riscaldarlo, tenere in ordine e conservare l’archivio scolastico. Delle migliaia di Comuni meridionali non pochi fecero ciò che la legge dettava loro. Avigliano tra essi.
(continua…)
Parte I