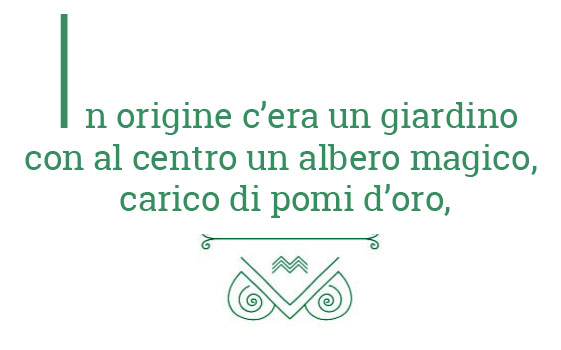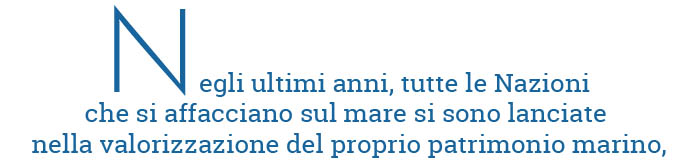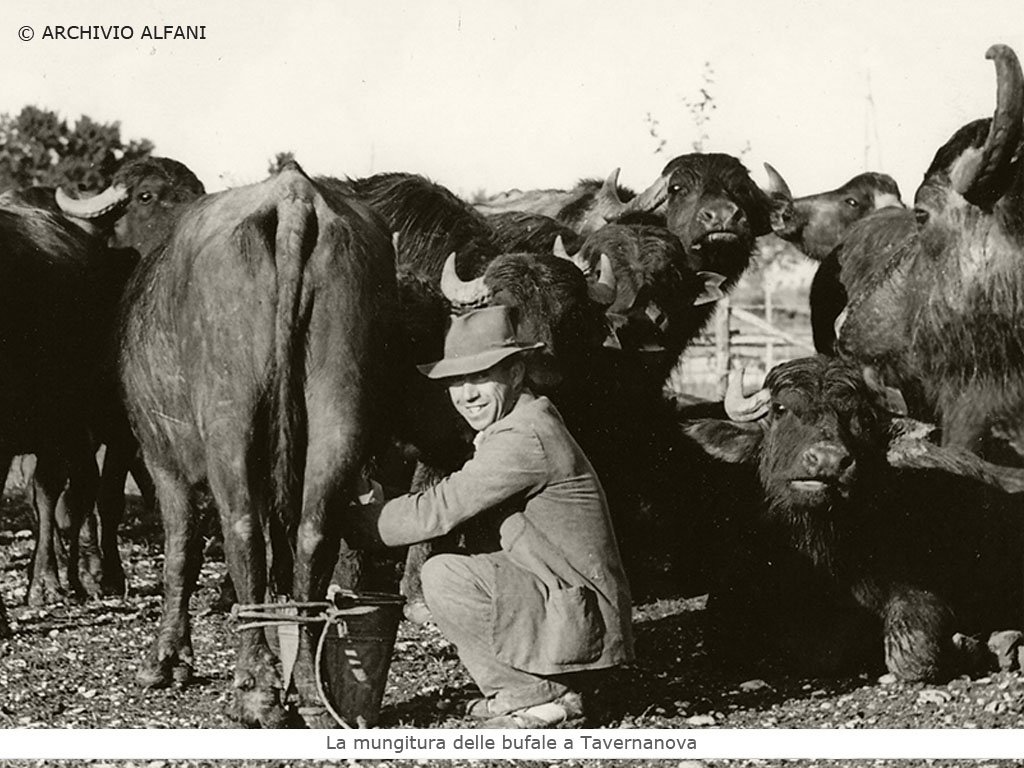convinte che la loro sopravvivenza futura, nonché la speranza di mantenere il livello di benessere finora goduto dalle loro popolazioni, dipendano in parte rilevante sia dallo sfruttamento delle risorse marine, sia da un maggiore coinvolgimento nelle attività del commercio marittimo.
La maggior parte dei governi, infatti, è giunta alla preoccupante conclusione che quanto è ricavabile dalla terra o dal sottosuolo non basta più a produrre reddito per il proprio Paese, e per questo si rivolgono al mare, come fonte di future ricchezze. Sintomatica è, a tal proposito, la dichiarazione, alcuni anni fa, da parte di un Presidente della Repubblica francese, che si meravigliava del “troppo lungo oblio della Francia sulla sua vocazione marittima”1 e aggiungeva che il Paese “doveva avere una volontà politica permanente per andare verso l’oceano, per proiettarvi un’ambizione”2
Questa corsa al mare, divenuta di recente un approccio comune
a molti governi, inclusa la Cina, spiega perché si sia verificata un’intensificazione dei contenziosi marittimi e un riarmo navale generalizzato, che ha coinvolto, tra l’altro anche
molte Nazioni rivierasche del Mediterraneo.
La situazione nel nostro bacino è oggettivamente difficile e, anche se non ha ancora dato luogo a conflitti aperti, non sono mancati momenti di tensione tra i vari Paesi. Basterà citare lo scontro tra un convoglio di navi turche, la Freedom Flotilla, con le forze speciali israeliane, il 31 maggio 2010 e, ancor prima, la dichiarazione del Parlamento turco, che nel 1995 approvò un documento che considerava casus belli ogni espansione delle acque territoriali greche, al di là delle 6 miglia marine.
Un tale crescente livello di contenzioso, frutto di questa maggiore attenzione alle ricchezze del mare comporta, per il nostro Paese, come e più del passato, la necessità di disporre di un “Potere Marittimo” per contenere tale conflittualità e far valere i propri diritti. Ma cosa vuol dire questo concetto? Per chi non lo ricordasse, già nel 1814 un illustre napoletano, Giulio Rocco, ne definì l’essenza, affermando che esso era “nell’ordine politico, una forza somma risultante da quella di una ben ordinata Marina Militare e di una numerosa Marina di Commercio”3.Vista con gli occhi di oggi, tale affermazione del nostro insigne conterraneo non è altro che un’applicazione all’ambiente marittimo del paradigma secondo il quale “la ricchezza è in genere necessaria per sostenere la potenza militare, così come la potenza militare è di solito necessaria per conquistare e proteggere la ricchezza”, ma possedere un “Potere Marittimo” richiede precisi requisiti, sia in campo militare, sia in quello commerciale, che non sono sempre disponibili.4�
Il Meridione è la parte della penisola italiana più vicina sia alle linee
del grande commercio marittimo internazionale, sia ai bacini alturieri
del Mediterraneo, dove le ricchezze dei fondali marini
sono più numerose, e pretese da molti.
È quindi necessario capire come il Meridione si collochi rispetto ai requisiti di marittimità, e cercare di stabilire quale possibilità esso abbia di sviluppare le proprie attività sul mare, che oggi, ancora più rispetto al passato, è diventato la fonte primaria di benessere per un popolo.
I requisiti che definiscono la marittimità furono analizzati, verso la fine
del XIX secolo, da uno studioso americano, Alfred Thayer Mahan,
il quale li chiamò “elementi del potere marittimo”. Sarà quindi
opportuno esaminare, per ognuno di essi, come si colloca
il nostro Meridione:
Posizione geografica
“se una nazione è situata in modo tale da non essere costretta a difendersi sulla terra né indotta a ricercare un aumento del proprio suolo sulla terra, è per la sua stessa unità d’intenti rivolti al mare, avvantaggiata rispetto a un’altra che abbia le sue frontiere sul continente”5. Se poi questa Nazione è posizionata lungo le principali rotte commerciali, lo studioso americano notava che il suo vantaggio geografico è ancora maggiore. A proposito del Mediterraneo, Mahan aggiungeva che “le circostanze hanno fatto sì che il Mare Mediterraneo abbia giocato nella storia del mondo una parte superiore a quella di qualsiasi altra estensione di mare della stessa dimensione”6. La posizione geografica del Meridione, che, con la Sicilia, taglia il bacino in due parti, potendo controllare i transiti tra queste, è quindi particolarmente favorevole, e notevole potrebbe essere di conseguenza la possibilità di sfruttare la posizione geografica per il proprio sviluppo. Basta, inoltre, uno sguardo alla carta geografica per vedere come, dal punto di vista marittimo, il Meridione si affacci su entrambi i bacini, con la costa adriatico-jonica che guarda verso il Levante, fino al Medio Oriente, e un’altra che guarda verso il Ponente, e quindi aperta ai commerci atlantici. Non vi è un’altra regione o Paese, nel Mediterraneo, che goda di tutti questi vantaggi, dal punto di vista geografico;
Conformazione fisica.
“La linea di costa di un Paese costituisce una delle sue frontiere e più facile è l’accesso alla regione al di là della frontiera, in questo caso il mare, maggiore sarà la tendenza di un popolo ad avere relazioni col resto del mondo per quella via. Se si potesse immaginare un Paese con una estesa linea di costa, ma interamente priva di porti, questo Paese non avrebbe, di per sé, alcun commercio marittimo, né naviglio, né Marina Militare”7. Qui sorgono alcuni problemi: il Meridione, con la sua limitata disponibilità di porti, alcuni dei quali sono ormai inadeguati a favorire il commercio, spesso per mancanza di manutenzione e di ammodernamento, è quindi fortemente svantaggiato sotto questo aspetto. La situazione dei porti turistici, i “Marina”, è in effetti migliore, anche se non ancora adeguata, per numero e capacità ad accogliere tutto il turismo marittimo che le bellezze dei nostri mari potrebbero attirare. Questo è un punto sul quale è necessario impegnarsi, se si vuole che il Meridione esca dal suo presente stato di sottosviluppo;
Estensione del territorio.
“Non è tanto il numero totale dei chilometri quadrati della superficie del Paese che deve essere considerato, quanto la lunghezza della sua linea di costa e le caratteristiche dei suoi porti. A questo riguardo occorre dire che, a parità di condizioni geografiche e fisiche, la lunghezza della linea di costa è fonte di potenza o di debolezza, a seconda che la popolazione sia più o meno numerosa”8. In teoria, quindi, con la sua costa estesa e piena di piccoli ridossi, il Meridione avrebbe tutte le caratteristiche per costituire un fattore propulsivo per incrementare la potenza economica e commerciale dell’Italia. In pratica, però, ci troviamo di fronte a un grande problema, triste retaggio della Storia, come vedremo tra breve;
Entità della popolazione.
“Per quanto riguarda la popolazione, non è solo il totale generale che deve essere computato, ma il numero di gente che prende il mare o, per lo meno, che è immediatamente disponibile per l’imbarco e per la costruzione di materiali navali”9. Purtroppo, nel Meridione, la specie umana nota come “homo maritimus” costituisce una netta minoranza, ancorché di rara qualità. Questo è dovuto sia ai secoli di dominazione straniera, sia alle minacce dal mare, che hanno indotto larghe fasce della nostra popolazione a emigrare verso l’interno del Paese: i bellissimi comuni, arroccati sulle montagne, che vediamo attraversando in auto il Meridione, non sono altro che una risposta a queste situazioni ingestibili, da parte di un popolo spesso lasciato indifeso, fino al XVIII secolo. Un altro grave problema, presentatosi negli ultimi decenni, è la progressiva decadenza della cantieristica meridionale, dato che in questo importante settore produttivo i responsabili delle decisioni economiche hanno a suo tempo deciso di spostare il baricentro della cantieristica al nord dell’Italia. Ciò ha reso il Meridione particolarmente debole sotto questo aspetto, facendogli perdere know-how e posti di lavoro;
Carattere nazionale.
“Se il potere marittimo è basato su un vasto e pacifico commercio, allora l’attitudine all’occupazione commerciale deve essere la caratteristica peculiare delle Nazioni che sono state, prima o poi, grandi sul mare”10. Ma il Mahan osservava anche che “le classi nobili d’Europa ereditarono dal Medioevo un arrogante disprezzo per il pacifico commercio, un disprezzo che ha esercitato un’influenza modificatrice nel progresso di queste, a seconda del carattere nazionale di questi Paesi”11. Questa osservazione si attaglia, in modo particolare, al Meridione: anche dopo la scomparsa della nobiltà come classe dirigente, le attività commerciali vengono sia sistematicamente oppresse dalla criminalità organizzata, sia considerate di livello inferiore rispetto ad altre professioni, specie quelle del terziario. Nel Meridione il senso di legalità è un patrimonio di meno della metà della popolazione e la criminalità organizzata, che prospera solo in ambienti dove l’illegalità è tollerata, può quindi opprimere le attività produttive e commerciali, impedendo lo sviluppo delle nostre terre e incrementando la disoccupazione;
Carattere del governo.
“La condotta del governo corrisponde all’esercizio di una volontà intelligente che, a seconda che sia saggia, energica e perseverante oppure no, causa successo o fallimento nella vita di un uomo o nella storia di una Nazione. (A tal proposito) i più grandi e brillanti successi si sono avuti quando vi è stato un intelligente indirizzo da parte di un governo interamente impregnato dello spirito del popolo e consapevole delle sue genuine inclinazioni”12. Quanto i governi regionali del Meridione siano determinati a far sì che il nostro Sud possa godere di uno sviluppo duraturo grazie alle attività marittime, è una domanda che è lecito porsi
In effetti, qualcosa è stato fatto, ma con una popolazione in gran parte lontana dal mare, com’è stata per secoli quella del Meridione, molto c’è ancora da fare per invertire la tendenza.
Come si può notare dalle considerazioni finora elencate, esistono notevoli impedimenti a uno sviluppo della marittimità del Meridione, malgrado l’enorme potenziale, essenzialmente geografico, che la favorisce.
In buona sostanza, le azioni necessarie, per colmare il divario esistente, rispetto alle potenzialità in campo marittimo del Meridione,
sono, in ordine di importanza:
Educare e abituare alla vita di mare una maggiore aliquota
della nostra popolazione.
Molti encomiabili sforzi sono stati fatti da parte di Associazioni, come la Lega Navale, ma è necessario che tali sforzi vengano non solo incoraggiati, ma anche integrati da un’azione ben più energica da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Portare una popolazione verso il mare richiede anche una propaganda capillare per convincere l’opinione pubblica del Meridione che il mare non è più un pericolo, ma un’enorme opportunità;
Migliorare i porti.
Questo è un problema generale dei Paesi del Mediterraneo. Osservava, a tal proposito, l’intellettuale francese, Jacques Attali, che “i porti maggiori di questo mare sono al quarantesimo o al cinquantesimo posto nel mondo, (e) scadono annualmente in tale classifica”13. Un’azione decisa in tal senso, quindi, porterebbe al Meridione un benessere notevole, come mostra lo sviluppo di Gioia Tauro, che è diventato – rara avis – uno dei porti maggiori del bacino;
Incentivare la cantieristica meridionale, la cui decadenza
ha raggiunto un livello preoccupante.
Se è vero che la concorrenza dei Paesi asiatici è forte in questo campo, è altrettanto vero che le costruzioni navali di alta qualità e prestazioni sono un settore strategico, dove ben pochi Paesi possono competere con le qualità di noi meridionali in fatto di ingegno e di progettazione;
Dare un ulteriore impulso alle attività turistiche sul mare.
Chi sia andato sulla Costa Azzurra, da Nizza fino a Tolone, può vedere quanto indietro siamo noi meridionali, in questo campo. Con le coste e isole che abbiamo, potremmo più che raddoppiare le presenze di turisti e appassionati del mare. Servono più porti e più servizi, che generano indotto e occupazione.
A monte di tutto, però, deve esserci una maggiore consapevolezza che non vi è sviluppo senza legalità. Proprio il settore dell’economia marittima è quello che necessita, come e più di altri, di legalità e di trasparenza.
Se la maggioranza della nostra popolazione non si convince
che le attività economiche vanno protette dall’illegalità, dalla
corruzione e dalla criminalità, nulla potrà consentire
lo sviluppo di un “meridione Marinaro”.
Infatti, non ci vuole molto per perdere questa occasione di sviluppare le attività sul mare e altri Paesi, pur meno dotati del nostro Meridione, sarebbero ben felici di toglierci fette importanti di benessere in questo settore. Il rischio è quello di rassegnarci a vedere gli altri prosperare sul mare e, al massimo, “servire loro il caffè”!
In definitiva, non ci si può limitare a vedere i futuri perni dell’economia del Meridione né nel turismo in genere né nella manifattura di prodotti di basso valore aggiunto, come si è pensato di fare. Una decisa sterzata verso l’eccellenza in campo marittimo, in tutti i settori di attività, è necessaria se si vuole stimolare uno sviluppo bilanciato e durevole del Meridione.