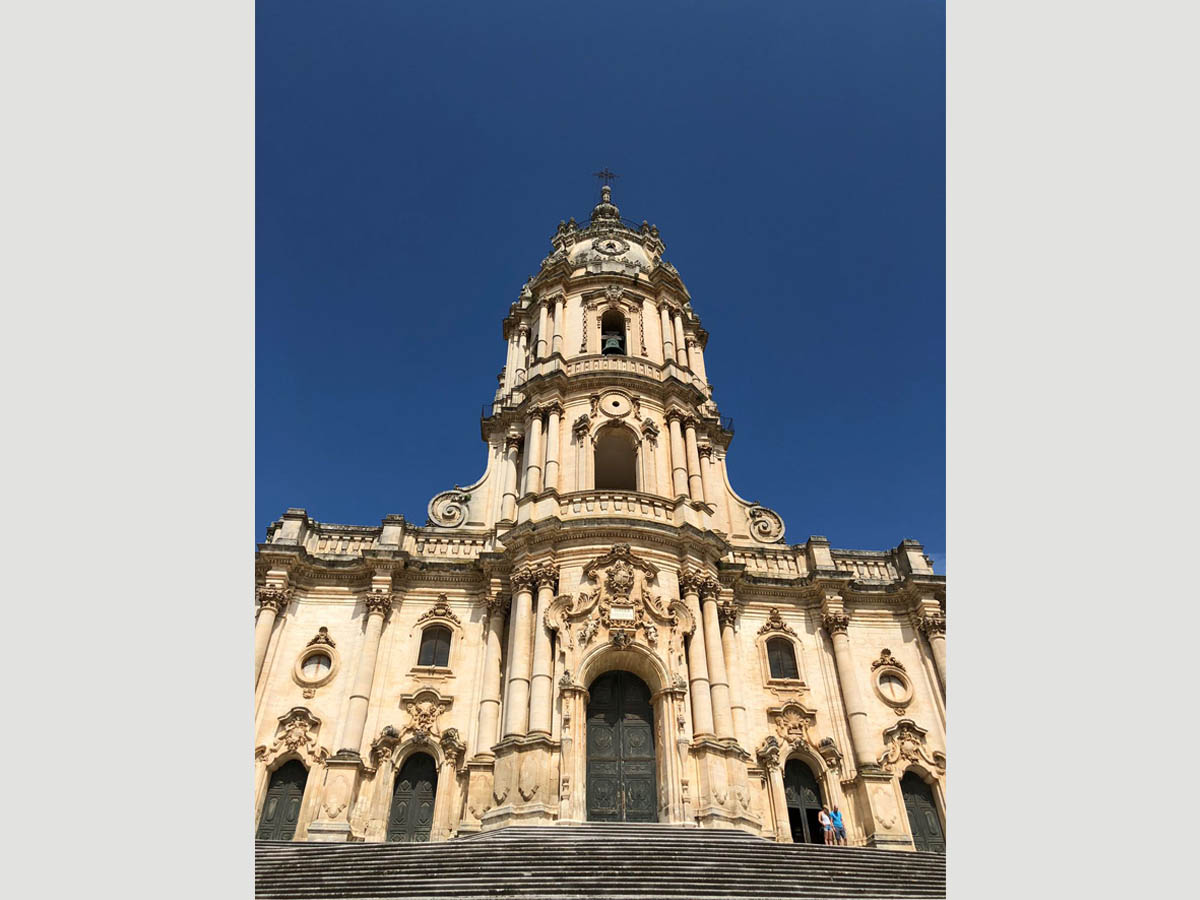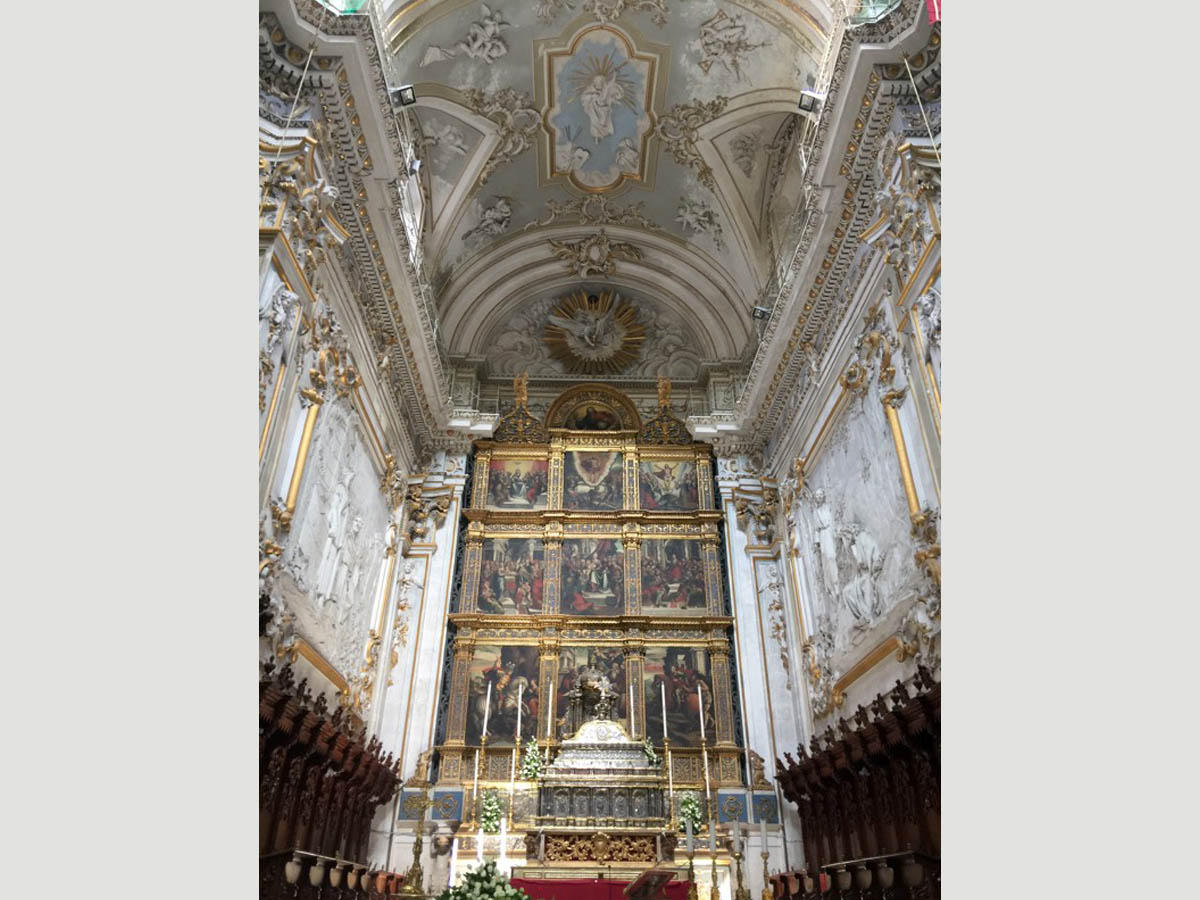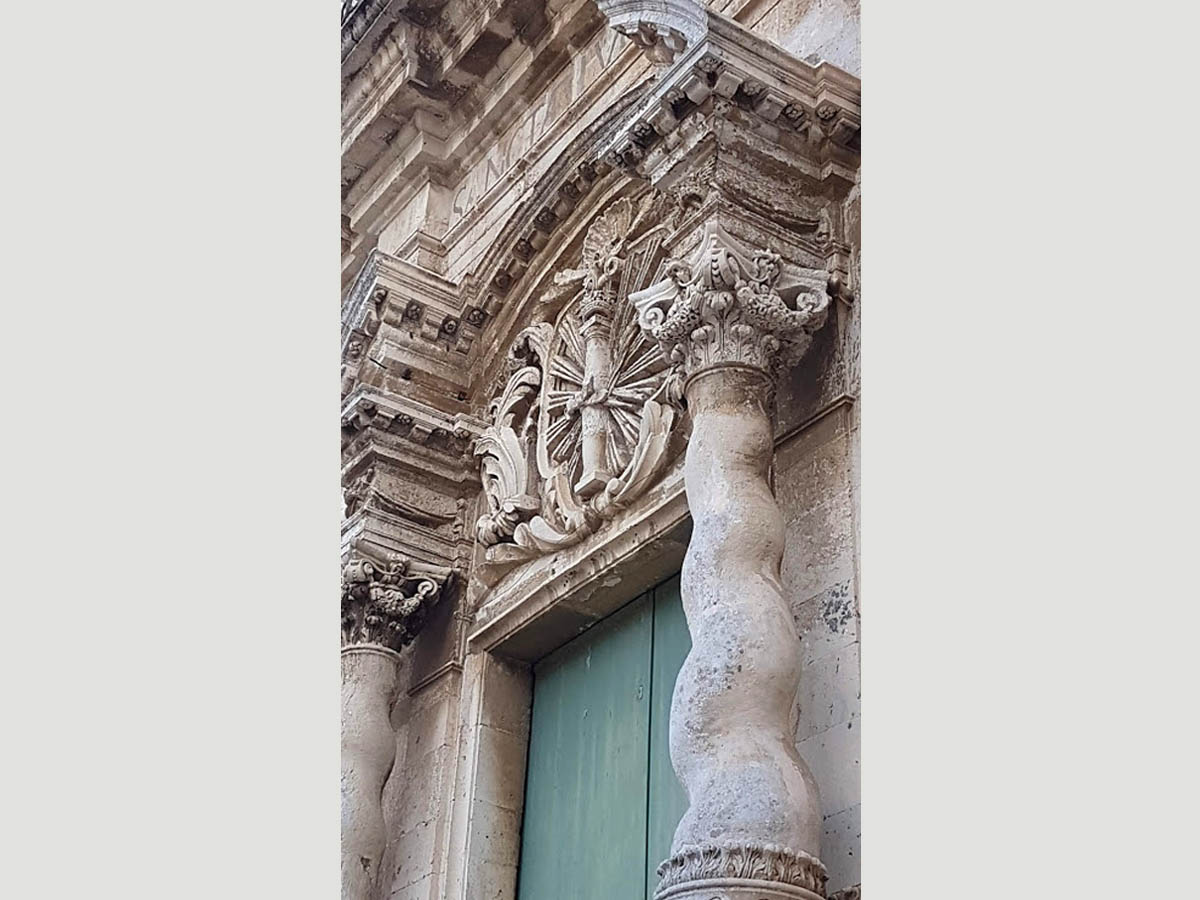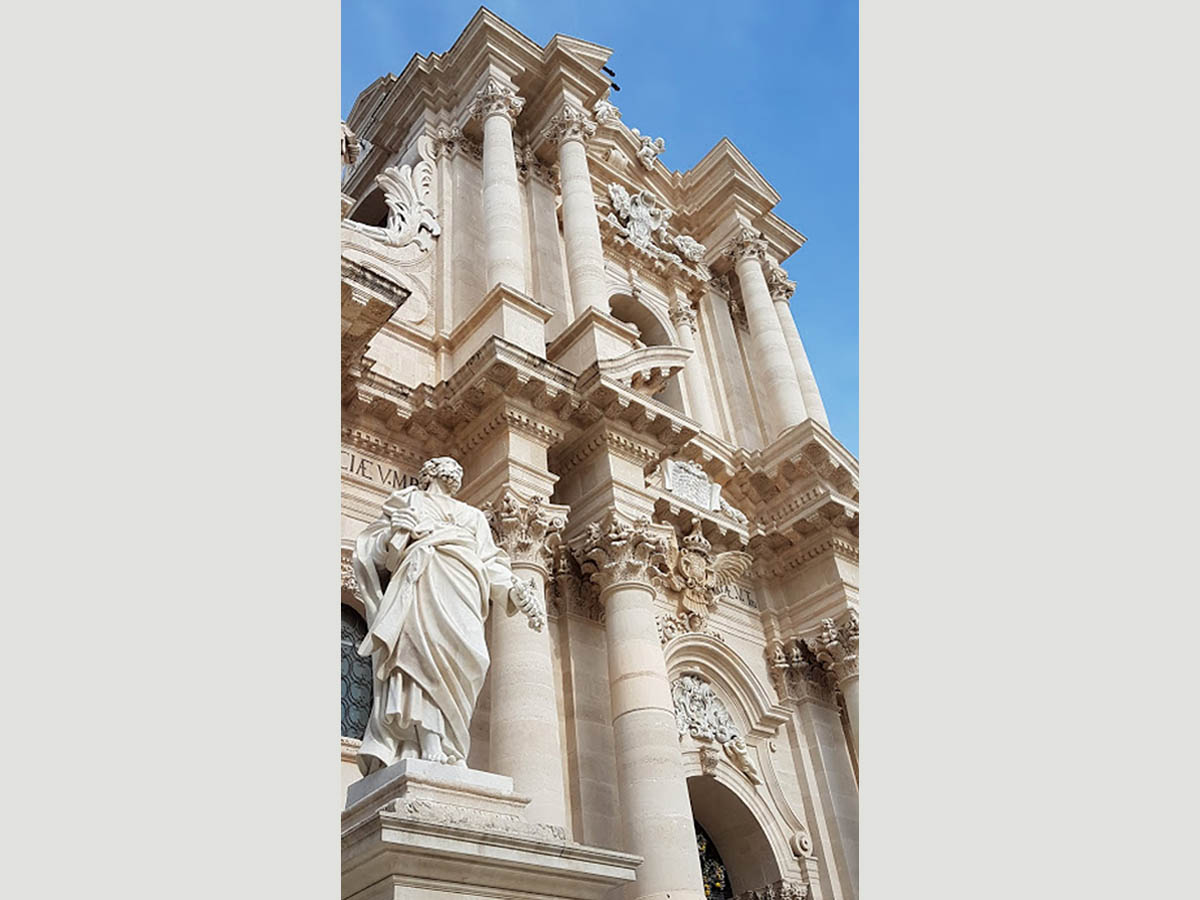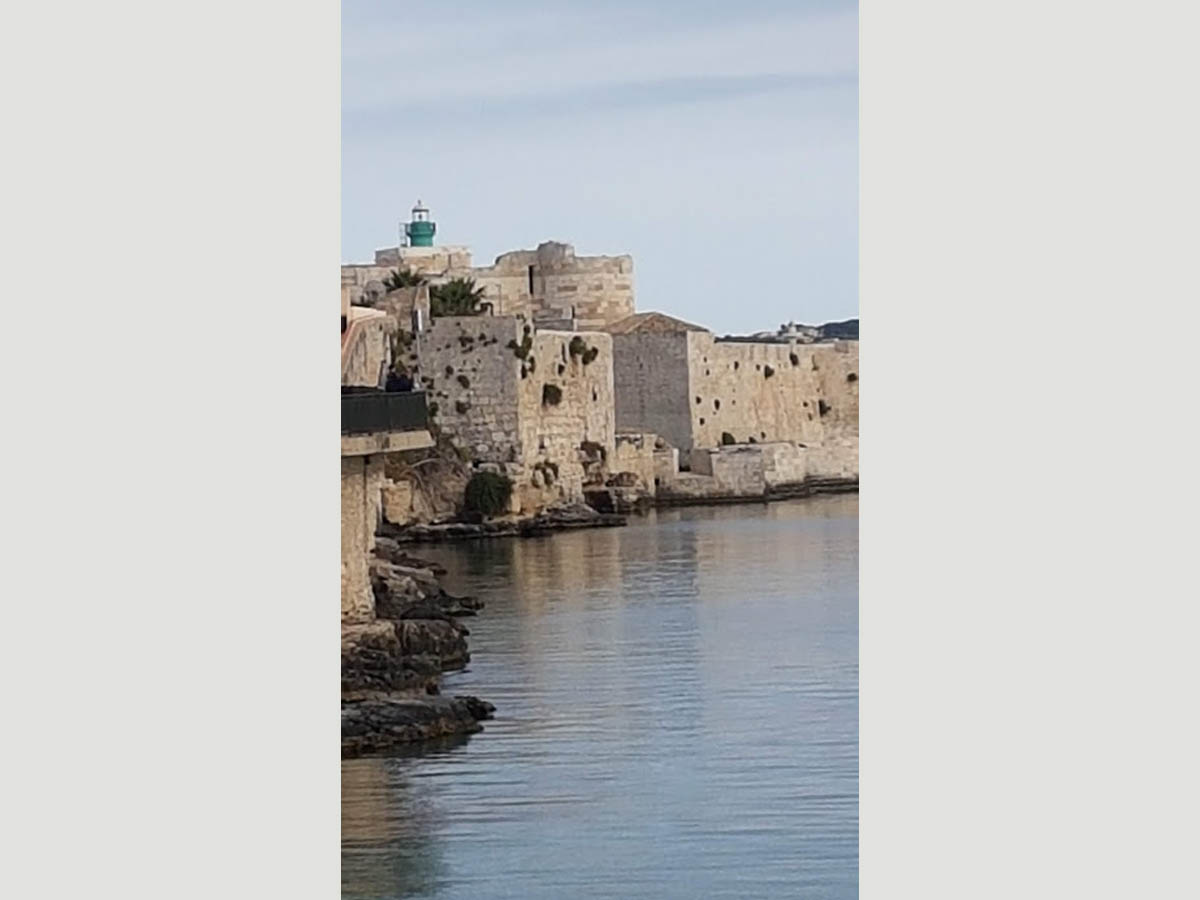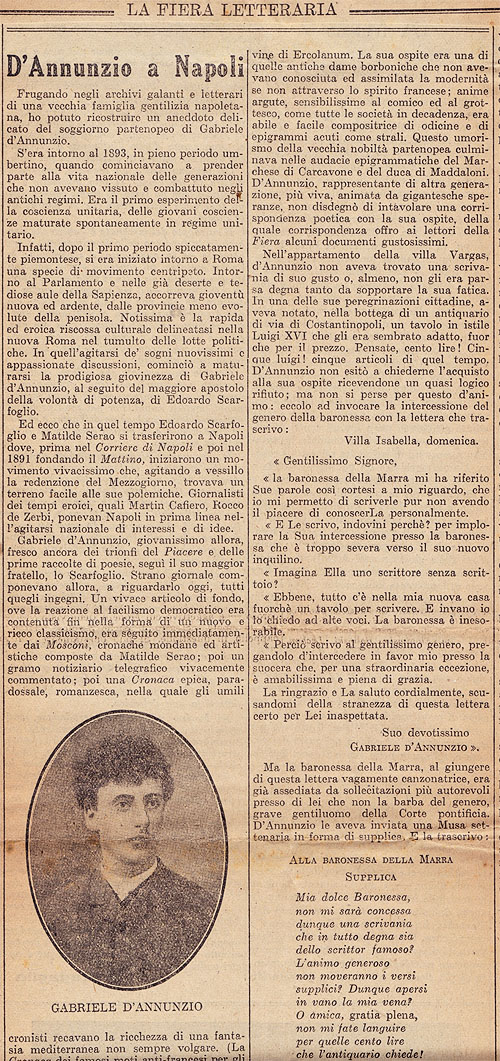VIA MARINA DI REGGIO CALABRIA
La bellezza e la suggestione di quel tratto di costa che si affaccia sullo Stretto di Reggio e Messina avrebbe potuto certamente evocare, nel poeta-soldato, l’espressione di apprezzamento che gli viene attribuita. C’è, però, un elemento che va considerato e sul quale non risulta che gli osservatori più attenti della storia di Reggio Calabria di quel periodo si siano interrogati: D’Annunzio non sarebbe mai stato a Reggio dopo la realizzazione del Lungomare.
Eppure, più volte fu invitato e, certamente, lo fece l’On. Giuseppe Valentino considerato l’ideatore di quel chilometro che tanta suggestione riesce ad evocare e che si caratterizza come momento architettonico e panoramico più significativo e struggente della città calabrese.
La costruzione del Lungomare, così come oggi lo si può ammirare in luogo
della struttura preesistente – l’antica Via Terme, di poco più a monte
della vecchia Via Marina con la quale poi si confondeva,
è frutto dell’appassionata intuizione di Valentino che realizza così la straordinaria terrazza lunga un kilometro dalla quale si può ammirare, in tutta la sua sfolgorante bellezza, il panorama dello Stretto di Reggio e Messina: un dono di Dio alle due città che si affacciano su quel tratto di mare perché quella bellezza resti immutabile laddove gli uomini, nel corso dei secoli, si sono “sbizzarriti” per turbare le armonie della natura. E fu questo sforzo teso ad individuare la soluzione che meglio potesse valorizzare quel luogo incantevole che Giuseppe Valentino riesce ad esprimere in maniera mirabile in un libro di memorie scritto venticinque anni dopo il sisma che aveva distrutto la sua città.
Qui le stesse parole di Valentino riescono a rendere in maniera palpabile e suggestiva come la sua elaborazione intelligente abbia consentito la soluzione più funzionale e più coerente con le esigenze di eleganza e grandiosità che dovevano caratterizzare quella realizzazione.
Il problema da affrontare era l’area scoscesa su cui sarebbe dovuta sorgere
la passeggiata e, quindi, quali soluzioni adottare per attenuare le pendenze
e nello stesso tempo dare un’idea di ampiezza che conferisse
grande dignità al lungomare.
Val la pena riproporre testualmente alcune espressioni del libro di Valentino che in maniera semplice e suggestiva nel contempo, riescono a rendere l’idea di come lo sforzo di edificare esaltando al massimo l’opera sotto il profilo estetico venne anche alimentato dalla comparazione con luoghi d’Europa noti per la loro eleganza e bellezza. Scriveva Valentino: «nelle ansie della ricerca mi parve di ricordare, non so bene, se nei giardini di Montecarlo od altrove, delle aiuole in pendio, (quando il mio cervello si stillava in questi problemi … estetici la città era un groviglio di macerie e la mia casetta di Via Tribunali era immersa nel buio e nello squallore!) ed allora mi balenò la soluzione: “e se dessi a tutta la zona di giardinaggio, che separa le due strade, quel dolce declivio che basti a superare il dislivello?” Eureka! Mi fermai su questa idea che mi parve una trovata, pur continuando nella mia mente a fare un confronto colla Via Marina di San Remo, coll’Ardenza di Livorno con la proménade des Anglais di Nizza, le quali sono tutte piatte, senza dislivelli, e credetti il mio ripiego della pendenza degradante sarebbe stata un’originalità presumibilmente di bello effetto, e di movimentata eleganza, sia per coloro che guardino la strada dalle varie parti della città, sia per coloro ed ancora meglio, che la guardino dalla parte del mare».
Così nacque la Via Marina: il più bel chilometro d’Italia a prescindere
che lo abbia detto o meno d’Annunzio ovvero un incantato,
ignoto osservatore di quella meraviglia.
Quando a distanza di anni il degrado si stava impadronendo di quell’angolo di Paradiso, Italo Falcomatà – sindaco che amava la sua città – si adoperò per recuperare questo sito incantevole e – grazie agli strumenti della modernità – riuscì a coprire l’attigua strada ferrata con la realizzazione di un tunnel che ha consentito l’ampliamento della passeggiata, incorniciata dalla splendida ringhiera disegnata da Camillo Autore che di Valentino era amico ed estimatore.
Questo merito di Falcomatà è stato riconosciuto e la parte della via Marina posta a ridosso della spiaggia porta il suo nome. A Valentino che ideò il più bel chilometro d’Italia, lo realizzo tra mille difficoltà, rischiando talvolta il patrimonio avito, è dedicata soltanto una colonna romana, all’inizio del Lungomare, dove una piccola targa ne ricorda l’opera. Ma nella considerazione dei Reggini, nonostante il tempo trascorso dagli eventi che determinarono la costruzione di questa opera straordinaria, Egli resta il “Sindaco della Ricostruzione”.
La stampa ne parla ogni qualvolta v’è motivo di ricordare questi anni intensi
ed appassionati della ricostruzione di Reggio,
nelle Università gli studenti hanno scritto tesi di laurea sulla sua opera, i paragoni si succedono fatalmente nel corso degli anni rispetto ad altri Amministratori che hanno brillato… per non aver fatto nulla in una città che, ancor oggi, ha bisogno di molto.
Questo ricordo grato, che sopravvive al tempo che passa, è motivo di orgoglio e gratificazione per coloro che oggi portano il suo nome e sanno che l’impegno e l’amore per Reggio è l’irrinunciabile patrimonio morale che Egli ha lasciato..